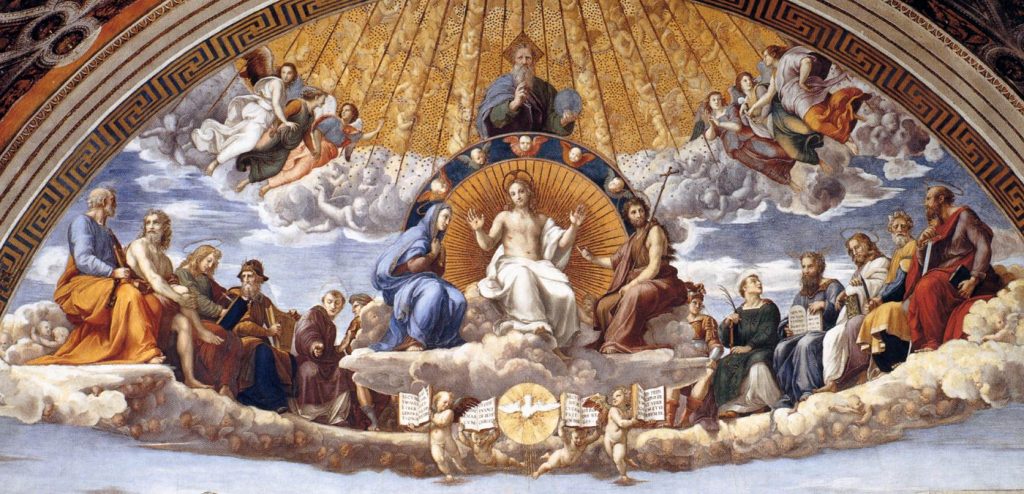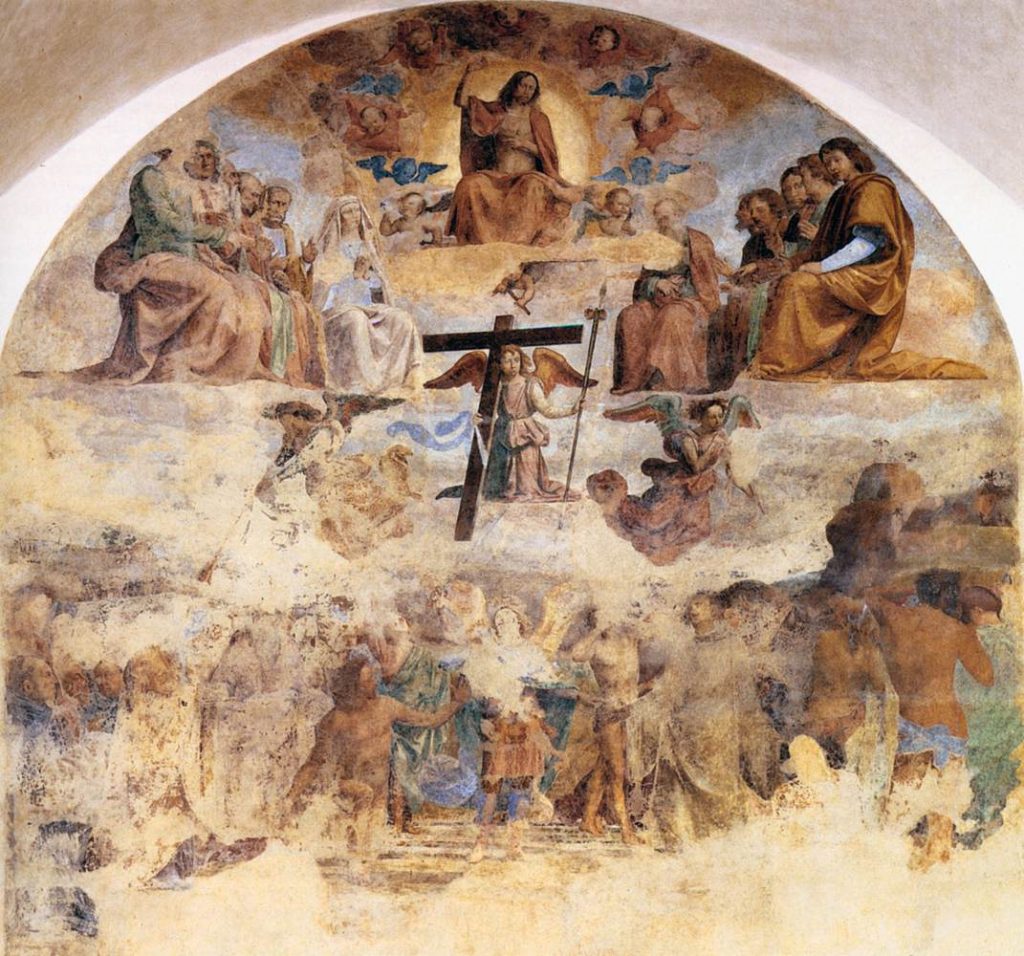LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’ANIMA A ROMA
A cura di Andrea Bardi
Storia di Santa Maria dell'Anima
La vicenda storica della chiesa di Santa Maria dell’Anima, attuale sede del Pontificio Istituto Teutonico nei pressi di piazza Navona, vuole come cornice il fenomeno tutto romano delle chiese nazionali. Epicentro di un costante flusso di pellegrini da tutto il continente, l’Urbe vide sorgere, al calar del Medioevo, una serie di istituti di assistenza specificatamente legati a comunità nazionali. Sebbene il concetto di natio non corrispondesse totalmente con quella che è la sua accezione moderna (alcuni degli allora “stati nazionali” oggi sono realtà politiche regionali), la convergenza di determinati elementi (provenienza geografica, comunanza linguistica e adesione a un insieme di pratiche identitarie) forniva spesso e volentieri lo stimolo iniziale alla costruzione di veri e propri spazi fisici comunitari. Fu in questo clima che il mercante olandese Johannes Peters di Dordrecht, giunto a Roma da membro della guarnigione militare pontificia, decise di acquistare tre case nel Rione Parione, per poi riqualificarle come ospizio per tutti i pellegrini provenienti dalla natio Almanorum: era il 1390, e si celebrava il terzo Anno Santo nella storia della Chiesa. Mancando l’unità nazionale, e di conseguenza un santo patrono (La Spagna aveva S. Giacomo, la Francia S. Luigi), l’ospizio si affidò al patronato di Santa Maria dell’Anima, protettrice dei bisognosi. Neanche due decenni dopo, quello che nacque come istituto assistenziale si sganciò definitivamente dall’amministrazione romana. Poco prima di morire (1406) papa Innocenzo VII Migliorati pose l’ospizio sotto il patrocinio diretto della Curia Romana. L’ospizio, intanto, si era trasformato, grazie all’azione di Dietrich von Niem, in una vera e propria confraternita, della quale egli assunse l’incarico di primo provisor (provveditore), termine con il quale verranno indicati tutti i successivi soprintendenti dell’Anima di lì a venire. La crescita esponenziale della comunità tedesca a Roma rese necessaria la demolizione dell’ospizio (1431-1433) e il suo successivo trasferimento. Negli ambienti originari venne invece innalzata una chiesa gotica a tre navate. Eugenio IV, promotore dell’iniziativa, volle una chiesa a tre navate e sei cappelle laterali (tre per lato). La sua partenza per Firenze, nei primi anni Quaranta, non fermò la confraternita, che in assenza del papa provvide da sola al completamento dell’edificio (1446). Nulla rimane, purtroppo, della prima fondazione quattrocentesca, ricostruita pochi decenni dopo, ancora con un Giubileo a fare da volano per un ulteriore rinnovamento delle strutture. È del 24 settembre del 1499, infatti, il documento di delibera della confraternita, all’interno del quale le intenzioni dell’Anima apparivano chiare. La nazione tedesca avrebbe dovuto primeggiare nel confronto con le altre nazioni, e per farlo avrebbe puntato sulle specificità linguistiche della sua architettura. Una chiesa spiccatamente tedesca (“Alamannico more compositum”, così recitano le carte), che potesse gareggiare con la vicina, e recentemente rinnovata nel suo paramento frontale, chiesa di San Giacomo degli Spagnoli. Erigere una chiesa “tedesca” significava in primis portare l’alzato delle navi laterali alla stessa altezza di quella principale, secondo il modello della “chiesa a sala” (Hallenkirche) nordica. In secondo luogo, anche le maestranze impiegate nella costruzione dovevano essere tedesche. L’allora soprintendente dei lavori, il maestro di cerimonie pontificio Johannes Burckard – provveditore dell’Anima dal 1494 – prese a cuore il progetto “tedesco” della fondazione, anche se la sua visione dovette collassare con il desiderio della confraternita di aggiornarsi su dettami squisitamente rinascimentali e “italiani”. Desiderio reso possibile dalla consulenza chiesta a Donato Bramante, allora impegnato anche sul fronte “nemico” della corona iberica, in un episodio citato anche da Giorgio Vasari nella Vita del maestro urbinate:
“Trovossi al consiglio dello accrescimento di San Iacopo degli Spagnuoli in Navona e parimente alla deliberazione di Santa Maria de Anima, fatta condurre poi da uno architetto todesco”
L’identità di questo “architetto todesco”, tuttavia, ancora non è stata svelata. L’unico nome attestato dai documenti di pagamento, infatti, è quello del fiesolano Bartolomeo Lante, connesso anche lui a Bramante per aver collaborato con il maestro nella vicina S. Maria della Pace[1]. Con l’Anno Santo l’Anima ottenne la licenza di demolizione dell’edificio (21 febbraio 1500) e provvide alla posa della prima pietra (11 aprile) riservata al legato imperiale Matthias Scheidt come atto di rinsaldamento del legame tra confraternita e Sacro Romano Impero. Dieci anni dopo, sotto il rettorato di Willem von Enckenvoirt – braccio destro di papa Adriano VI (1521-1523) – venne consacrata la zona presbiteriale; dopo altrettanti anni, venne completato anche il campanile gotico (1520), elemento marcatamente “tedesco” della struttura nei rivestimenti cuspidali a maioliche colorate. Il completamento dell’edificio avvenne nel 1523, mentre per la consacrazione vera e propria della chiesa si dovette aspettare il novembre del 1542. A quella data, tuttavia, anche le decorazioni erano ben lungi dall’essere ultimate (è del 1541 il primo intervento di Francesco Salviati nella cappella del Margravio di Brandeburgo), e ciò dovette avvenire, in sostanza, per scarsa disponibilità economica. Differentemente dalle altre chiese nazionali, alle quali era costantemente garantita la disponibilità delle casse statali, l’Anima si reggeva su donazioni private, su iniezioni di liquidità da parte della banca Fugger e sui proventi delle indulgenze. Fu proprio in riferimento a una delle questioni più spinose sollevate da Lutero che l’Anima manifestò il suo silenzioso clamore antiprotestante. L’affidamento del patronato di una delle cappelle al Margravio Albrecht di Brandeburgo, strenuo difensore del commercio della salvezza, valse da solo come la più netta presa di posizione che la chiesa cattolica potesse mai auspicarsi in quel delicato momento storico. La chiesa mantenne il ruolo di avamposto cattolico romano anche a Concilio ultimato (1563), con l’edificazione della tomba del duca di Julich-Kleve-Berg[2] e, nel Seicento, con la definizione del programma iconografico delle cappelle di San Benno e di San Lamberto. Ancora tra Cinque e Seicento, la chiesa (a cui dal XV secolo era stato concesso il privilegio della sepoltura in loco) divenne il luogo prescelto da numerosi patrizi provenienti dai paesi cattolici del nord Europa. Inoltrandosi nel secolo, tra il 1635 e il 1644 vennero conclusi i lavori anche nella sagrestia, su progetto di Paolo Maruscelli. Attorno alla metà del Settecento (1749), invece, gli interventi in stile barocco di Paolo Posi ampliarono il coro, che venne rivestito di preziosi stucchi dorati. Le pareti laterali del presbiterio vennero profondamente modificate nel loro assetto originario, tramite la ricollocazione di alcuni gruppi scultorei (la tomba di Andrea d’Austria subì lo spostamento in controfacciata, mentre al suo posto venne collocato il monumento al duca Karl Friedrich). Un secolo più tardi (1874-1875) la chiesa assunse gli sfarzi che le tinte neorinascimentali di Emilio Stramucci e Ludwig Seitz (pittore tedesco allievo del Nazareno[3] Friedrich Overbeck) intendevano dare alla volta, alle finestre, al coro e alla navata principale (nonché alle tribune dell’organo, progettate dall’architetto Luca Carimini). L’ultimo intervento decorativo sulla chiesa, interessata recentemente anche da un’importante campagna di restauro (terminata nel 2014) è stato patrocinato dall’attuale rettore Franz Xaver Brandmayr, che ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’austriaco Johann Weyringer.
Descrizione
Esterno: La facciata
L’attuale spartito architettonico del fronte dell’Anima risponde alla configurazione da essa assunta in occasione del terzo e ultimo intervento di ricostruzione, fortemente promosso dalla confraternita all’approssimarsi del Giubileo del 1500[4]. Il nuovo profilo rettangolare, al limite del quadrato perfetto, doveva parlare una lingua ben diversa da quell’alamannico more inizialmente auspicato da Burckard e dai confratelli stessi. Il dirottamento dello sforzo produttivo in direzione di un linguaggio più asciutto, solenne e “italiano”, è testimoniato dall’affidamento di alcuni lavori a Bartolomeo Lante[5] in luogo di mastri nordici (impiegati anche dal Burckard per la sua casa romana) nonché dalla presenza di elementi sangalleschi nella morfologia dei basamenti[6] e dei capitelli. La facciata attuale [fig. 1], terminata nel 1514, si offre allo spettatore come un grande corpo in mattoni rossi e pietra chiara[7] suddiviso in tre ordini.
Il primo, delimitato in tutti e due gli angoli da un doppio partito di paraste corinzie, accoglie tre aperture timpanate. Il portale principale, inquadrato anch’esso da due paraste corinzie, custodisce tra gli spioventi del timpano triangolare il gruppo scultoreo con la Madonna delle Anime, attribuito a Bartolomeo Lante e completato attorno al 1538 [fig. 2]. Le terminazioni timpanate ai lati, invece, rispettano un profilo lunettato. Pressando delicatamente gli acanti dei capitelli, l’iscrizione dedicataria (TEMPLUM BEATE MARIE DE ANIMA HOSPITALIS TEUTONICORUM MCXIII) è protetta da una trabeazione dentellata in leggero aggetto. Lo spartito architettonico ha ritmo analogo anche nei due ordini superiori: mentre nel secondo le paraste, in luogo dei portali, definiscono lo spazio d’esistenza di tre grandi finestre ad arco, nell’ultimo l’oculus centrale è accostato a due rilievi: allo stemma di Massimiliano I d’Asburgo (sulla sinistra) si accompagna l’insegna dell’ivi sepolto papa Adriano VI (sulla destra). La partitura esterna della facciata, tuttavia, non coincide con l’organizzazione degli spazi interni, andando a negare così una tendenza assai generalizzata nella progettazione architettonica dell’epoca.
Le tre navate, portate alla stessa altezza secondo il modello tedesco delle Hallenkirchen, superano di gran lunga il primo ordine esterno. La questione della corrispondenza tra esterno e interno, rintracciabile anche nella coeva facciata di San Giacomo degli Spagnoli (oggi Nostra Signora del Sacro Cuore), ha condotto alcuni studiosi, come Renata Samperi, a formulare ipotesi circa l’aspetto originario del prospetto. Una soluzione interessante, nota la studiosa, potrebbe essere fornita da una variazione sul tema della forma basilicale. Variazione tutta sangallesca[8] giocata sull’introduzione, tra i due ordini, di un attico mediano. Le ipotesi formulate dalla Samperi, così come da altri studiosi, permettono quantomeno di tentare l’individuazione, se non di un nome preciso, quantomeno di un ambito culturale ben definito, ovvero quello dell’universo bramantesco-sangallesco. Ai nomi dei due maestri, tuttavia, se ne affianca un altro, ancora in via congetturale, per la progettazione degli ambienti della volta: Andrea Sansovino.
Esterno: il campanile
Risalente al 1520, il campanile di Santa Maria dell’Anima presenta una conformazione nettamente “tedesca” rispetto al corpo di fabbrica principale. Modificato in corso d’opera il progetto iniziale della chiesa, esso si presenta come il marchio di fabbrica, come l’unico elemento veramente gotico individuabile nel complesso [fig. 3]. Il motivo per cui una tale dovizia di lemmi gotici sia andata concentrandosi soprattutto nella torre campanaria è presto detto: essendo la chiesa oscurata da un filario di abitazioni che divideva l’allora Via Millina (oggi Via di S. Maria dell’Anima) da piazza Navona, l’unico elemento che potesse svettare tra i caseggiati prospicienti la facciata era proprio il campanile. L’alzato del paramento murario in mattoni rossi si divide in due ordini. Il primo è costituito da una semplice monofora cieca a tutto sesto. Il secondo, partendo dall’alto, è chiuso su ogni faccia da paraste ioniche binate che stringono al loro interno una bifora a tutto sesto. L’estremità finale della torre vede infine la presenza della monumentale guglia rivestita a maioliche policrome protetta in basso da quattro timpani ad arcata cieca polilobata.
L’interno
Cronologia
Il nome di Andrea Sansovino gravita attorno alle questioni relative alla progettazione della volta del coro. I pagamenti dal 1504 menzionano infatti un certo “maestro Andrea fiorentino”, contattato per ultimare proprio le volte del coro, i cui spazi vennero realizzati a partire dal maggio di quell’anno. Gli ambienti del coro, consacrati nel novembre 1510, furono i primi in ordine di esecuzione dopo i partimenti esterni del corpo. Partimenti che definirono la chiesa nel suo curioso profilo trapezoidale. L’occupazione di suolo pubblico concessa alla confraternita nel 1500, infatti, venne sfruttata appieno dall’architetto, il quale profittò della situazione per allargarsi in direzione del Vicolo della Pace, ottenendo così anche l’effetto di regolarizzare l’assetto viario del Rione[9]. Portata a termine la fabbrica del coro, nel 1515 il nuovo provveditore Willem von Enckenvoirt si occupò della direzione dei lavori nella parte centrale del corpo e nelle cappelle laterali (1516). Facendo fede alla delibera iniziale, la nuova chiesa avrebbe dovuto munirsi di un corpo longitudinale a tre navate con ben dodici incavi laterali. Ad oggi, invece, l’Anima conta solo otto cappelle gentilizie, e non dodici: tuttavia, il motivo di tale ridimensionamento è ancora oscuro agli studi. In ogni caso, la fabbrica dell’Anima si chiuse nel 1523; prima di essere consacrata, tuttavia, passarono quasi vent’anni. La cerimonia solenne venne celebrata, infatti, solo il 25 novembre del 1542.
Gli spazi
Le navate e la volta
Le navi dell’Anima, portate alla stessa altezza già in fase progettuale secondo il modello delle Hallenkirchen nordiche, devono il loro attuale splendore agli interventi condotti su di esse negli anni Settanta dell’Ottocento [fig. 4].
Sulle crociere delle volte fu impegnato l’allora trentenne Ludwig Seitz (1844-1908). Le volte, i cui stucchi dorati ribadiscono le antiche linee di forza dei costoloni, vennero ricoperte a fresco dai sigilli di sei principati elettorali del Reich (eccezion fatta per la Boemia), affiancandoli, sulle vele risultanti, a ritratti di santi tedeschi. Sulle navi laterali, la costante presenza dei marchi Fugger e von Enckenvoirt – nonché di quello della Confraternita – ricorda agli astanti i passati fasti dell’Anima. Le crociere a loro volta insistono su pilastroni compositi con paraste corinzie addossate. Le basi dei pilastri, a loro volta, contengono iscrizioni commemorative dei numerosi defunti ivi sepolti dalla seconda metà del Cinquecento.
Controfacciata: tombe e vetrate
Insieme alle cappelle gentilizie che occupano le navate laterali della chiesa, un primo momento di iconografia controriformata è offerto al visitatore dalle due tombe che fiancheggiano il portale d’accesso. Entrando nella chiesa, sulla destra troviamo la Tomba di Andrea d’Austria [fig. 5]. Opera dello scultore Gillis van Vliete, è inquadrata da colonne corinzie e sormontata da un timpano spezzato. Il defunto cardinale, morto nel 1600, è colto nell’atto di pregare, alle spalle un rilievo con l’Ascensione. La collocazione attuale del complesso funerario di Andrea non corrisponde al suo posizionamento originario. Inizialmente, infatti, doveva ornare le pareti laterali del coro, da cui venne spostato solo nel 1751. Separata dal portone principale, un’altra tomba, quella dei cardinale Willem von Enckenvoirt [fig. 5], anch’essa destinata al presbiterio. Morto nel 1534, affidò l’esecuzione dei lavori a Giovanni Mangone, che completò la struttura nel 1538. Inquadrato da due colonne corinzie, il catafalco del cardinale poggia, alle sue estremità, su due aquile. Il corpo del defunto, sdraiato poggiando il gomito destro su di un cuscino e la mano sulla testa, precede una lastra a rilievo con Dio Benedicente.
Ad un periodo decisamente successivo risale la Madonna delle Anime dipinta sulla vetrata centrale [fig. 6]. Eseguita da Ludwig Seitz, comprende, nella sua sezione centrale, la Vergine in trono con Bambino[10] il cui volto è valorizzato dall’emiciclo superiore della nicchia in cui si inserisce. Due angeli, riccamente abbigliati, rivolgono il loro sguardo a due figure vestite solo con un perizoma: sono le anime a cui la Vergine offre protezione. In basso al centro, l’aquila bicipite della casata d’Asburgo. Ai lati della finestra, l’ultimo intervento di Johann Weyringer (2013-2019) comprende i rilievi in vetro dell’Arcangelo Michele e di un Angelo con tromba.
Le cappelle laterali di destra
La prima cappella che si apre sulla navata destra è dedicata a Benno di Meissen, vescovo vissuto nel XI secolo e canonizzato da Adriano VI nel 1523. Un secolo dopo, il ricco agente dei Fugger Johannes Lambacher, donando all’Anima una considerevole somma di denaro, volle destinarla alla decorazione della cappella. La pala d’altare [fig. 7], eseguita nel 1618 ed opera del caravaggesco veneziano Carlo Saraceni, narra l’episodio del Miracolo di San Benno (il ritrovamento delle chiavi di Meissen, gettate in acqua dal vescovo Benno in fuga da Enrico IV che lo accusava di tradimento, all’interno del corpo di un pesce offerto a Benno da un locandiere).
La pala d’altare si inscrive in un’edicola a timpano spezzato, fiancheggiata a sua volta dalle epigrafi in marmo nero di Bernardino Radi recanti iscrizioni celebrative del donatore, sormontate a loro volta dallo stemma di Lambacher. Proseguendo, la cappella dedicata a S. Anna conteneva inizialmente un gruppo ligneo policromo raffigurante S. Anna Metterza (S. Anna con la Vergine e il Bambino). L’opera, poi ricollocata nel Collegio Sacerdotale, venne sostituita da pitture a fresco di Cornelius Leysen rinvenute in occasione delle ultime campagne di restauro. In seguito all’ampliamento dell’intitolazione della cappella anche all’Immacolata Concezione, voluta da Johannes Savenier, la parete di fondo venne impegnata dalla pala di Giacinto Gimignani (Madonna con Bambino e S. Anna), del 1640 [fig. 8]. La decorazione della cappella prosegue con tre busti in marmo: a destra quelli di Johannes Savenier e del nipote Gualtiero Gualtieri, rispettivamente di Alessandro Algardi ed Ercole Ferrata, collocati in aggetto rispetto alla scarsa profondità della nicchia in cui si trovano; a sinistra, un altro busto, stavolta del cardinal Johannes de Sluse, è invece frutto del talento di Francesco Cavallini. A differenza della cappella di San Benno, unica eccezione, la cappella di S. Anna è, così come le altre, interamente decorata a fresco. Giovan Francesco Grimaldi riempì la restante porzione della parete di fondo con tre Storie di S. Anna, per collocare poi la Gloria di S. Maria e S. Anna sulla calotta absidale.
La terza cappella di destra venne affidata al patronato dei Fugger, ricchissimi banchieri di Augusta, diretti finanziatori della confraternita. Attorno agli anni Venti del XVI secolo Jakob Fugger convocò Giulio Romano assegnandogli, per la parete di fondo della cappella di famiglia, una Sacra Famiglia con i SS. Giovannino, Giacomo e Marco[11].Morto Jakob Fugger (1525) i lavori ripresero solo nel 1549 per iniziativa del nipote Anton. Le Storie della Vergine Maria di Girolamo Siciolante da Sermoneta vennero così completate nel 1560. In seguito al trasferimento della pala sull’altare maggiore del coro (1750) sulla parete di fondo venne posizionato un Crocifisso ligneo di Giovan Battista Montano (1584), ancora oggi in loco [fig. 9].
L’ultima cappella di destra, detta della Pietà, deve il suo nome al gruppo scultoreo del Lorenzetto che dal 1560 occupa, inserita all’interno di un nicchione marmoreo aperto sul lato superiore, la parete di fondo. Spoglia di decorazioni prima di quella data, la cappella doveva custodire altri affreschi del Sermoneta, purtroppo perduti. Anche per l’altare si dovette aspettare la fine del Settecento, con l’intervento di Ottavio Perini e Antonio Baldi, mentre la porzione superiore della parete fu riempita a stucchi monocromi da Giovanni Carani [fig. 10].
Le cappelle laterali di sinistra
Alla cappella di San Benno, prima di destra, corrisponde, sul lato sinistro, un altro ambiente connotato dalla precisa iconografia controriformistica. È la cappella che Lambertus Ursinus de Vivariis, provveditore dell’Anima ai primi del Seicento, fece consacrare al suo santo patrono, le cui reliquie si trovano nell’Anima dal 1636. Come Lambacher, egli affidò la pala a Saraceni, il quale nel 1618 licenziò un meraviglioso Martirio di San Lamberto [fig. 11]. Ai lati dell’edicola centrale, i due epitaffi in marmo nero coronati dai busti dei donatori commemorano Lamberto e il nipote, Egidius Ursinus de Vivariis, per volontà del quale il pittore “bambocciante”[12] Jan Miel decorò le pareti con le Storie di S. Lamberto.
Il secondo spazio a sinistra è dedicato al santo boemo Giovanni Nepomuceno, canonizzato nel 1729. Cinquant’anni più tardi, la confraternita dell’Anima decise di intitolargli una cappella. La primitiva pala d’altare, con la Vergine Maria che appare a San Giovanni Nepomuceno, opera di Anton Von Maron, venne sistemata in sagrestia. La semplice edicola a timpano lunettato venne completata, nel 1877, dalla pala con S. Giovanni Nepomuceno e il beato Johannes Sarkander [fig. 12,] altra opera di Seitz, che prima proseguì suddividendo la parete superiore in tre Scene della vita di San Giovanni Nepomuceno, e infine completò il lavoro con la Gloria della Vergine contornata da angeli.
La cappella di Santa Barbara, assegnata negli anni Trenta del Cinquecento alla confraternita, fu decorata a partire dal 1531 per volontà di un suo influente membro, nonché provveditore dell’Anima in quel periodo, ovvero il cardinale Willem von Enckenvoirt. Il blasone del cardinale (tre aquile su fondo oro) si ripete su entrambi i basamenti dell’edicola a tempio che, puntando sull’effetto di composta solennità conferito dall’accostamento di pilastri ionici scanalati con un semplice timpano triangolare, accoglie la Santa Barbara che intercede per Enckenvoirt dinanzi alla Santissima Trinità [fig. 13], capolavoro giovanile ad olio su pietra di Michael Coxcie[13]. Il pittore fiammingo, all’epoca tra i maggiori rappresentanti del raffaellismo romano, eseguì per la cappella anche le Storie di S. Barbara sulla parete di fondo e l’Ascensione con gli Apostoli e la Vergine Maria nella calotta.
L’ultima cappella sulla sinistra, nonché la più famosa dell’intero complesso, è la cappella del Margravio Albrecht di Brandeburgo. Cardinale nel 1518, fu da sempre un acerrimo nemico di Lutero. Tramite la mediazione dell’agente dei Fugger Quirinus Galler e del mercante Johannes Lemeken[14], il cardinale si assicurò il denaro da disporre per la decorazione della cappella. L’architettura dell’edicola, a timpano lunettato sorretto da colonne composite è opera di Bartolomeo Lante. I brani pittorici, invece, vennero eseguiti in due momenti differenti (1541-43 e 1549-50) da Francesco de’ Rossi detto il Salviati. Al primo momento va fatta risalire la monumentale Resurrezione a fresco [fig. 14] e la Pentecoste nel registro superiore della calotta, mentre alla fine degli anni Quaranta va datata la pala d’altare con la Deposizione, curiosamente anch’essa a fresco [fig. 15].
La sagrestia
Tramite un ambiente adiacente alla cappella del Margravio si accede all’anticamera della sagrestia. Quest’ultima, realizzata tra gli anni Trenta e Quaranta da Paolo Maruscelli, ha profilo rettangolare e volta ribassata. Riccamente decorata a stucchi dorati, contiene, nella parte centrale, un’Assunta del pittore viterbese Giovan Francesco Romanelli (anni Trenta del Seicento), racchiusa all’interno di una profilatura ottagonale a sua volta contornata da una trama di festoni vegetali in stucco e aquile bicipiti. Le vele della volta introducono piccole lunette che fanno da casa per le figure di sei papi di lingua tedesca, tra i quali anche lo stesso Adriano VI. Sulle pareti vennero collocati altri dipinti a tema mariano: la Natività di Gilles Hallet, l’Annunciazione di Giovanni Maria Morandi, la Visitazione di Giovanni Bonati e una S. Anna che istruisce la Vergine Maria, copia di un altro quadro di Hallet. Sopra la porta della sagrestia, invece, si trova l’originale pala di San Nepomuceno di Anton von Maron. Oggi in una collezione privata, ma originariamente concepita per la sagrestia[15], è la Natività di Carlo Maratta, rifiutata dai confratelli per il costo eccessivo e venduta dal pittore al conte Friedrich Christian di Schamburg – Lippe.
Il coro
Il primo intervento consistente sulle pareti del coro fu attuato, tra il 1536 e il 1542, da Giovanni Mangone. L’architetto, responsabile anche del catafalco funebre del cardinale Enckenvoirt, realizzò in quegli anni il maestoso altare marmoreo. Alle sue spalle, prima della ricollocazione settecentesca della Pala Fugger di Giulio Romano, avrebbe dovuto trovarsi un gruppo scultoreo della Madonna delle Anime, simile a quello eseguito dal Lante per il timpano del portale maggiore, che tuttavia non venne mai portato a compimento. In via provvisoria, venne collocata la Pietà del Lorenzetto; una volta trasferita anch’essa (1560) nell’ultima cappella di destra, sull’edicola dell’altar maggiore venne collocato un grande tabernacolo eucaristico, oggi perduto.
Ai lati dell’altare due nicchie custodiscono due figure femminili: sono le virtù teologali della Fides (sulla sinistra) e della Religio (sulla destra). La parete di fondo si completa con due scene mariane di Ludovico Stern (Natività e Morte della Vergine) e con la vetrata della Trinità di Ludwig Seitz. L’abside, i cui stucchi dorati disegnano l’originaria partizione costolonata, convoglia le linee degli ori al centro della calotta, all’interno del quale il monogramma dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria sostituì quello di Giulio II. La decorazione del presbiterio continua lungo le pareti laterali seguendo un programma che, se in origine avrebbe dovuto confermare lo stretto rapporto tra Adriano VI e Enckenvoirt (la cui tomba si trovava dirimpetto a quella del pontefice), oggi, con lo spostamento del catafalco del cardinale in controfacciata, sancisce invece la salda alleanza tra la curia romana e i principi cattolici. La tomba di Adriano VI, voluta da Enckenvoirt – ma non dal pontefice – e affidata all’architetto senese Baldassarre Peruzzi, assume le forme di un monumentale arco trionfale fiancheggiato da due ordini di nicchie ad arco inquadrate da colonne composite. Insistendo su un basamento a rilievo, dove coppie di putti sorregge l’insegna di Adriano accompagnando dai lati l’epitaffio centrale, la struttura parte da una grande lastra, anch’essa a rilievo, con l’ingresso di Adriano VI a Roma, fiancheggiata da due virtù cardinali, Iustitia e Fortitudo, alle quali si sovrappongono Prudentia e Temperantia. Il catafalco del pontefice è introdotto da un’iscrizione celebrativa, che percorre il complesso in larghezza, ideato da Enckenvoirt e riferito alla cattiva fama di cui Adriano godeva presso i romani[16].
PROH DOLOR! QUANTUM REFERT IN QUAE TEMPORA VEL OPTIMI CUIUSQUE VIRTUS INCIDAT
(AHIMÉ! QUANTO INFLUISCE L’EPOCA IN CUI SI MANIFESTA LA VIRTÙ, ANCHE QUELLA DI UN GRANDE UOMO)
Il sarcofago vero e proprio, inciso con le parole ADRIANUS VI PP (“Adriano Vi Pontefice) e preceduto dallo stemma di Adriano, è sormontato dalla figura dormiente del papa, ritratto da Michelangelo da Siena nella stessa posa in cui Mangone effigiò von Enckenvoirt. Al di sopra della trabeazione, una lunetta a rilievo con la Madonna con Bambino e gli Apostoli Pietro e Paolo. Al di sopra del frontone triangolare, un rilievo con la Fides.
Munita anch’essa dalla forma di un arco a tre fornici, la tomba di Karl Friedrich di Julich-Kleve-Berg venne posizionata in luogo del monumento funebre di Enckenvoirt. Il giovane duca ereditario, morto di vaiolo nel 1575 proprio in occasione di un soggiorno a Roma, era per il papato – ed in particolare per il papa di allora, Gregorio XIII Boncompagni – l’alleato principale dell’ortodossia cattolica nelle burrascose terre germaniche. Alla sua morte, il pontefice volle ad ogni costo commemorare il giovane duca, finanziando direttamente la costruzione del suo monumento funebre, chiamando tre scultori di provenienza fiamminga: Nicolas d’Arras, Gillis van de Vliete e Pierre de la Motte. Mani giunte, rivolto verso il coro, il giovane duca, riccamente abbigliato, assiste devotamente al Giudizio Finale a rilievo nella porzione centrale della lastra. Nelle nicchie laterali a conchiglia, invece, due figure allegoriche di Caritas e Prudentia che in origine dovevano ornare il monumento di Andrea d’Austria. Al loro posto, in queste nicchie, le stesse allegorie di Fides e Religio che ad oggi fiancheggiano l’altar maggiore.
Note
[1] A Lante spetta anche la realizzazione della facciata e del frontone per l’abitazione del notaio Johannes Sander di Nordhausen, attiguo rispetto alla chiesa.
[2] All’epoca dell’anno Santo del 1575, il duca ereditario Karl Friedrich di Julich – Kleve – Berg era il più forte alleato cattolico di Gregorio XIII in Germania. La costruzione della tomba rispondeva alle prescrizioni della chiesa controriformata stabilite da Carlo Borromeo nelle Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae (1577).
[3] I Nazareni, raccolti attorno alla Confraternita di San Luca di Vienna prima di occupare il monastero romano di S. Isidoro, furono un gruppo di pittori tedeschi che facevano del ritorno all’arcaismo quattrocentesco e della prevalenza dei temi sacri i loro marchi di fabbrica.
[4] Al febbraio di quell’anno risale la concessione della licenza di occupazione di suolo pubblico da destinare a nuovi ambienti della chiesa.
[5] Lante fu coadiuvato da Andrea da Settignano.
[6] Renata Samperi nota l’introduzione, tra il toro inferiore e la scozia delle basi, di un elemento a gola rovesciata riscontrabile anche nel cortile superiore del Belvedere.
[7] L’associazione tra i due materiali si diffuse molto durante gli ultimi anni del Quattrocento. Un esempio su tutti, Palazzo della Cancelleria.
[8] L’elemento dell’attico mezzano compare, infatti, in un disegno del progetto della chiesa di Loreto di Antonio da Sangallo.
[9] All’epoca, per una questione di decoro pubblico, la razionalizzazione dello spazio urbano aveva nella creazione di viae rectae uno dei suoi punti di forza.
[10] I modelli figurativi a cui sembra attingere Seitz sono le pale d’altare eseguite in ambito veneziano degli ultimi decenni del Quattrocento.
[11] I santi Giacomo e Marco vennero scelti per omonimia con due morti della famiglia Fugger (Jakob e Markus Fugger).
[12] Con “Scuola dei Bamboccianti” si intende lo stuolo di pittori che, sulla scia di Pieter van Laer “il bamboccio”, si dedicò alla descrizione di brani della vita agreste romana.
[13] La tecnica dell’olio sulla pietra ebbe in Sebastiano del Piombo uno dei suoi più illustri portavoce. Non si esclude, infatti, che il giovane Coxcie la apprese dal maestro.
[14] Lo stesso Vasari, nella vita del Salviati, scrive di come egli “nella chiesa de’ Tedeschi cominciò una cappella a fresco per un mercante di quella nazione”.
[15] La Natività di Maratta è citata nelle Vite da Giovan Pietro Bellori: “Dipinse Carlo un quadro della Natività della Vergine, ricercatone da signori deputati di Santa Maria dell’Anima della nazione tedesca, da collocarsi in una delle quattro facce della sagrestia.”
[16] Una nota pasquinata, diffusa ai tempi in cui Adriano era ancora sepolto a S. Pietro, recitava: “hic jacet impius inter Pios” (“qui giace un non pio tra i Pii”).
Bibliografia
Amadio, Siciolante, Girolamo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 92, 2018.
Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, Tipografia Vaticana, 1891.
P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, Mascardi, 1672.
Cheney, De’ Rossi Francesco detto il Salviati, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 39, 1991.
Kubersky – Piredda, T. Daniels, Santa Maria dell’Anima, Ruswil, Archipel Verlag, 2020.
Leuschner, The Young Talent in Italy, in Michael Coxcie (1499-1592) and the Giants of his Age, a cura di K. Jonckheere, Londra, 2013, pp. 50-63.
Lorizzo, Carlo Maratta e la chiesa di Santa Maria dell’Anima: il restauro della pala di Giulio Romano e la Nascita della Vergine per la sacrestia, in “Rivista d’Arte”, 5, 3, 2013, pp. 241-256.
Monbeig Goguel, Francesco Salviati e il tema della Resurrezione di Cristo, in “Prospettiva”, 13, Firenze, Centro di Della, 1978, pp. 7-23.
Nova, Francesco Salviati and the ‘Markgrafen’ Chapel in S. Maria dell’Anima, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 25, 3, Firenze, 1981, pp. 355-372.
Ottani Cavina, Saraceni, Carlo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 90, 2017.
Parlato, Giulio Romano, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 57, 2001.
Rendina, Le chiese di Roma, Roma, Newton Compton, 2000.
Samperi, La fabbrica di Santa Maria dell’Anima e la sua facciata, in “Annali di architettura”, 14, 2002, pp. 109-128.
Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.
Il Parnaso PT I
A cura di Andrea Bardi
Dopo aver completato la Disputa e la Scuola di Atene, Raffaello procede, tra il 1510 e il 1511, a impegnare la terza parete della Stanza, quella “di verso Belvedere”[i]con l’allegoria della poesia e con la raffigurazione del Parnaso (fig. 1), associato al tondo a fresco della Poesia sul soffitto (Fig. 2).
Il monte Parnaso, collocato all’intersezione di tre regioni dell’entroterra greco – Beozia, Focide e Ftiotide – è assurto, in epoca classica, a sede del dio Apollo e delle Muse. La stessa parola luvia (un idioma parlato tra il II e il I millennio a.C. nella penisola anatolica) parnassas, infatti, sarebbe da tradurre come “casa degli dei”.
Il Parnaso: i personaggi
Nel grande affresco vaticano – che raggiunge quasi i sette metri di larghezza – il Parnaso è casa di un dio in particolare, Apollo, delle nove Muse e di un consesso di poeti, antichi e moderni, suddivisi in quattro grandi “zone” tematiche[ii]: in alto a sinistra, troviamo i grandi autori dell’epica classica e medievale (Fig. 3), con Omero al centro, circondato da Virgilio, Dante, Stazio – dietro Virgilio – e il giovane Ennio, seduto sulla sinistra di Dante.
Più in basso, Saffo (fig. 4), costituisce – assieme a Pindaro (?), Catullo (o forse Tibullo o Properzio), Orazio e Petrarca – il raggruppamento della lirica (fig. 5).
Sul lato opposto dell’affresco, trovano spazio i grandi tragici greci (Eschilo, Sofocle, Euripide, fig. 6) e, più in alto, tutti gli esponenti di quei generi “mediani” come l’elegia o l’epigrammatica (fig. 6).
Le questioni attributive: due poeti “mediani”
Se l’individuazione degli autori classici non ha comportato particolari problematiche, vista la loro lunga e consolidata tradizione figurativa, circa i poeti “moderni” gli studiosi non hanno ancora individuato un accordo comune. Qualsiasi tentativo di ricostruzione dell’identikit di alcuni poeti – e di due personaggi in particolare – non può, però, non partire da due fonti specifiche, le Vite vasariane (1568) e la Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino (1695).
Circa la fonte vasariana, va tuttavia chiarito, sin da subito, che la sua descrizione del Parnaso non si fonda tanto sull’osservazione diretta dell’affresco, quanto dalla visione dell’incisione a bulino realizzata da Marcantonio Raimondi nel 1517 (Fig. 7), il cosiddetto Parnaso I oggi ai Musei Civici di Pavia.
Nell’incisione di Raimondi, che costituisce l’unica testimonianza del progetto originale di Raffaello, Vasari individua, al di sotto di “una infinità di Amori igniudi con bellissime arie di viso”[iii]non presente nella versione definitiva dell’affresco, molti poeti, tra i quali riconosce Giovanni Antonio Tibaldeo (“il Tibaldeo similmente et infiniti altri moderni”)[iv]. La presenza di Tebaldeo viene confermata da Giovanni Paolo Lomazzo che, nel Libro dei Sogni (1563), nel menzionarlo, non nasconde le sue perplessità (“tanto che a me pare che di esservi quasi non fusse degno”)[v].
A cavallo tra XVII e XVIII secolo, Bellori, oltre a confermare le indicazioni vasariane (“Incontro veggonsi due altri Laureati, che il Vasari riferisce al Tibadeo, ed al Boccaccio”)[vi] è il primo a identificare, nella figura sull’estrema destra dell’affresco, “il Sannazaro laureato in nobil sembiante, raso, senza barba”[vii].Il poeta napoletano Jacopo Sannazaro è, per Vincenzo Farinella e Alberto Casadei (Il Parnaso di Raffaello. Criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, 2017) un’ipotesi plausibile. I due studiosi, nella loro analisi, legano il personaggio sbarbato del Parnaso a una xilografia di Sannazaro contenuta nell’edizione Perna (Basilea, 1577) degli Elogia doctorum virorum (con incisioni di Tobias Stimmer)[viii] e all’effigie su una medaglia di Girolamo Santacroce.
Ancora Casadei e Farinella gettano nuova luce su un altro personaggio, l’uomo barbato dai capelli corti e neri che, in alto a destra, rivolge il suo sguardo allo spettatore. Se precedentemente questi veniva spesso associato (Vasari, Lomazzo, Bellori) a Giovanni Antonio Tebaldeo, sono i due studiosi a proporre una valida alternativa. Scartando l’ipotesi Ariosto – al tempo dei fatti ambasciatore degli Estensi e perciò inviso a Giulio II – essi chiamano in causa il poeta Jacopo Sadoleto. Autore del fortunato poemetto De Laocoontis statua (1506) Sadoleto, che all’epoca aveva poco più di trent’anni – pressappoco l’età che si può desumere dalla fisionomia del personaggio dipinto – può essere a buona ragione considerato come una figura di primo piano nella monumentale operazione celebrativa nei confronti di quella fervida stagione culturale di Giulio II, il cui ruolo di protettore delle arti e delle lettere viene sancito del resto anche dai due monocromi di base, il primo con Augusto impedisce agli esecutori testamentari di Virgilio di bruciare l'Eneide (Fig. 8) e il secondo con Alessandro il Grande fa riporre i poemi omerici in un prezioso scrigno di Dario (Fig. 9).
Note
[i] G. Vasari, Le Vite, p. 71.
[ii] A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello: criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, p. 62.
[iii] G. Vasari, Le Vite, p. 71.
[iv] Ibidem
[v] Le parole di Lomazzo sono riportate in A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello, p. 62.
[vi] G.P. Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, p. 56.
[vii] Ibidem
[viii] A. Casadei, V. Farinella, Il Parnaso di Raffaello, p. 65.
Bibliografia
Paul Barolsky, Raphael’s “Parnassus” scaled by Bembo, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 19, no. 2, Chicago, The University of Chicago Press, 2000, pp. 31-33.
Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.
Alberto Casadei, Vincenzo Farinella, Il Parnaso di Raffaello. Criptoritratti di poeti moderni e ideologia pontificia, in “Ricerche di Storia dell’Arte”; n. 123, Roma, Carocci, 2017, pp. 59-72.
Beth Cohen, The “Rinascimento dell’Antichità” in the art of painting: Pausanias and Raphael’s Parnassus, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 3, no. 4, Chicago, The University of Chicago Press, 1984, pp. 29-44.
Adam T. Foley, Raphael’s Parnassus and Renaissance: afterlives of Homoer, in “Renaissance Quarterly”, 73, New York, The Renaissance Society of America, 2020, pp. 1-32.
Luba Freedman, Apollo’s glance in Raphael’s Parnassus, in “Source: Notes in the History of Art”, vol. 16, no. 2, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 20-25.
Kathi Meyer – Baer, Musical Iconography in Raphael’s Parnassus, in “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 8, no.2, Wiley – The American Society for Aesthetics, 1949, pp. 87-96.
Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, “Art Dossier”, n. 298, Firenze – Milano, Giunti, 2013.
David Rijser, The Stanza della Segnatura, the Middle Ages and Local Traditions, in Karl A.E. Enenkel, Konrad Adrian Ottenheym (a cura di), The Quest for an appropriate Past in literature, art and architecture, Leida, Brill, 2019, pp. 106-126.
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.
Paul F. Watson, On a window in Parnassus, in “Artibus et Historiae”, vol. 8, no.16, Cracovia, IRSA, 1987, pp. 127-148.
Emanuel Winternitz, Archeologia musicale nel Parnaso di Raffaello, in “Ecclesia”, n. 9, Città del Vaticano, 1955, pp. 452 – 457.
Sitografia
https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-santi_%28Dizionario-Biografico%29/
http://projects.mcah.columbia.edu/raphael/htm/raphael_parnas_draw.htm
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Pp-1-73
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Pp-1-74
https://www.treccani.it/vocabolario/parnaso
LA STANZA DELLA SEGNATURA DI RAFFAELLO IN VATICANO
A cura di Andrea Bardi
La Disputa del Sacramento
“Fece in un’altra parete un cielo con Cristo e la Nostra Donna, San Giovanni Batista, gli Apostoli e gli Evangelisti e Martiri su le nugole con Dio Padre, che sopra tutti manda lo Spirito Santo e massimamente sopra un numero infinito di Santi, che sotto scrivono la Messa; e sopra l’Ostia, che è sullo altare, disputano”[i]
Con queste parole Giorgio Vasari introduce il suo approfondimento sulla Disputa del Sacramento, affresco che, opponendosi alla celeberrima Scuola di Atene, occupa nella sua interezza la parete che ci si lascia alle spalle non appena si entra nella Sala. L’affresco (500x770 cm, fig. 1) si presenta come la traduzione pittorica della Teologia, una delle quattro discipline fondative dell’ordinamento umanistico che, assieme a Filosofia, Poesia e Giurisprudenza, rendono la Sala, nelle parole di Antonio Paolucci, “un capolavoro di antropologia culturale cattolica”[ii].
Il soggetto: disputa o non disputa?
Il nome con cui l’affresco è universalmente noto (Disputa del Sacramento) deve la sua fortuna al sopracitato passo vasariano, in cui lo storico aretino, descrivendo la scena, impiega, reiterandolo, proprio il verbo disputare (“un numero infinito di santi, che…disputano”; “Santi Dottori cristiani, i quali…disputando”; “faccendone segno co ‘l disputar con le mani”). L’indicazione vasariana si presta molto a letture erronee, una delle quali – quella che ha effettivamente preso piede dal Seicento in poi – vorrebbe il corteo di santi e dottori impegnato in una discussione. Un più corretto inquadramento tematico della scena permette, al giorno d’oggi, di inserirla nella lunga e proficua tradizione iconografica del Trionfo dell’Eucarestia o Trionfo della Chiesa, rigorosamente divisa in Ecclesia Militans (“Chiesa Militante”) e in Ecclesia Triumphans (“Chiesa Trionfante”). Va detto, infatti, che Giorgio Vasari “non intendeva affatto di fissare o proporre un titolo complessivo”[iii]. Parte della critica straniera arrivò addirittura ad intendere, spingendo il paradosso fino all’estremo, la disputa come una protesta nei confronti del dogma dell’Eucarestia. Ludwig von Pastor invece riaffermò, nella prima metà del Novecento, il principio secondo cui l’intento di Raffaello fosse “l’indagare, l’insegnare, l’apprendere […] tutto in rapporto a quell’Uno ed Eterno che è sempre presente sopra gli altari nel SS. Sacramento”[iv]. Ancora Bricarelli, invece, individuava nell’antifona O sacrum convivium la fonte iconografica dell’affresco[v] definito poi dal Muntz “la più alta espressione della pittura cristiana […] il più perfetto compendio di quindici secoli di fede”[vi]. Il soggetto proposto, il Trionfo, viene successivamente confermato da altri studiosi come Ernst Gombrich, Konrad Oberhuber, James Beck[vii].
La Disputa I: il disegno preparatorio e i significati simbolici
Una iniziale meditazione sull’architettura compositiva generale viene eseguita dall’artista in un disegno, che John Shearman definì Disputa I (fig. 2), oggi custodito presso la Royal Library del Castello di Windsor. Rispetto alla versione finale, nello studio – un acquerello con rialzi a biacca – Raffaello dispone i personaggi del registro inferiore dinanzi ad un porticato, oltre a non inserire, nella parte centrale, l’altare. La Disputa I evidenzia inoltre come l’artista non sentisse il bisogno di fornire un abbozzo dell’intera composizione, bensì di una sola metà (la sinistra) che sarebbe stata ripetuta successivamente in maniera perfettamente speculare.
Richiamando una tesi precedentemente espressa da Matthias Winger (Progetti ed esecuzione nella Stanza della Segnatura), Kim Butler Wingfield (Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura) ha portato l’attenzione sulla struttura architettonica che, ancor presente nello studio, è stata poi definitivamente accantonata nella versione finale dell’affresco. Il piano originale di Raffaello – sostiene Winner – era centrato sul concetto agostiniano di Civitas Dei, la “città di Dio” in cui le pietre da costruzione altro non sono che i cittadini stessi (Agostino usa l’espressione lapides vivi, ovverosia “pietre vive”)[viii]. Nei piani di Giulio II, pontefice fortemente legato al Corpus Domini, l’aspetto da tenere in maggiore considerazione doveva essere invece quello della corporalità di Cristo, del suo essere anche carne oltre che verbo[ix]. In virtù dell’emersione di predicazioni eretiche dal nord Europa, poi (Wycliffe, Hus) la riaffermazione della natura terrena di Cristo acquisisce, nell’affresco, un significato eminentemente politico.
Il registro inferiore: l’Ecclesia Militans
Il registro inferiore della composizione è interamente popolato dal consesso di dottori della chiesa, santi teologi ma anche letterati che, disposti a semicerchio attorno all’ostensorio, formano l’“esercito” del Signore, la Chiesa Militante (Ecclesia Militans, fig. 3). La chiara fama di molti di questi personaggi ha reso, poi, la loro identificazione estremamente semplice.
Ponendosi in ideale continuità con il brano paesistico del fondale, la figura che chiude la composizione all’estremità sinistra altri non è che Donato Bramante, soprintendente, all’epoca, del cantiere per la nuova Basilica di San Pietro, il cui avanzamento dei lavori è del resto richiamato sullo sfondo. Tra le altre figure presenti, i quattro Dottori della chiesa ricoprono delle posizioni privilegiate. Fiancheggiando l’altare da sinistra (Girolamo, Gregorio Magno) e da destra (Agostino, Ambrogio) i dottori sono individuati precisamente grazie ai nomi inscritti nelle aureole. La loro presenza risulta fondamentale per un motivo molto semplice: è ai Dottori, infatti, che si deve la sistemazione teorica del dogma della Transustanziazione, ovverosia la reale (e non simbolica) presenza di Cristo nell’Eucarestia. San Girolamo, affiancato dal leone, uno dei suoi simboli canonici di accompagnamento, aveva sottolineato la presenza di Cristo nell’ostia (Commento a Matteo) così come del resto aveva fatto Agostino (Sermoni). Su Gregorio, invece, è caduta recentemente l’attenzione di Kim Butler-Wingfield (Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, 2017). La studiosa, a partire dal confronto iconografico effettuato da Frederick Hartt tra il santo dottore e una una medaglia, oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, in cui l’orafo Caradosso Foppa aveva effigiato Giulio II, ha posto l’accento sulla centralità di Gregorio. Quest’ultimo aveva, tra il VI e il VII secolo, modificato la preghiera Eucaristica introdotta da Sant’Ambrogio (375 d.C.). In occasione di una messa, poi, lo scetticismo di una donna circa l’effettiva veridicità della Transustanziazione erano stati fugati grazie alla preghiera di Gregorio, che ebbero come conseguenza la trasformazione del pane nel vero corpo di Cristo. Attorno alla metà del XIV secolo, la leggenda trovò enorme diffusione anche in relazione all’imago pietatis di Santa Croce a Firenze, che era considerata l’immagine effettivamente vista secoli prima in occasione della messa. La medaglia di Caradosso, così come altre effigi fatte eseguire dal della Rovere, recava, sul verso, proprio l’imago pietatis di Santa Croce, e questo particolare inevitabilmente va a rafforzare il legame ideale tra i due pontefici. Le analogie, anche e soprattutto di carattere fisionomico, tra Giulio II e Gregorio si spiegherebbero, secondo la studiosa, anche alla luce del particolare accanimento dimostrato dai lanzichenecchi nel 1527 verso l’immagine di Gregorio/Giulio, che è infatti fortemente danneggiata. L’ira dei mercenari imperiali, nota Butler-Wingfield, si spiegherebbe perfettamente proprio considerando una simile confusione tra ciò che l’immagine rappresenta (Gregorio) e la sua effettiva ricezione. È tuttavia un altro particolare ad essere risolutivo per la studiosa: Gregorio/Giulio è, insieme a Sisto IV sul lato opposto (ancora un della Rovere) l’unico personaggio a poter disporre della visione del Trionfo celata agli altri; da ciò ne deriva la conclusione che l’episodio inscenato è una visione del santo. Questi, ancora nel Liber Moralium – testo a commento di Giobbe presente ai suoi piedi nella Disputa – aveva fortemente contestato la teoria secondo la quale il corpo di Cristo non era, al momento della Resurrezione, solido, opponendo invece il principio di corpo palpabile per veritatem naturae[x].
Collocato perfettamente al centro della scena, l’ostensorio, centro di gravità dell’intera composizione, si pone perfettamente all’interno di una verticale ideale che lo congiunge con la Trinità (la colomba dello Spirito Santo, il Figlio e il Padre). Ciò che appare dell’ostia, la sua componente materiale, va così ad integrarsi alla sua essenza – il corpo di Cristo – accessibile alla sola visione del consesso di santi e patriarchi che lo circondano. A destra, altri personaggi riconoscibili sono pontefici come Sisto IV e Innocenzo III. Ai piedi del primo, zio di Giulio II, compare il trattato De sanguine Christi, altra rivendicazione forte circa la natura terrena di Cristo e altro prezioso indizio della decisa presa di posizione ideologica da parte di Giulio. Ai lati di Innocenzo, poi, compaiono i due maggiori teologi del Duecento, Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio (canonizzato da Sisto IV nel 1482), che come i dottori della Chiesa recano il loro nome all’interno del nimbo, precedendo nel corteo lo stesso Dante Alighieri che proprio ai due santi aveva lasciato ampio spazio nei canti X-XII del Paradiso. Nel canto X, Tommaso è il primo a palesarsi al poeta:
“Io fui de li agni de la santa greggia
che Domenico mena per cammino
u’ ben s’impingua se non si vaneggia”
(Dante, Paradiso, X, 94-96)
Se nel canto successivo Dante continua a lasciare la parola al bue muto (epiteto con cui Tommaso venne ribattezzato dai suoi confratelli all’Università di Parigi), il quale descrive la vita e l’eredità di Francesco d’Assisi, un’operazione analoga è condotta, nel canto XII, da Bonaventura (questa volta in riferimento a Domenico di Guzman), che viene così introdotto dall’Alighieri:
“Io son la vita di Bonaventura
da Bagnoregio, che ne’ grandi offici
sempre pospuosi la sinistra cura.”
(Dante, Paradiso, XII, 127-129)
L’Ecclesia Triumphans
Al di sopra di una cortina di nubi dal quale fa capolino una molteplicità di piccole teste di putti, una teoria di santi circonda le figure della Vergine e di Giovanni Battista, a loro volta collocate ai lati di un Cristo in gloria. Assiso anch’esso su una nube, la sua figura sovrasta la colomba dello Spirito Santo, fiancheggiata a sua volta da quattro piccoli angeli intenti a tenere aperti i quattro Vangeli canonici. Schiere angeliche si innalzano del resto anche nella porzione superiore della scena, in prossimità del profilo dell’arco, e affiancano l’immagine perfettamente ieratica e frontale di Dio Padre che, tenendo in mano il globo terrestre, viene dotato di un nimbo (aureola) quadrato e circondato da una cascata di angeli che sembrano fluire verso il basso all’interno di linee disposte a raggiera.
Così come per la Chiesa Militante, anche per l’Ecclesia Triumphans (fig. 4) sul registro superiore l’individuazione dei santi effigiati risulta compito relativamente intuitivo. All’estrema sinistra, il gioco di sguardi tra San Pietro e Adamo (riconoscibile dalla nudità) precede le figure di San Giovanni Evangelista e di Re David, intento a suonare la cetra. Completano la figurazione Santo Stefano e il profeta Geremia. Il lato destro, chiuso invece da San Paolo, prosegue verso l’interno con Abramo, una figura di apostolo – la cui identità non è ancora perfettamente chiarita (San Giacomo o San Matteo) – Mosè (quest’ultimo riconoscibile dalle Tavole della Legge), San Lorenzo e Giuda Maccabeo.
La Disputa: le fonti iconografiche
Ogni analisi che si ponga come scopo quello di approfondire ad un discreto livello la questione relativa alle fonti iconografiche di un dato testo figurativo non può prescindere dai suoi precedenti. Prima di soffermarsi su parallelismi più diretti ed immediati, appare necessario effettuare una ricognizione che metta a fuoco questioni meno ovvie. Ancora Butler-Wingfield si sofferma, a tal proposito, sull’iconografia del Trionfo di San Tommaso. Tra le diverse variazioni sul tema menzionate dalla studiosa, quella offerta da Benozzo Gozzoli per Santa Caterina a Pisa (ora al Louvre, fig. 5) appare adeguata e perfettamente inscrivibile nella storia personale di Giulio. Così come nella Disputa, infatti, anche nella pala pisana compare la figura di Sisto IV. Da una prospettiva più eminentemente figurativa, poi, nel Trionfo di Tommaso appare quell’idea di asse centrale invisibile che lega una figura principale (Tommaso) alla quale si sovrappone quella del Padre Eterno.
La pala di Benozzo non esaurisce, però, il campionario di modelli a cui Raffaello sembra aver fatto riferimento per l’organizzazione, per l’impaginazione generale della scena. Fonti più vicine a lui, non cronologicamente ma geograficamente – le basiliche paleocristiane – potrebbero avere avuto un ruolo, un’influenza nelle scelte dell’urbinate. Alcune ipotesi sono state individuate, a tale scopo, dalla studiosa americana Bonnie Kutbay (Early Christian iconography in Raphael’s disputa), che ha inizialmente proposto un confronto con il mosaico absidale di Santa Costanza[xi] e con la decorazione del catino della basilica petrina, la cui conformazione venne copiata ai primi del Seicento (1605) da Giacomo Grimaldi, prima dei lavori di demolizione della navata portati avanti da Paolo V e affidati a Carlo Maderno (1612). La Kutbay sottolinea come tanto nei mosaici petrini quanto nella Disputa la separazione tra cielo e terra venisse segnalata da una linea curva, e di come la stessa rappresentazione del Paradiso fosse portata avanti per mezzo di linee radianti. Elemento, questo, che si ripete anche in altri mosaici absidali, quello dell’Incoronazione della Vergine, che Jacopo Torriti completò nel 1296 in Santa Maria Maggiore (fig. 6), o quello di San Clemente. La disposizione semicircolare degli apostoli attorno a Cristo, tuttavia, risale addirittura al V secolo (mosaici di Santa Pudenziana, Roma, fig. 7).
L’analisi dei modelli a disposizione di Raffaello va infine portata alle soglie del Cinquecento, addentrandosi all’interno del corpus pittorico raffaellesco. Il primo esempio utile a riguardo è il Giudizio Universale affrescato tra il 1499 e il 1501 da Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli in una delle cappelle dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze (Fig. 8). L’affresco, oggi staccato e conservato al Museo San Marco, appare, pur nelle lacune nella parte superiore, il precedente più vicino – almeno per la conformazione della parte superiore – alla Disputa ma, ancor prima, alla Trinità e santi (1505-1508, fig. 9), altra opera condotta a quattro mani da Raffaello e Perugino per la cappella Sansevero.
Note
[i] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, p. 69.
[ii] A. Paolucci, Raffaello in Vaticano, p. 10.
[iii] A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 334.
[iv] Le parole di Pastor sono riportate in ibidem, nota 1.
[v] C. Bricarelli, Il pensiero cristiano del Cinquecento nell’arte di Raffaello, p. 59. Le parole di Bricarelli sono riportate in A. Spadaro, la civiltà cattolica, p. 334.
[vi] Le parole di Muntz sono contenute in A. Spadaro, La civiltà cattolica, p. 335.
[vii] B.L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, p. 245.
[viii] Kim Butler Wingfield, Networks of knowledge: inventing Theology in the Stanza della Segnatura, p. 180.
[ix] Ibidem.
[x] Ivi, p. 187.
[xi] B. L. Kutbay, early christian iconography in Raphael’s disputa, p. 247.
Bibliografia
Kim Butler Wingfield, Networks of Knowledge: Inventing Theology in the Stanza della Segnatura, in “Studies in Iconography”, vol. 38, Kalamazoo, Medieval Institute Publications of Western Michigan University, 2017, pp. 174 – 221.
Bonnie L. Kutbay, Early christian iconography in Raphael’s Disputa, in “Journal of Literature and Art Studies”, vol. 9, no. 2, 2019, David Publishing, pp. 245-260.
Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, “Art Dossier”, n. 298, Firenze – Milano, 2013.
Deoclecio Redig de Campos, Raffaello nelle stanze, Milano, Martello, 1965.
John Shearman, Raphael as architect, in “Journal of the Royal Society of Arts”, vol. 116, no. 5141, Londra, Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 1968, pp. 388-409.
John Shearman, The vatican stanze: functions and Decoration (1971), in George Holmes (a cura di), Art and Politics in Renaissance Italy. British Academy Lectures, New York, The British Academy Press, 1993.
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.
LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO PT III
A cura di Andrea Bardi
In quello che intende essere l’ultimo approfondimento sulla cappella di Tiberio Cerasi in Santa Maria del Popolo verranno discusse le pitture sulla volta del vano e la pala d’altare, l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci.
La pala d’altare: l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci
Entro un’edicola delimitata da colonne corinzie in marmo verde e sormontata da un timpano triangolare spezzato, si trova la tavola dell’Assunzione di Annibale Carracci [Fig. 1]. Come già specificato in precedenza, in mancanza di documenti di pagamento o contratti, l’unico testimone coevo di tale commissione risulta essere l’avviso cittadino del 2 giugno 1601, nel quale tanto le opere di Caravaggio quanto la pala di Annibale ancora dovevano essere realizzate.
L’episodio viene raccontato da testi paleocristiani e ripreso successivamente da una delle principali fonti dell’agiografia cristiana medievale, la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, che descrive l’evento della ricongiunzione del corpo della Vergine alla sua anima, portata in cielo dal figlio Gesù alla presenza degli apostoli.
Ad una prima osservazione, la Vergine di Annibale sembra voler erompere dalla scatola rettangolare che abita per fuoriuscire dallo spazio pittorico e invadere quello reale. Bloccata dal marmo che ne confina inevitabilmente la spinta, Maria diviene il perno di una composizione che, messa a confronto con le laterali del Caravaggio, non riesce a replicarne il respiro ampio risultando per certi versi asfittica. Leo Steinberg (Observations on the Cerasi chapel, 1959) riuscì a cogliere acutamente i motivi alla base di tale disparità tra i due pittori: mentre il primo tornò sui suoi passi fornendo ai committenti una seconda versione per ognuna delle due pale, dimostrando una consapevolezza del contesto architettonico (“the Caravaggio paintings acknowledge their architectural context”[1]), Annibale non dimostrò lo stesso zelo nell’adattare la sua pala allo spazio dell’altare, che ne comprime la dirompente energia tramutandola in quella che Wittkower definì a ragion veduta una “massa opprimente”[2]. Del resto, come sappiamo dall’aggiunta di testamento di Tiberio Cerasi (2 maggio 1601) a quelle date Carlo Maderno ancora non aveva consegnato il disegno definitivo dell’ambiente, quindi entrambi gli artisti si trovarono a dover operare “al buio”[3]. Il confronto con Caravaggio, però, si giocava soprattutto sulla declinazione del concetto di “vero”. Un vero fotografico, ottico, nitido quello del Merisi; un vero mai lasciato a sé, ma sempre sottoposto al filtro della grande pittura italiana (Correggio, Paolo Veronese) quello di Annibale. Quest’ultimo non avrebbe mai accettato di far convergere del tutto la vita con l’arte, come avrebbe fatto del resto il Merisi nel controverso Transito della Vergine per Santa Maria della Scala, prendendo a modello il corpo morto di una prostituta (“una cortigiana”, secondo Giulio Mancini) per farne una Vergine morente. L’“eccesso di idealizzazione” dell’Assunta, dunque, può plausibilmente spiegarsi proprio in ragione di una volontà di accentuazione del contrasto col giovane rivale. Il concetto di vero mediato dalla storia si traduce, qui, in una rielaborazione di due testi fondamentali del primo Cinquecento italiano, l’Assunta dei Frari di Tiziano [Fig. 2] e la Trasfigurazione di Raffaello [Fig. 3]. Proprio alcuni elementi di comunanza con Tiziano (specialmente dei passaggi chiaroscurali) sono, nel dibattito sulla datazione della Cerasi, messi in campo da Silvia Ginzburg che, a partire da tali considerazioni, è propensa a spostare di un paio d’anni più avanti (1602 – 1603 ca.) l’esecuzione dell’opera. È lo stesso Malvasia, del resto, a parlarci di un viaggio a Venezia compiuto nel 1602 da Annibale in occasione del funerale del fratello Agostino[4]. La Ginzburg inoltre si appoggia a rinvenimenti documentari (un pagamento effettuato nel maggio 1605 ad un falegname “per haver accomodato li quadri delle pitture”[5]).
Il tema dell’Assunzione nella produzione di Annibale
Al di fuori del confronto con Caravaggio, l’Assunta Cerasi può essere termine di paragone con altre variazioni sul tema che Annibale condusse lungo tutto l’arco della sua carriera. La prima riflessione su tale soggetto fu effettuata dal pittore nel 1587 in una pala eseguita per la Confraternita di San Rocco a Reggio Emilia (oggi alla Gemäldegalerie di Dresda, fig. 4).
Nella prima pala reggiana Annibale lascia quasi fluttuare la Vergine che, attorniata da un corteo di angeli, lascia attoniti gli apostoli radunati attorno alla sua tomba. Quest’ultima è leggermente decentrata rispetto alla Cerasi. Annibale, sin dagli esordi, mostrava una certa attenzione per le architetture classiche e quest’ultime, nella successiva prova, oggi al Prado [Fig. 5], diventano gli elementi sintomatici della sua personalissima rielaborazione del lessico veronesiano. Nello specifico, le colonne che a Dresda sono lisce e terminanti con capitelli ionici, nell’Assunzione di Madrid vengono scanalate, e per i capitelli si passa all’ordine corinzio. Inoltre, la maggiore maturità nel dominio dello spazio permette ad Annibale di osare scorci più incisivi, aprendo la scena anche a un delicato panorama collinare.
Per la cappella Bonasoni nella chiesa bolognese di San Francesco [Fig. 6], dipinta nel 1592, Annibale conduce verso il basso il punto di vista dell’osservatore, portandolo leggermente più al centro della scena.
Lo spazio della tela è qui messo a disposizione di una temperatura espressiva più concitata, ed è inoltre suddiviso perfettamente a metà dalla prepotenza con cui la massa di nubi, sulla quale trovano posto degli angioletti irrequieti, emerge facendo sfondo ad una Vergine che sembra volare per davvero, più credibile rispetto ai corpi fluttuanti, sospesi nell’atmosfera, delle precedenti versioni.
La volta
Nella botte della volta della cappella, incorniciati da stucchi dorati, si trovano i due riquadri laterali e l’ovato centrale, dipinti a fresco da Innocenzo Taccone, allievo di Annibale Carracci su disegni di quest’ultimo [Fig. 7].
I riquadri laterali sono fortemente legati alle pale laterali del Caravaggio. L’episodio del Domine quo vadis? [Fig. 7, a sinistra] precede cronologicamente la Crocifissione, costituendo tra l’altro l’evento scatenante del pentimento di Pietro. La Visione di San Paolo, invece [Fig. 7, a destra] raffigura il momento in cui “Paolo Dottore della genti fu rapito al terzo cielo[6]”, episodio a cui accenna lo stesso Paolo nella seconda delle Lettere ai Corinzi:
“So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze”
(Seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi, 12, 2-5).
L’ovato centrale, con l’Incoronazione della Vergine, è il brano qualitativamente più pregiato di tutta la volta, al punto tale da far ipotizzare un presunto intervento di Annibale per le rifiniture[7]. Anche il tema dell’Incoronazione fu molto caro ad Annibale. Partendo dall’affresco di Correggio per il catino absidale di S. Giovanni Evangelista a Parma (ora staccato e custodito presso la Galleria Nazionale di Parma, fig. 8), Annibale realizzò l’Incoronazione, oggi al Metropolitan di New York, che nel 1603 era documentata nell’inventario del cardinale Pietro Aldobrandini.
Note
[1] L. Steinberg, Observations on the Cerasi chapel, p. 186.
[2] R. Wittkower, Arte e architettura in Italia, p. 116.
[3] S. Ginzburg, scheda di catalogo dell’Assunta Cerasi, in Benati, Riccomini, p. 380.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] G. Baglione, Le vite, p. 312.
[7] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 522.
Bibliografia
AA.VV., Caravaggio, Carracci, Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Milano, Silvana, 2001.
Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, Roma, Andrea Fei, 1642.
Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, per il success. al Mascardi, 1672.
AA.VV., The Drawings of Annibale Carracci, Washington, National Gallery of Art, 1999.
Daniele Benati, Eugenio Riccomini (a cura di), Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006.
Maurizio Calvesi, Caravaggio, “Art Dossier”, Firenze, Giunti, 1986.
Roberto Longhi, Caravaggio, Roma, Editori riuniti, 1982.
Denis Mahon, Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington Magazine”, vol. 93, no. 580, Londra, Burlington Magazine Publications, pp. 222-235.
Stephen D. Pepper, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, in AA.VV., Studi di storia dell’arte in onore di Denis Mahon, Milano, Electa, 2000, pp. 109-122.
Orietta Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino, Einaudi, 2014.
Leo Steinberg, Observations in the Cerasi Chapel, in “The Art Bulletin”, vol. 41, no. 2, New York, College Art Association, pp. 183-190.
Claudia Viggiani, La cappella Cerasi, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009, pp. 511-531.
Rudolf Wittkower, Arte e Architettura in Italia. 1600 – 1750, Torino, Einaudi, 2018.
Roberto Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, in “Melanges de l’ecole francaise de Rome”, 93 – 2, Roma, Ecole Francaise de Rome, 1981, pp. 821 – 822.
Sitografia
http://www.smariadelpopolo.com/it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tiberio-cerasi_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-merisi_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ricci_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-tacconi_(Dizionario-Biografico)
LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO PT II
A cura di Andrea Bardi
Dopo aver tracciato, nel precedente elaborato, la storia documentaria dei lavori relativi alla cappella, nei seguenti articoli si intende offrire un focus sulla decorazione pittorica al suo interno che la rende uno degli spazi più eloquentemente espressivi dell’ondata di innovazione portata dal nord Italia da Annibale Carracci e da Caravaggio.
Descrizione
La cappella Cerasi è collocata in fondo alla navata di sinistra della chiesa, fiancheggiando l’altare maggiore. Essa si compone di due spazi, un’anticamera e lo spazio vero e proprio della cappella, separati da un arco impostato su pilastri, a loro volta decorati con rilievi in stucco dorato narranti episodi della vita dei due santi titolari, Pietro e Paolo; ai quali si aggiunge un ulteriore rilievo, la lapidazione di Santo Stefano, la cui presenza si spiega alla luce della tomba di Stefano Cerasi, fratello del tesoriere Tiberio.
L’anticamera
I monumenti
L’ambiente che precede lo spazio principale, o anticamera, custodisce, sulle pareti opposte di destra e di sinistra, rispettivamente i monumenti di Stefano [Fig. 1] e Tiberio Cerasi [Fig. 2].
Le due tombe si presentano analoghe nel formato: a una cornice quadrangolare, che inscrive una placca di marmo sulla quale è incisa una lunga iscrizione commemorativa, viene assommato un timpano emiciclico spezzato, interrotto dal busto del defunto, leggermente aggettante ed inserito in una cornice ovale in marmo. In un contributo degli anni Cinquanta per il “Burlington Magazine”, Leo Steinberg accetta una proposta già avanzata da Bruhns, il quale aveva individuato proprio nell’aggetto dei due busti una novità di concezione nella scultura funeraria dell’epoca: rivolgendosi all’altare, essi intrecciavano con l’ambiente in cui si inserivano un rapporto di “perpetua adorazione”[1]
La volta
Stando a Giovanni Baglione, sia le lunette laterali [Figg. 3 - 4] che la piccola volta a botte dell’anticamera della cappella Cerasi [Fig. 5] vennero dipinte a fresco dal pittore novarese Giovanni Battista Ricci:
“Alla Madonna del Popolo dentro la cappella de’ Cerasi (tra l’altar maggiore, e l’altra cappella di Santa Catherina di figure di stucco, e di pitture da Giulio Mazzoni Piacentino abbellita) il Novara ha la volta di quella a fresco con varii Santi colorita”[2]
Tra i “varii santi” di cui ci informa il Baglione, quelli illustrati sulle lunette sono Padri della Chiesa. La lunetta di destra è abitata da Ambrogio, al quale un angelo sul retro porta la mitria, e Girolamo, affiancato dal leone che, secondo la leggenda, venne da questi guarito dai rovi. Sul lato opposto, la colomba si poggia sulla spalla di Gregorio Magno, incoronato da un angelo con la tiara pontificia, mentre Agostino risulta identificabile dal saio nero dell’ordine.
Nella volta vera e propria, separati da stucco dorato, i quattro Evangelisti, affiancati dai consueti simboli iconografici (toro, leone, angelo ed aquila) si radunano invece attorno al tondo centrale con la colomba dello Spirito Santo.
Le pale laterali di Caravaggio
Come è noto dai documenti, già menzionati nel precedente elaborato, Caravaggio si impegnava, il 24 settembre 1600, nel portare a termine, entro otto mesi, due grandi quadri su legno di cipresso di dieci palmi per otto (233 x 178 cm ca.). La scelta da parte di Cerasi del cipresso in luogo della tela era dovuto alle caratteristiche fisiche delle sue fibre le quali, molto resinose, impedivano le infiltrazioni d’acqua[3]. Successivamente, anche Annibale decise di adottare il formato ligneo per la sua Assunta.
Sempre dal contratto conosciamo i soggetti delle due pale: dagli accordi Caravaggio avrebbe dovuto collocare su di una parete una Crocifissione di San Pietro, e dirimpetto ad essa una Conversione di Saulo. Giovanni Baglione, tra i primi biografi del Merisi, ci dice, nella vita dedicata al pittore, che
“Nella Madonna del Popolo a man dritta dell’altar maggiore dentro la cappella de Signori Cerasi su i lati del muro sono di sua mano la Crocifissione di s. Pietro; E di rincontro ha la Conversione di s. Paolo. Questi quadri prima furono lavorati da lui in un’altra maniera, ma perché non piacquero al Padrone, se li prese il Cardinale Sannesio; e lo stesso Caravaggio vi fece questi, che hora si vedono, a olio dipinti, poiché egli non operava in altra maniera; e (per dir così) la Fortuna con la Fama il portava”[4]
I quadri originariamente concepiti per la cappella, dunque, non vennero mai installati in loco e nel 1642 – data di pubblicazione delle Vite – si trovavano nella raccolta del cardinal Sannesio, che ottenne la porpora nel 1604[5]. Sui motivi che spinsero “il Padrone” a sostituire le prime pale la critica non è ancora giunta ad un accordo: Roberto Longhi, tra i massimi studiosi del Caravaggio e tra i principali artefici della sua riscoperta critica nel secolo scorso, ipotizzò che la sostituzione delle tavole fu voluta dal pittore stesso, maggiormente a suo agio con la pittura ad olio[6] che provvide a dotare di un’armatura di travi lignee che “isolassero” la tela dalla parete[7]. Luigi Spezzaferro, altro grande studioso del Caravaggio, ritenne invece che in seguito alla sostituzione delle tavole Cerasi avrebbe trovato un nuovo accordo economico col Merisi, il quale – nell’ipotesi di Stephen D. Pepper – avrebbe sentito sulle sue spalle il peso della sfida “gomito a gomito”[8] con Annibale andando così a sostituire delle prove che, a suo giudizio, non erano all’altezza dell’Assunzione del bolognese[9], per il quale, del resto, non aveva mai nascosto una sincera ammirazione. Circa la pala con Santa Margherita, commissionata ad Annibale per la chiesa di Santa Caterina dei Funari da monsignor Gabriele Bombasi, Bellori scrisse che
«Michel Angelo da Caravaggio dopo essersi fermato lungamente a riguardarlo, si rivolse, e disse: mi rallegro che al mio tempo veggo pure un pittore, intendendo egli della buona maniera naturale, che in Roma, e nell’altre parti ancora affatto era mancata[10]»
Qualunque sia il motivo dietro la sostituzione delle opere originarie, sta di fatto che, al 1604, esse erano già nella casa del Sannesio. Il nipote del cardinale, Francesco, unico erede dei beni Sannesio, vendette i “doi quadri grandi in tavola che rappresentano san Pietro crocifisso e l’altro la Conversione di san Paolo scorniciati e filettati d’oro” (presenti nell’inventario del 1644) a Juan Alfonso Enriquez de Cabrera[11]. Mentre l’originaria Crocifissione è andata perduta, la Conversione venne acquistata nel 1682 da Francesco Maria Balbi per poi finire nella collezione Balbi Odescalchi di Roma [Fig. 6].
Nella prima versione del dipinto, Caravaggio narra l’episodio riportato in più momenti negli Atti degli Apostoli (9, 1 – 9; 22, 6 – 11; 26, 12 - 18). Nella pala Odescalchi Saulo, scalzato dalla cavalcatura, porta le mani al volto, incapace di sopportare la luce divina in tutto il suo fulgore. Negli Atti non si fa menzione della presenza effettiva, corporea di Cristo, bensì solo della sua voce:
“Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: “Che devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e prosegui verso Damasco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco.”
(Atti degli Apostoli, 22, 6 – 11)
La presenza fisica di Cristo, pur non essendo attestata dalle fonti scritte, può tuttavia vantare una grande fortuna nel panorama artistico nazionale[12] (si pensi a uno degli arazzi disegnati da Raffaello per la Sistina, o all’affresco di Michelangelo nella Cappella Paolina).
La conversione di Saulo
Incrociando la Conversione Odescalchi con la seconda versione su tela [Fig. 7], collocata sulla parete destra della cappella, si fatica a trovare un’espressione più sintetica ed efficace di quella data dal Bellori, che nella vita del pittore parla a buon diritto di una
“historia affatto senza attione”[13]
Già da una prima ricognizione le parole dello storico risultano estremamente calzanti: Saulo sembra quasi accogliere, e non fuggire, l’emanazione di luce che lo colpisce. Del resto, anche la caduta pare attenuarsi in quanto a forza, ben lontana dal disarcionamento violento, da quel dramma temporaneo che nella pala Odescalchi si consuma in un istante. Il futuro principe della Chiesa spalanca le braccia, tiene chiusi gli occhi; il soldato, che nella Odescalchi non esitava a puntare la picca contro il Salvatore, qui pare aver deposto per sempre la lancia ritirandosi a vita privata nei campi. È una conversione che si consuma in una stalla, la “conversione di un cavallo”, come ebbe a dire anche Roberto Longhi, in cui anche le brevi reminiscenze paesistiche, che avevano accompagnato il Merisi sin dai primi tempi, si dissolvono nella più pacata ombra notturna.
Le indagini radiografiche effettuate sul dipinto hanno svelato una prima idea compositiva, sempre a colore, per la figura del santo, più anziano e ancora in atto di coprirsi il volto dal misterioso bagliore[14].
La crocifissione di Pietro
Sulla parete fronteggiante la Conversione, Caravaggio fece collocare l’episodio centrale della vita dell’apostolo Pietro, ovvero la sua crocifissione. Condannato al martirio da Nerone, Pietro riuscì a fuggire dal carcere. Imbattutosi, lungo la via Appia, in Cristo in persona, gli domandò dove fosse diretto (l’episodio noto come Domine quo vadis?, frescato da Innocenzo Tacconi sulla botte della volta). Cristo, accusandolo di pavidità e vigliaccheria, gli disse che sarebbe stato disposto a farsi crocifiggere una seconda volta. Fu a quel punto che Pietro ritornò sui suoi passi e, non considerandosi degno di un epilogo simile a quello del suo maestro, si fece crocifiggere a testa in giù. Nella pala Cerasi Caravaggio sceglie di immortalare il momento esatto in cui degli ignari mestieranti stanno per tirare su la croce. Pietro, il cui sviluppo diagonale bilancia la direttrice uguale e contraria dei due aguzzini, sembra ripensare fino all’ultimo ai continui e immeritati tradimenti nei confronti di Gesù. È una morte che porta con sé un pentimento inascoltato, un lamento sordo ai torturatori, indifferenti e indaffarati in una qualsiasi giornata di lavoro.
Note
[1] L. Steinberg, Observations in the Cerasi chapel, p. 184.
[2] G. Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, p. 149.
[3] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 514.
[4] G. Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, p. 137.
[5] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 515.
[6] R. Longhi, Caravaggio, p. 55.
[7] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 515.
[8] E. Riccomini, Annibale studiosa letizia di dipingere all’italiana, p. 4.
[9] Stephen D. Pepper, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, p. 111.
[10] G. P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, p. 32.
[11] L’inventario dei beni di Francesco Sannesio è contenuto anche in L. Spezzaferro, Caravaggio, Carracci, Maderno. La Cappella Cerasi in S. Maria del Popolo a Roma, p. 111.
[12] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 528.
[13] G. P. Bellori, Le vite, p. 207.
[14] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 528.
Bibliografia
AA.VV., Caravaggio, Carracci, Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Milano, Silvana, 2001.
Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, Roma, Andrea Fei, 1642.
Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, per il success. al Mascardi, 1672.
AA.VV., The Drawings of Annibale Carracci, Washington, National Gallery of Art, 1999.
Daniele Benati, Eugenio Riccomini (a cura di), Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006.
Maurizio Calvesi, Caravaggio, “Art Dossier”, Firenze, Giunti, 1986.
Roberto Longhi, Caravaggio, Roma, Editori riuniti, 1982.
Denis Mahon, Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington Magazine”, vol. 93, no. 580, Londra, Burlington Magazine Publications, pp. 222-235.
Stephen D. Pepper, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, in AA.VV., Studi di storia dell’arte in onore di Denis Mahon, Milano, Electa, 2000, pp. 109-122.
Orietta Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino, Einaudi, 2014.
Leo Steinberg, Observations in the Cerasi Chapel, in “The Art Bulletin”, vol. 41, no. 2, New York, College Art Association, pp. 183-190.
Claudia Viggiani, La cappella Cerasi, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009, pp. 511-531.
Rudolf Wittkower, Arte e Architettura in Italia. 1600 – 1750, Torino, Einaudi, 2018.
Roberto Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, in “Melanges de l’ecole francaise de Rome”, 93 – 2, Roma, Ecole Francaise de Rome, 1981, pp. 821 – 822.
Sitografia
http://www.smariadelpopolo.com/it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tiberio-cerasi_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-merisi_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ricci_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-tacconi_(Dizionario-Biografico)
Riferimenti fotografici
Fig. 1 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75063979
Fig. 2 - By Never covered - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46859047
Fig. 3 - Di Sailko - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76699471
Fig. 4 - Di Sailko - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76699470
Fig. 5 - Di Giovanni Battista Ricci (Italian painter, 1537 – 1627) - Carlos Goulão, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46860406
Fig. 6 - By Caravaggio - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10293565]
Fig. 7 - By Sailko - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76699462
Fig. 8 - By Caravaggio - Credits: By Sailko - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76699469
LA CAPPELLA CERASI IN SANTA MARIA DEL POPOLO
A cura di Andrea Bardi
I prossimi due elaborati vorranno fornire al lettore un approfondimento sulla cappella di Tiberio Cerasi nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, ristrutturata in maniera decisiva agli inizi del XVII secolo. A un primo elaborato, maggiormente focalizzato sugli aspetti storico – documentari di tale riconfigurazione, ne seguirà un secondo, all’interno del quale verranno invece presentati gli interventi pittorici veri e propri.
Introduzione
La cappella di Tiberio Cerasi, tesoriere della Camera Apostolica, nella chiesa di Santa Maria del Popolo entra a buon diritto nel novero dei luoghi d’elezione dell’arte romana del Seicento, fornendo indicazioni utilissime a comprendere quale fosse, a cavallo dei due secoli, lo stato della pittura nell’Urbe. Nell’ultimo decennio del Cinquecento, infatti, la scena culturale romana era stata scossa dall’arrivo di due forestieri, Michelangelo Merisi e Annibale Carracci. Se quest’ultimo tentò di fondere i particolarismi locali (la Parma di Correggio, la Venezia di Veronese) in un linguaggio pittorico “nazionale” che – dopo aver metabolizzato, dalla metà degli anni Ottanta del Cinquecento in poi, stimoli eterogenei – aveva bisogno degli ultimi tasselli (Michelangelo e Raffaello) per giungere alla suprema sintesi figurativa, per il primo non è peregrino affermare che l’assoluta fedeltà al vero naturale – che connotava, del resto, in maniera preponderante anche l’indagine grafico-pittorica di Annibale – non poteva, e non doveva in alcun modo giungere a compromessi con la storia. I due artisti, entrambi reduci da commissioni di assoluto livello (La cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi per Caravaggio, con tre episodi della vita dell’apostolo Matteo; la volta a fresco della galleria di Odoardo Farnese per Annibale) furono messi l’uno di fianco all’altro, in una sorta di “sfida” implicita tra due diverse concezioni di “vero naturale” che apre il secolo cambiando per sempre la storia dell’arte italiana ed europea. Un rinnovato interesse per il vero che conviveva, però, con il linguaggio “ufficiale”, come notava correttamente Rudolf Wittkower (Arte e architettura in Italia. 1600-1750). Solo dalla consapevolezza di una simile convivenza si può spiegare il tono enfatico che l’anonimo estensore dell’avviso del 2 giugno 1601 riserva tanto alle pale Cerasi quanto agli affreschi del Cavalier d’Arpino, esponente di spicco del tardomanierismo romano, nella Sala degli Orazi e dei Curiazi al Campidoglio:
“hora si scorge che Roma fiorisce nella pittura, più che habbia fatto à tempi a dietro; attendendosi hora à finire le tele di Campidoglio dal Cavaliere Giuseppe, li dua quadri che fa il Caravaggio per la Capella del già Mons.r Ceraseo, Tesauriero. Il quadro Principale in essa Capella di d.o Caraccio, essendo insomma quei tre quadri di tutta l’eccellenza, et bellezza”[1]
Storia
Le vicende legate alla cappella vanno fatte risalire alla seconda metà del XV secolo, quando, in concomitanza con la risistemazione dell’intero edificio ecclesiastico promosso da papa Sisto IV, il cardinale veneziano Pietro Foscari decise di stabilire lì il suo monumento funebre. Circa un secolo più tardi, la suddetta cappella fu al centro di una trattativa tra l’allora “tesauriero” della Camera Apostolica, monsignor Tiberio Cerasi, e i padri dell’ordine agostiniano, a cui la chiesa apparteneva dalla metà del Duecento. L’intenzione di Tiberio, riportata nel testamento redatto nel 1598, era di farsi tumulare
“nella Chiesa del Popolo nella sepoltura dove è sepolto mio Padre Madre et Fratello”[2]
Due anni dopo (la proposta arrivò a Cerasi l’8 luglio 1600) furono gli stessi agostiniani ad offrire la cappella,
“existentem in parte superiori versus et iuxta altare maius sub invocatione eiusdem sanctissimae Virginis Mariae, sitam inter cappellam subtus chorum a sinistra, et cappellam illustrissimorum dominorum de Theodolis a dextera manibus, ut illam arbitrio suo ornari curet et faciat”[3]
“scambiandola” con una casa nei pressi di Montecitorio.
Una volta acquisito il vano, Tiberio Cerasi provvide a dotarlo di un apparato architettonico e pittorico moderno (tale libertà di azione gli era stata concessa dagli stessi padri[4]). In primo luogo, egli rimosse l’iscrizione commemorativa al cardinal Girolamo Foscari[5]. Nel settembre dello stesso anno, Cerasi concretizzò i contatti avviati con il Caravaggio pattuendo col pittore una somma di quattrocento scudi, cinquanta dei quali sarebbero stati versati come anticipo dal marchese Vincenzo Giustiniani (grande protettore dalla prima ora del Merisi). L’artista, da parte sua, si impegnava a consegnare, “infra octo menses” (entro otto mesi),
“duo quadra cupressus longitudinis palmor[um] decem et latitudinis octo”
(due quadri in legno di cipresso lunghi dieci palmi e larghi otto)
Le due tavole (223 x 178 cm ca.) avrebbero dovuto illustrare gli episodi centrali della vita degli apostoli Pietro e Paolo, ai quali la cappella era dedicata, ovvero il martirio per crocifissione del primo e la conversione “sulla via di Damasco” per il secondo.
Circa la pala d’altare, non abbiamo testimonianze documentarie del contratto stipulato con Annibale Carracci, autore di un’Assunzione della Vergine. L’unica testimonianza posteriore al contratto con Caravaggio è costituita da una piccola aggiunta al testamento originario, vergata da Cerasi il 2 maggio 1601 (un giorno prima della sua morte[6]) che ci è utile in quanto ci consente di conoscere il nome dell’architetto scelto per la risistemazione architettonica della cappella, Carlo Maderno[7]. Gli ultimi cinquanta scudi vennero versati a Caravaggio – il cui compenso finale venne decurtato di cento scudi per il ritardo nelle consegne – il 10 novembre 1601 dall’Ospedale della Consolazione, ente nominato erede universale della fortuna del Cerasi.
La cappella venne consacrata nel 1606[8], e, sebbene non si abbia una data precisa per la sistemazione dei dipinti al suo interno, questo anno può fornire un prezioso ante quem.
Note
[1] L’avviso è stato pubblicato da R. Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, p. 821.
[2] Le parole del testamento sono riportate anche in L. Spezzaferro (La cappella Cerasi e il Caravaggio, in Caravaggio, Carracci, Maderno, p. 108) e poi in C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 514.
[3] Le parole dell’atto notarile di Luzio Calderini sono state pubblicate nel 1951 da Denis Mahon (Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, p. 226).
[4] “Concedono detti Padri […] la suddetta Cappella con facoltà et autorità che sua Sig.ria Ill.ma possa à suo libero arbitrio et beneplacito, et quando à Lei piacera fabricarla, alzarla, […] la in dietro et ornarla in modo et forma che à lei accomoderà et sarà di soddisfatione tanto in vita et mentre egli viverà, come dopo la sua morte, et quando sua Sig.ria Rev.ma ordinerà et non altrimente” (anche questa parte dell’accordo tra Cerasi e gli agostiniani è riportata in D. Mahon, Egregius in Urbe pictor, p. 226, nota 33).
[5] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 512.
[6] La notizia della morte di Tiberio Cerasi è contenuta nell’avviso del 5 maggio 1601 (“Di roma li 5 di Maggio 1601. Mecordi notte Mons.r Cerasio, Tesauriero Generale di S. ta Chiesa passò all’altra vita, et datoli sepultura nella sua bellissima Capella, che faceva fare nella Madonna della Consolatione, per mano del famosissimo pittore Michel Angelo da Carravaggio; primo che morisse, intendesi habbia giunto un codicillo al suo testamento, fatto un pezzo fa, lasciando Herede delle sue facultà li Padri della Mad.na della Consolatione, con obbligo che debbino far finite la sudetta Capella” (testo contenuto in D. Mahon, Egregius urbe pictor, p. 227, nota 41).
[7] C. Viggiani, La cappella Cerasi, p. 514.
[8] Ivi, p. 515.
Bibliografia
AA.VV., Caravaggio, Carracci, Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Milano, Silvana, 2001.
Giovanni Baglione, Le vite de’ pittori, scultori et architetti, Roma, Andrea Fei, 1642.
Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, per il success. al Mascardi, 1672.
AA.VV., The Drawings of Annibale Carracci, Washington, National Gallery of Art, 1999.
Daniele Benati, Eugenio Riccomini (a cura di), Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006.
Maurizio Calvesi, Caravaggio, “Art Dossier”, Firenze, Giunti, 1986.
Denis Mahon, Egregius in Urbe pictor: Caravaggio revised, in “The Burlington Magazine”, vol. 93, no. 580, Londra, Burlington Magazine Publications, pp. 222-235.
Orietta Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino, Einaudi, 2014.
Claudia Viggiani, La cappella Cerasi, in Maria Richiello, Ilaria Miarelli Mariani (a cura di), Santa Maria del Popolo. Storia e restauri, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009, pp. 511-531.
Rudolf Wittkower, Arte e Architettura in Italia. 1600 – 1750, Torino, Einaudi, 2018.
Roberto Zapperi, Per la datazione degli affreschi della Galleria Farnese, in “Melanges de l’ecole francaise de Rome”, 93 – 2, Roma, Ecole Francaise de Rome, 1981, pp. 821 – 822.
Sitografia
http://www.smariadelpopolo.com/it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tiberio-cerasi_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-merisi_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-ricci_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-tacconi_(Dizionario-Biografico)
LA SALA DELLE NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANE
A cura di Federica Comito
Subito successiva alla Sala delle Prospettive, si trova la camera da letto di Agostino Chigi conosciuta come la Sala delle Nozze di Alessandro e Rossane. Prende il nome dalle storie affrescate che vedono come protagonista Alessandro Magno e la principessa Rossane, figlia di Ossiarte satrapo della Battriana (una regione asiatica corrispondente più o meno all'attuale Afghanistan), che il giovane condottiero sposa nel 327 a.C. La storia scelta era destinata a glorificare il committente Agostino, paragonandolo all'eroe della classicità. Affrescata nel 1518-19, effettuarono i lavori nella sala prima l’architetto Baldassarre Peruzzi e poi il pittore Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Questo incarico offrì al Sodoma la possibilità di entrare a far parte del prestigioso circolo di umanisti di Agostino Chigi. Nella sala colpisce l’elaborato soffitto a cassettoni con forme geometriche dorate e blu che incorniciano dodici piccoli riquadri rappresentanti scene dalle Metamorfosi di Ovidio alternate a decorazioni vegetali. Disegnato da Baldassarre Peruzzi, è stato eseguito poi da Maturino da Firenze aiutato probabilmente da un giovane Polidoro da Caravaggio. Al centro si trova lo stemma araldico di Agostino Chigi su fondo azzurro.

Gli affreschi della Sala delle Nozze
Sulle pareti sono affrescate alcune significative scene della breve vita del condottiero Alessandro Magno, morto a soli 33 anni.
Sull’intera parete nord della Sala delle Nozze è raffigurata la scena, particolarmente conosciuta e che dà il nome alla stanza, delle Nozze di Alessandro e Rossane. Nell'affresco sono frequenti i richiami al tema matrimoniale, dai puttini alati alla fiaccola accesa sostenuta dal dio Imeneo, emblema delle nozze, ritratto alle spalle del seminudo Efestione, fedele compagno del condottiero macedone. Da notare i giochi prospettici: in basso una sorta di balaustra dietro la quale si vede un pavimento in prospettiva con Alessandro che porge la corona alla bellissima sposa; sul fondo del padiglione del letto c’è uno specchio - tipico della cultura fiamminga - che ingrandisce otticamente la stanza; un loggiato sulla destra dona profondità alla scena. Il letto, probabilmente, riprendeva quello realmente presente nella camera, costato 1592 ducati perché realizzato in oro, avorio e pietre preziose. L'affresco con le Nozze di Alessandro e Rossane era il più importante perché dedicato al matrimonio tra Agostino e Francesca, ma anche il più difficile da realizzare in quanto avrebbe dovuto ricreare un antico dipinto del pittore greco Aezione. Purtroppo però tale dipinto non esisteva più, e non ne erano neppure reperibili delle copie. Per ricostruirlo si dovette far fronte a una descrizione letteraria contenuta nell'Erodoto dello scrittore latino Luciano. Il testo, in greco, venne tradotto in latino nel 1503, ma stampato e diffuso solo dopo il 1529. Secondo alcuni storici è probabile che inizialmente Agostino Chigi avesse affidato a Raffaello il compito di dipingere questa camera, infatti in alcuni passi dei trattati di Dolce e Lomazzo si accenna ad un disegno realizzato dal Sanzio ad acquerello e biacca con le storie di Alessandro il Grande. Tuttavia Raffaello in quel momento era già impegnato ad affrescare la Loggia di Psiche perciò l'incarico passò al Sodoma, già conosciuto dalla famiglia Chigi in quanto aveva lavorato a Siena per Sigismondo, fratello di Agostino. Prendendo in esame lo studio di Raffaello, il Sodoma ridefinì la composizione, seguendo scrupolosamente il testo letterario e arricchendo la scena di elementi narrativi. La mano raffaellesca è ancora evidente, come nella donna con la brocca a sinistra, ripresa dall'Incendio di Borgo nell’omonima Stanza Vaticana, ma anche nelle architetture tipicamente bramantesche e nella dilatazione spaziale. Il Sodoma però effettua anche interessanti variazioni personali, dettate dai suoi studi archeologici: la figura di Alessandro deriva dalla conoscenza dell'Apollo del Belvedere, quella di Vulcano ripropone il movimento ricco di tensione e dramma del Laocoonte.
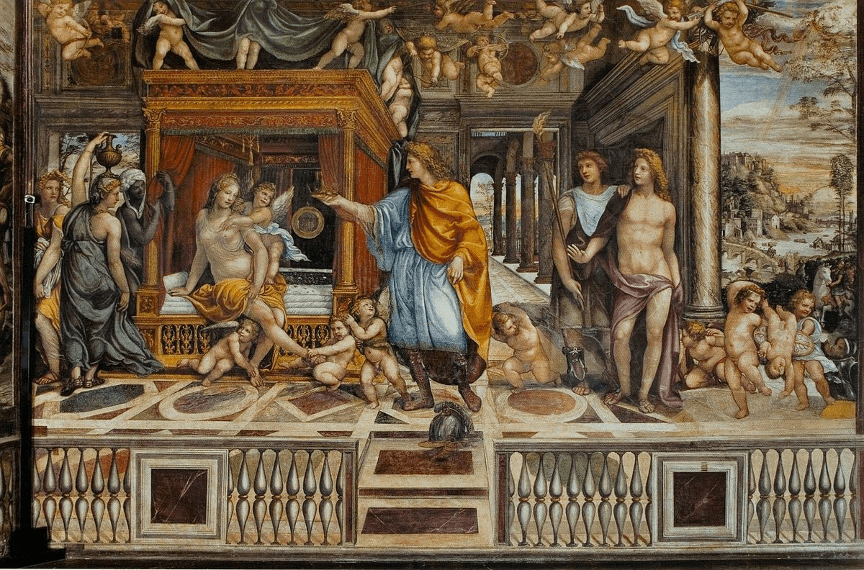
Sulla parete successiva è raffigurato Alessandro Magno che doma Bucefalo, dipinto in cui è riconoscibile, specialmente nella parte destra, la mano di un collaboratore. Si pensa che questo affresco sia stato realizzato per coprire i buchi lasciati dalla rimozione del letto a baldacchino che doveva trovarsi ancorato proprio a quella parete. Pare invece che il lato sinistro sopra l’entrata, dove si intravede sullo sfondo la Basilica di Massenzio e in primo piano la Lupa con Romolo e Remo, sia da attribuire al Sodoma.
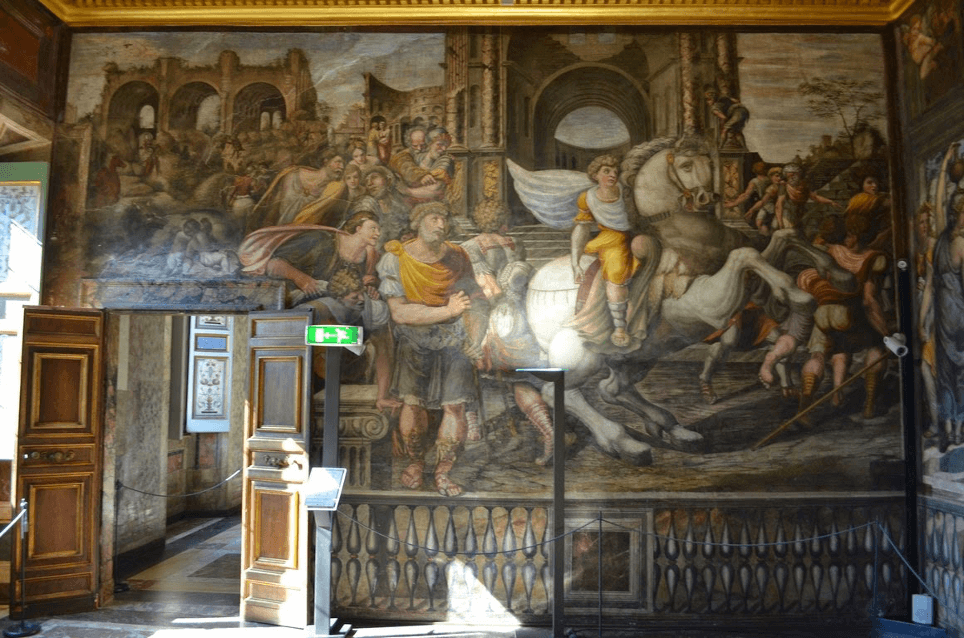
Nella parete tra le due finestre è affrescata una scena di battaglia con un paesaggio di campagna romana che si perde all'orizzonte, visto, anche in questo caso, oltre un parapetto come se ci si affacciasse sulla battaglia.
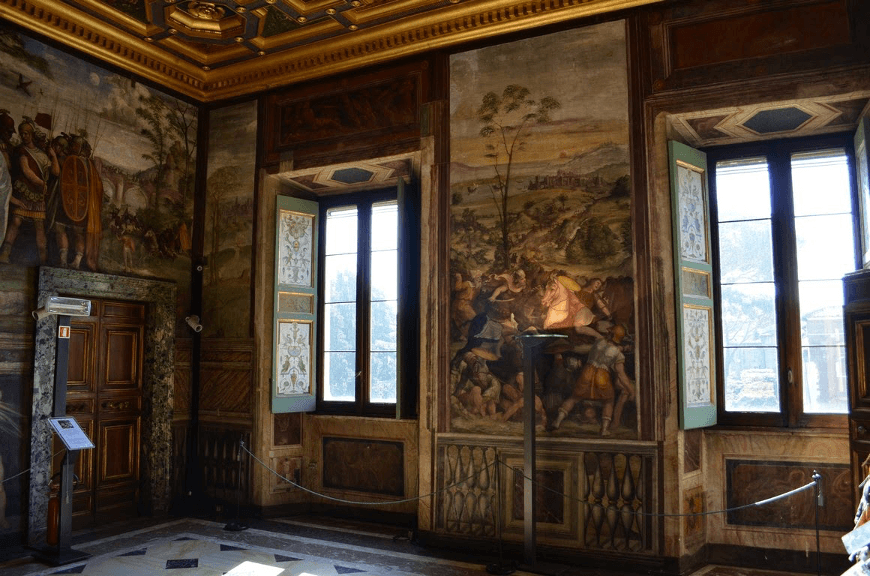
Sulla parete destra è dipinta la Clemenza di Alessandro Magno nei confronti della famiglia di Dario, il re persiano sconfitto: Alessandro Magno, dopo la battaglia, riceve e perdona la vedova e le figlie del rivale. Tra le figure femminili si è voluta riconoscere una donna ispirata alla Galatea di Raffaello. Sotto l’affresco si trova il camino e ai lati è affrescata la fucina di Vulcano. Il dio si trova nella sua bottega a forgiare le frecce dell'amore per Cupido: è chiara l'associazione tra la fucina del dio e l'allume vulcanico alla base della ricchezza di Chigi, ma anche la volontà di alimentare il fuoco dell'amore. Infatti Chigi soffriva di idropisia (termine oggi sostituito da anasarca) che, in alcuni casi, influenza le prestazioni sessuali. Questo potrebbe quindi essere collegato all'approccio rinascimentale alla medicina, che coinvolgeva la teoria degli Umori secondo cui il loro squilibrio causava malattie. Pertanto l’incendio della fucina contrasterebbe l'effetto negativo dell’acqua legato all’idropisia.
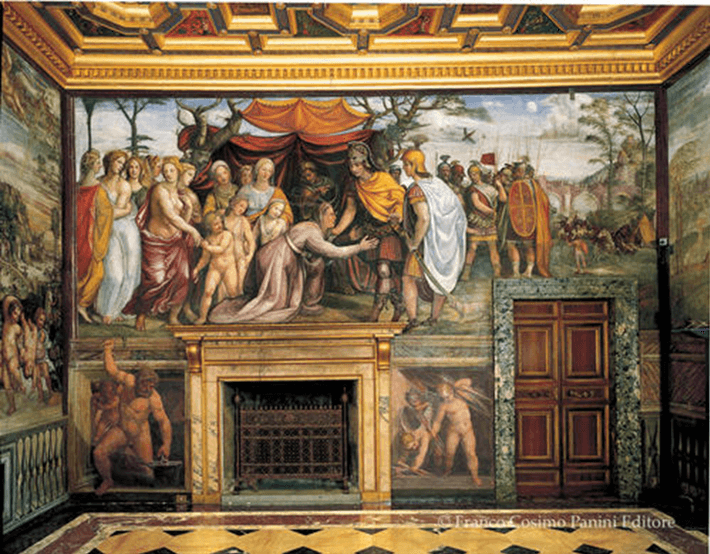
Esiste anche una diversa lettura di questi affreschi del Sodoma che si basa sull’ermeneutica alchemica, citando le quattro fasi della Grande Opera (nigredo, rubedo, citrinitas, albedo; rispettivamente annerimento, sbiancamento, ingiallimento e arrossamento) descritte con simboli crittografici. Conosciuta in latino come Magnum Opus, la Grande Opera è l'itinerario alchemico di lavorazione e trasformazione della materia prima, finalizzato a realizzare la pietra filosofale.
Imperia e Francesca
Secondo una teoria meno considerata l’intera Villa, e in particolare la Sala delle Nozze, sarebbero stati realizzati non per Francesca Ordeaschi ma per omaggiare Imperia, una cortigiana di cui Chigi si era innamorato prima di conoscere Francesca. Imperia era considerata la donna più bella di Roma, al pari di una dea, però non era felice. Innamorata, infatti, di un nobile romano, Angelo Del Bufalo, non poteva sposarlo perché l’uomo era già coniugato. Quindi, dopo l’ennesimo litigio con l’amante, decise di uccidersi, assumendo un veleno mortale: a nulla valsero le cure dei medici più famosi di Roma chiamati da Agostino Chigi. Dopo due giorni di dolorosa agonia, Imperia morì. Agostino finanziò un maestoso funerale a Roma, sensazionale per una cortigiana. Il suo monumento funebre a San Gregorio al Celio non è sopravvissuto fino ai giorni nostri.
Questa sala, conosciuta come la "Camera delle Nozze", è stata incessantemente associata alla decisione di Chigi di sposare la veneziana Francesca Ordeaschi nel 1519, quando Imperia era già morta. Tuttavia recentemente è stato pubblicato un ritratto di Imperia e, se questo ritratto presenta le reali fattezze della donna, gli stessi lineamenti del viso possono essere chiaramente osservati in Rossane, in Galatea nel Trionfo di Galatea e in Venere nel pennacchio con Venere e Psiche nella Loggia di Psiche.
Quindi lo schema unificante per i dipinti di Villa Farnesina raffigurerebbe il grande amore di Chigi per una cortigiana, culminante in questa stanza finale, dove egli, attraverso la fantasia, potrebbe negare la realtà dei fatti e vivere un matrimonio immaginario, non reale, incarnato in parte nell'iscrizione originale che correva attorno alle pareti:
Vale et dormi; somnus enim otium est. Animae felices a miseris in dimidio vitae non differunt
(Addio e sonno; veramente nei sogni c'è tempo libero / pace / quiete / riposo. Gli spiriti della fortuna e della miseria nella vita vengono mandati via ma non dispersi.)
Nella Stanza delle Nozze tutto viene spazzato via a favore di una vita di fantasia, l'illusione del sogno dell'antichità e della classicità, dove tutto è bello oltre che eterno. Questo può forse essere il significato di fondo di uno dei tanti elogi a Imperia in occasione della sua morte, dove Chigi è identificato con l'Impero e Imperia con Venere e la loro storia d'amore elevata a un mito della Roma rinascimentale:
Dii duo magna dederunt munera Romae: Imperium Mavors et Venus Imperiam ... Hos contro steterunt Mors et Fortuna, rapitque Fortuna imperium, mors rapit Imperium. Imperium luxere patres, nos luximus ipsi hanc: Illi orbem, nos nos cordaque perdidimus.
(Gli dei fecero a Roma due grandi doni: Marte le diede l'Impero e Venere [diede] Imperia ... La morte e la fortuna erano contro di loro: la fortuna portò via l'Impero e la morte [prese] Imperia. I nostri padri piansero sull'Impero e noi piangemmo troppo su di lei: persero [l'Impero] mentre noi perdemmo il cuore.)
Così il poeta Giano Vitale piange la morte della cortigiana nell’Imperiae panegyricus nel 1512, anno della morte della fanciulla.
Conclusione
Si tratta della storia d’amore tra una ragazza di rango inferiore, anche in questo caso, e un uomo di successo, come la storia d’amore tra Francesca Ordeaschi e Agostino, perché anche Imperia era una cortigiana. Gli affreschi dipinti dal Sodoma raccontano delle nozze tra Alessandro Magno e Rossane, prima prigioniera e poi sposa. La scelta non è casuale, infatti gli affreschi non servono solo ad elogiare il matrimonio ma anche l’ascesa della moglie, Francesca Ordeaschi, da amante a moglie legittima. Quest’ultima versione è quella generalmente accolta.
Gli affreschi della Stanza, ritoccati da Carlo Maratta alla fine del ‘600, vennero restaurati nel 1974-1976 grazie ad un nuovo e fondamentale restauro.
Bibliografia
“A Fantasia Of Pagan Myth In The Villa Farnesina: Agostino Chigi’s Homage To His Lover, Imperia”, in Pagans and Christians- from Antiquity to the Middle Ages, ed., Lauren Gilmour, British Archaeological Reports, International Series 1610
Terenzio, La Farnesina, in “Bollettino d’arte del Ministero della Educazione Nazionale”, n. 24, 1930/31, pp. 76-85
Sitografia
http://www.travelingintuscany.com/arte/ilsodoma/villafarnese.htm
ww.villafarnesina.it
https://www.youtube.com/watch?v=eXPhhjkGLsI
PALAZZO BARBERINI A ROMA
A cura di Maria Anna Chiatti
Palazzo Barberini: il casato, il progetto e la fabbrica
La storia dell’intera famiglia Barberini sarebbe, come facilmente si intuisce, troppo lunga e perigliosa da affrontare in una trattazione come questa, quindi ci si limiterà a delineare soltanto le vicissitudini di alcuni personaggi, in particolare di Maffeo Barberini, ben più noto con il nome di papa Urbano VIII. Il prestigio che prima il cardinalato e poi la tiara valsero all’intero casato, sta alla base delle motivazioni che portarono alla costruzione di uno dei palazzi più belli di Roma, nel XVII secolo così come oggi.

Il casato e lo stemma
Maffeo Virginio Romolo Barberini (1568 – 1644, fig. 1), quinto dei sei figli di Antonio Barberini (M. 1571) e di Camilla Barbadori (M. 1609), nacque il 5 aprile 1568 a Firenze, dove sette anni prima si erano trasferiti i suoi avi, commercianti di tessuti, oriundi di Barberino di Val d’Elsa; da questo luogo proviene anche il cognome della famiglia, che ab origine era Tafani.
Alla prematura scomparsa del padre l’educazione dei figli fu affidata a Camilla sotto la tutela del cognato Francesco Barberini (1528 - 1600), il primo laureato, sacerdote e prelato della famiglia, allora protonotario apostolico presso la Curia romana.
Maffeo svolse studi umanistici presso il Collegio fiorentino dei gesuiti e nel 1584 si trasferì a Roma su invito dello zio per frequentare il Collegio romano e perfezionare gli studi; due anni più tardi si recò all’Università di Pisa, dove si laureò il 7 aprile 1588 in utroque iure [1]. Dopo il ritorno a Roma si occupò soprattutto dell’amministrazione dei beni e degli affari dello zio impegnato nel mercato di compravendita degli uffici vacabili: Francesco comprò per il nipote numerosi e costosi uffici, grazie ai quali questi poté fare carriera all’interno della Curia pontificia. Nel 1593 lo zio rinunciò al protonotariato in favore di Maffeo, che qualche anno più tardi riuscì anche ad ottenere la carica di chierico di Camera, un promettente trampolino di lancio per raggiungere il cardinalato.
Il 28 maggio 1600 morì lo zio Francesco, lasciandolo come unico erede fiduciario.
Grazie all’enorme ricchezza ereditata, a Maffeo furono conferiti da Clemente VIII (1536 - 1605) incarichi dispendiosi ma molto prestigiosi: la nunziatura straordinaria ricevuta nel 1601 lo portò alla corte di Parigi, dove instaurò ottimi rapporti con il mondo politico e culturale francese.
La carriera del nostro ebbe poi sviluppi assai rapidi: nel settembre del 1604 fu ordinato sacerdote e ad ottobre era già arcivescovo titolare di Nazareth (seppure questa fosse una nomina sui generis, perché l’arcivescovato di Nazareth era unito a quello di Barletta e ne condivideva le esigue entrate). A novembre fu ufficialmente nominato nunzio ordinario alla corte di Francia, dove rimase per tre anni; l’11 settembre 1606 papa Paolo V (1552 - 1621) promosse Maffeo al cardinalato, e il 14 ottobre a Fontainebleau il re di Francia Enrico IV (1553 - 1610) consegnò il berretto rosso al nuovo cardinale alla presenza della corte reale.
A seguito di questa nomina i tre tafani che avevano finora popolato lo stemma della famiglia vennero sostituiti con altrettante, più nobili, api (Figg. 2-3).
Il Cardinal Barberini non prese più residenza nella “Casa Grande” in via dei Giubbonari perché il palazzo risultava troppo piccolo per le sue esigenze: nel 1620 la famiglia contava quarantasei persone, e gli stretti vicoli di accesso non consentivano l’agevole passaggio delle carrozze. Durante i soggiorni romani, perciò, egli usava affittare prima il palazzo Salviati in piazza del Collegio romano, poi il palazzo Madruzzo in Borgo.
Quando il 19 luglio 1623, undici giorni dopo la morte di Gregorio XV (1554 - 1623), iniziò il conclave per la nomina del nuovo pontefice, l’orizzonte si delineava incerto perché dei cinquantacinque cardinali che parteciparono al conclave, almeno quindici erano ritenuti papabili: le tre fazioni in concorrenza, numericamente equivalenti, erano formate dai rapporti di clientela che le legavano alla casa Aldobrandini o Borghese o Ludovisi, piuttosto che da appartenenze politiche filofrancesi o filospagnole. Dopo diciassette giorni di inutili scrutini, mentre il caldo estivo si faceva insopportabile e dilagava fra i conclavisti una febbre infettiva (che dopo qualche tempo ne avrebbe uccisi quaranta), finalmente si raggiunse un compromesso fra le fazioni Borghese e Ludovisi: la mattina del 6 agosto si arrivò all’elezione del Cardinal Barberini con cinquanta voti su cinquantaquattro.
Maffeo assunse il nome di Urbano VIII.
Palazzo Barberini: dal progetto alla fabbrica
L’elezione al soglio pontificio di Maffeo determinò quindi per l’intera famiglia la necessità di avere una residenza romana adeguata al nome di Sua Santità per immagine e dimensioni.
Se in un primo momento si pensò di ampliare la “Casa Grande” in via dei Giubbonari attraverso l’acquisto di edifici attigui, ben presto fu palese la necessità di costruire una dimora che fosse nuova e più rappresentativa rispetto alla casa in cui vivevano Carlo Barberini (1562 - 1630, fratello di Maffeo) e la famiglia dal loro arrivo a Roma all’inizio del secolo.
Quasi tutte le proposte presentate si riferivano alla proprietà sulle pendici del Quirinale che Francesco Barberini (1597-1679, figlio di Carlo) aveva acquistato nel 1625 da Alessandro Sforza, tenendo conto dell’edificio già presente in quel sito: un lungo e stretto corpo di fabbrica a due piani, risultato di parecchi ampliamenti (l’ultimo dei quali molto recente) dell’originario casino di metà Cinquecento.
I primi progetti contemplavano tutti la tipica struttura fiorentino - romana del palazzo con corte centrale, come si può osservare in un codice dell’Archivio Barberini (Barb. Lat. 4360), o nel disegno di Carlo Maderno (1556 - 1629) conservato a Stoccolma, o ancora nella prefigurazione che compare nella pianta di Giovanni Maggi del 1625 [2]. In tutti questi esempi il casino Sforza veniva inglobato nella fabbrica come uno dei lati che circondano la corte centrale quadrata, e la scelta di mantenere la preesistenza prevalse poi anche nel progetto definitivo, avviato nel 1628: un progetto che si discostava sostanzialmente da tutte le proposte precedenti, “imponendosi come un caso di innovazione tipologica tra i più straordinari nella storia dell’architettura italiana” [3].
Il palazzo fu pensato come un volume compatto, ma sviluppato in avancorpi che ne racchiudessero sia la facciata est verso il giardino che, più profondamente, la facciata ovest verso la strada Felice (oggi via delle Quattro Fontane). Questo prospetto occidentale è una bellissima finta loggia a tre piani, e all’epoca della sua costruzione era in dialogo sia con i prospetti sul cortile e sul giardino di palazzo Farnese che con la quattrocentesca loggia delle Benedizioni a San Pietro, demolita nel 1610 [4].
Appropriato a un sito suburbano, l’impianto con avancorpi consentiva un riutilizzo semplice e meno costoso della preesistenza Sforza. Inoltre è possibile che Urbano VIII e Francesco volessero conferire alla dimora di famiglia un aspetto simile ai contemporanei palazzi francesi: anche il “Cardinal nepote” aveva infatti trascorso un periodo in Francia nel 1625, e aveva potuto ammirare edifici come lo château Blérancourt (1612-1618) e il palais du Luxembourg (dal 1615), opere recenti di Salomon de Brosse (1571 - 1626) che presentavano la corte d’onore aperta tra corpi sporgenti.
Con questa struttura Palazzo Barberini avrebbe saputo assolvere una duplice funzione di dimora di rappresentanza e villa di otium.

Quando si arrivò alla definizione della pianta, la famiglia si affidò al settantenne Maderno, l’architetto più famoso di Roma, al quale tuttavia furono date precise direttive. Il Maestro va quindi considerato autore delle linee essenziali del progetto, dell’assetto e degli ornati degli spazi conclusi finché egli era in vita, quindi l’ala nord (Fig. 4, le cui fattezze sono replicate nell’ala sud), la facciata est (Fig. 5, quella sul giardino) con il corpo centrale come arco di trionfo, e i primi due livelli della loggia a ovest (Fig. 6).
Consulente dei Barberini, sin dall’inizio dei lavori, fu Gian Lorenzo Bernini (1598 -1680); artista già affermato e pupillo di papa Maffeo, è possibile che sia stato lui a suggerire al collega Francesco Castelli (altresì noto come Borromini, 1599 - 1667) l’iconico tema dell’ovale trasverso sia per la sala verso il giardino che per la scala sud, ancora circolare in un disegno di Borromini [5].
Bernini, al quale fu affidata la direzione dei lavori dopo la morte di Maderno, completò la loggia della facciata ovest con un terzo livello, e si può individuare il suo stile anche nelle finestre a edicola ionica delle campate di collegamento tra loggia e ali, e in alcuni portali e camini delle sale interne; tuttavia in questa nuova fase della fabbrica si manifestò anche, per la prima volta in piena autonomia, il linguaggio decorativo profondamente originale di Francesco Borromini, del quale Bernini, prima di rompere con il collega alla fine del 1632, accettò i disegni per i portali minori del salone centrale e per le finestre quadrate del terzo livello della facciata occidentale (Fig. 7).

L’accesso al palazzo avveniva sia da piazza Grimana (l’odierna piazza Barberini), percorrendo un viale in salita che portava all’adito nord, oppure si poteva entrare da via Felice direttamente nella corte occidentale. Quest’ultimo è anche l’ingresso odierno, cui si accede mediante la cancellata progettata dall'architetto Francesco Azzurri (1827-1901) nel 1848, realizzata poi nel 1865, con i grandi telamoni scolpiti da Adamo Tadolini (1788–1868, Fig. 8).
Dal cortile si può godere della bellissima facciata, formata da sette campate che si ripetono su tre livelli di arcate sostenute da colonne che ripropongono i tre stili classici (dal basso dorico, ionico e corinzio, Fig. 9). Tramite le arcate del pianterreno si accede al grande portico, articolato in due file di sette e cinque campate coperte a volta (Fig. 10); qui, al centro, si apre una scala che porta ai giardini, sistemati ad un livello più alto del piano terra. Questo spazio coperto consentiva ai Barberini e ai loro ospiti di accomodarsi nel palazzo scendendo dalle carrozze al riparo dalle intemperie e servendosi dello scalone a pozzo quadrato a nord (il cosiddetto Scalone di Bernini, Fig. 11), o di quello elicoidale a sud, la scala del Borromini (che era riservata ad una circolazione più privata, meno di rappresentanza, Figg. 12 e 13). Le due scale monumentali costituiscono le porzioni mediane degli avancorpi accostati all’edificio centrale, secondo un principio estetico e funzionale; la forma del palazzo risulta quindi essere una “H”, in cui l’avancorpo a nord è costituito dal palazzetto Sforza.
Gli ambienti erano così distribuiti: l’ala settentrionale accoglieva gli appartamenti estivi e invernali dei membri laici della famiglia, Taddeo (nipote di Maffeo, 1603 - 1647) al pianterreno, la moglie Anna Colonna (1601 - 1658) al piano nobile, la madre Costanza Barberini in un settore del secondo piano; l’ala sud era interamente dedicata al cardinale Francesco, mentre il corpo centrale ospitava il grande salone di rappresentanza con soffitto a doppia altezza, l’anticamera agli appartamenti cardinalizi anch’essa a doppia altezza, e la sala ovale che affaccia sul giardino.
Nel 1633 al terzo piano del palazzo fu allestita la grandiosa biblioteca di Francesco (quarantamila volumi): aveva inglobato quella dello zio Maffeo e divenne famosissima e seconda solo alla Vaticana. Vi si accedeva dalla scala elicoidale, attraverso un’anticamera che ospitava sessanta busti di letterati, mentre nel salone dominava il busto di Urbano VIII scolpito da Bernini (Fig. 14). In altre stanze adiacenti furono esposte collezioni di monete, bronzetti, conchiglie, cristalli e minerali. Completava questa enorme raccolta di meraviglie il sontuoso giardino, perfettamente apprezzabile dalla biblioteca, dove si coltivavano specie rare in accordo con la passione botanica del cardinal Francesco.
Fig. 14 - Gian Lorenzo Bernini, Ritratto di Urbano VIII, 1632 - 1633. Credit: https://www.instagram.com/barberinicorsini/?hl=it
I giardini
In una maniera del tutto pertinente al carattere duplice del complesso, a metà tra palazzo di città e villa suburbana, il giardino era in origine un vero e proprio parco: si estendeva dalla strada Pia (oggi via XX Settembre) fino all'odierna salita di san Nicola da Tolentino, ed era concepito come un giardino all'italiana, comprendente anche un giardino segreto, abitato da animali esotici come struzzi e cammelli. Alla fine del XVIII secolo l’assetto del parco cambiò, e per meglio conformarsi al gusto dell’epoca furono introdotti un'area di alberi ad alto fusto da giardino romantico e la cosiddetta casina di sughero, di fronte alla cordonata di collegamento del giardino con il palazzo. Nel 1814 nell'angolo tra la via Felice e la strada Pia fu costruito uno sferodromo [6] aperto al pubblico, che tale rimase fino al 1881, quando il parco di Palazzo Barberini cominciò ad essere progressivamente eroso dalle politiche urbanistiche, prima umbertina e poi fascista: il giardino, grande spazio libero nel cuore di Roma, venne risucchiato nello sviluppo urbanistico della nuova capitale, che vedeva i suoi ministeri allinearsi lungo via XX Settembre. Al parco fu risparmiata la lottizzazione totale che distrusse Villa Ludovisi, ma furono comunque sacrificate le strisce esterne verso la strada Pia, e lungo la rampa delle carrozze fu costruita nel 1875 la grande serra. Nel 1936 alle spalle della casina di sughero fu costruita la palazzina Savorgnan di Brazzà, ad opera di Gustavo Giovannoni (1873 - 1947) e Marcello Piacentini (1881 - 1960), durante i cui scavi di fondazione venne trovato un mitreo di II secolo.
Nei prossimi articoli si vedranno nel dettaglio alcuni aspetti di Palazzo Barberini come le grandi volte affrescate e le scale monumentali, ma anche il programma decorativo rococò dell’appartamento settecentesco di Cornelia Costanza Barberini, ultima erede diretta della famiglia.
Note
[1] Letteralmente “nell’uno e nell’altro diritto”: è un’espressione che si usava per definire i laureati in diritto civile e canonico.
[2] A. Antinori, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, p.140.
[3] Idem, cit. p. 142.
[4] A. Antinori, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, p. 142.
[5] A. Antinori, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, p. 145.
[6] Impianto sportivo per le varie specialità del gioco del pallone - da non confondersi con il calcio. Nelle nazioni dove si praticano sport sferistici, le definizioni di sferisterio cambiano, ma il significato del termine si riferisce sempre all'impianto dove si disputano partite di giochi sferistici. (Via Wikipedia)
Bibliografia
Antinori A., Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, in Scotti Tosini A. (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. Il Seicento, tomo I, Electa, Milano 2003, pp. 140 - 145
Spagnolo M., I luoghi della cultura nella Roma di Urbano VIII, in Luzzatto S., Pedullà G. (a cura di), Atlante della Letteratura, vol. 2, Einaudi, Torino 2011, pp. 387 - 409
Sitografia
Sito delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica al link: https://www.barberinicorsini.org/ (ultima consultazione 25/08/20)
Dizionario Biografico degli Italiani alle voci:
Urbano VIII, papa (http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-urbano-viii_%28Dizionario-Biografico%29/ ultima consultazione 25/08/20)
Barberini, Francesco (http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-barberini_(Dizionario-Biografico) ultima consultazione 25/08/20)
Barberini, Carlo (http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-barberini/ ultima consultazione 25/08/20)
Enciclopedia Treccani alla voce Barberini, Famiglia (http://www.treccani.it/enciclopedia/barberini_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ultima consultazione 25/08/20)
LA SALA DELLE PROSPETTIVE
A cura di Federica Comito

L’occasione delle nozze con Francesca Ordeaschi convinse Agostino Chigi ad effettuare dei lavori di restauro all’interno della sua villa. In particolare si preoccupò di far allargare il salone al primo piano, conosciuto come Sala delle Prospettive, perché è questa la sala dove si sarebbe poi tenuto il suo banchetto nuziale il 28 agosto 1519, a cui parteciparono personaggi illustri e addirittura Papa Leone X. Agostino affidò tale compito, ancora una volta, al senese Baldassarre Peruzzi, architetto della Villa.
Nella cosiddetta Sala delle Prospettive si nota non solo un richiamo all’antico, ma anche quel desiderio di rapporto costante tra interno ed esterno che è il leitmotiv dell’intera villa e che vede nelle soluzioni di Peruzzi degli esiti straordinari. Infatti, la Sala delle Prospettive deve il suo nome al fatto che per le prime volte in pittura si utilizza la scenografia con effetto di trompe-l’oeil e illusionisticamente la stanza si apre a vedere quello che c’è fuori, ovvero la città che si estende attorno al Palazzo. Ai lati del salone l’architetto ha dipinto due finte logge con colonne affacciate su Roma, raffigurando un tratto di mura in primo piano con dietro la Chiesa di Santo Spirito, una basilica romanica, la Porta Settimiana e a sinistra Monte Mario con Villa Mellini (oggi Osservatorio Astronomico). Per rafforzare l’illusione, Peruzzi arriva a tagliare la lettera “A” del nome di “Agostino Chigi” in un’iscrizione per rendere reale l’effetto tridimensionale della colonna che sporge dalla parete.

Questi affreschi fungono anche da testimonianza di come doveva presentarsi Roma al tempo. Una città ricca di torri i cui balconi venivano costruiti in legno, e che spesso finiva anche vittima delle esondazioni del Tevere. Infatti, in un punto sulla destra, l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia è proprio stato ricoperto dalle acque esondate del fiume. I pavimenti delle finte terrazze affrescate sono identici al pavimento vero e proprio all’interno della Sala delle Prospettive, che non è mai cambiato in 500 anni. Le linee del pavimento sono perfettamente corrispondenti a quelle degli affreschi, come se la pavimentazione continuasse anche nella terrazza; tuttavia, se si cambia punto di osservazione il trucco viene svelato.

Il fregio mitologico e i riquadri con gli dei
Appena sotto il soffitto a cassettoni blu con decorazioni vegetali dorate a rilievo, corre un ampio fregio in cui le scene mitologiche narrate sono scandite da cariatidi in monocromo. Il lungo fregio, che cinge l’ambiente nella parte superiore delle pareti, è stato realizzato da Baldassarre Peruzzi e bottega o forse da un giovane Giulio Romano. Sotto il cornicione affrescato vengono rappresentati gli dei sulle entrate e sui finestroni. Entrando a sinistra le figure femminili e a destra le figure maschili. In ordine riconosciamo: Cerere, Diana, Minerva, Giunone e Venere, a seguire Apollo, Saturno, Giove, Nettuno, Marte e Mercurio. Tra le figure di Minerva e Giunone, Sopra il camino, si trova l’affresco con la Fucina di Vulcano che dà vita ad una lunga tradizione che vede il dio del fuoco associato ai domestici caminetti di tutta Europa e che si ritroverà anche nella Sala delle Nozze.
Partendo da sinistra sono presenti sulla parete nord le dee Diana, Minerva e Giunone. Nel fregio vediamo:
- la morte di Adone amato da Venere: dal sangue di Adone nascerà l’anemone, il fiore del vento, per non essere mai dimenticato (episodio presente nel decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio);
- il trionfo di Arianna e Bacco, divinità molto presente nelle sale della villa;
- la gara sui carri tra Enomao, che amava decorare il suo palazzo con i crani dei nemici sconfitti, e Pelope che, vincendo la gara, sposò Ippodamia, figlia di Enomao;
- una scena sul monte Elicona, la sede delle muse in cui è presente il cavallo alato Pegaso che tocca con lo zoccolo la pietra facendo nascere una sorgente sul fondo, altri personaggi con la corona di alloro in testa sono in primo piano;
- nell’ultimo quadro della parete viene illustrata una scena acquatica con Venere come personaggio principale.
Sopra il camino l’affresco raffigurante la fucina del dio Vulcano.

Nella parete est della Sala delle Prospettive sono raffigurati sulle due porte Venere e Apollo, nel fregio tre scene:
- la prima, molto enigmatica, sembrerebbe rappresentare la dea Iride, riconoscibile a sinistra per la presenza dell’arcobaleno. Probabilmente si tratta della scena in cui la dea chiede a Ipno (il sonno) di mandare uno dei suoi tre figli, in questo caso Morfeo, in sogno ad Alcione per comunicarle che il marito Ceice è morto in mare;
- nel riquadro centrale Cefalo, che ha dato il nome all’isola di Cefalonia, di cui Eos, la dea dell’Aurora si innamora, e di Procri la sua sposa che dopo tradimenti e riconciliazioni viene uccisa proprio da Cefalo stesso;
- nell’ultimo affresco si vede il carro del sole.

Nella parete sud scompaiono le cariatidi; sono presenti quattro finestre sormontate dagli dei Saturno, Giove, Nettuno e Marte, ai cui lati troviamo dipinte le muse. Nei riquadri del fregio sono affrescati:
- la toeletta di Venere;
- Apollo che intreccia una corona nuziale;
- Il mito di Arione di Metimna, leggendario cantore e suonatore di cetra, costretto a gettarsi in mare dai marinai che volevano derubarlo. Viene salvato dai delfini incantati dalla sua melodia, che lo riportano a riva (Erodoto, libro primo delle Storie);
- Il mito di Pan e Siringa, una ninfa seguace di Artemide, che per sfuggire alle insistenze del dio venne trasformata in un fascio di canne palustri che, mosse dal vento, produssero un suono talmente armonioso da spingere il dio stesso a costruire il famoso flauto a canne conosciuto ancora oggi come “flauto di Pan” (Ovidio, libro primo);

Sulla parete ovest della sala si trovano le due porte sormontate da Mercurio e Cerere e sul fregio le ultime tre scene separate da cariatidi, partendo da sinistra:
- L’episodio in cui Alcione vede il corpo del marito Ceice in mare;
- Il mito di Deucalione e Pirra, unici sopravvissuti all’ira di Giove che, infuriato per la crudeltà degli umani, aveva mandato sulla Terra un terribile diluvio devastante. La coppia, sbarcata sul Parnaso, consulta l’Oracolo di Delfi ottenendo questa enigmatica risposta: "Uscite dal tempio e gettate dietro le vostre spalle le ossa della Gran Madre". Stettero a lungo a pensare a queste parole ma un giorno Deucalione si illuminò e capì che la Gran Madre era la Terra, e le ossa della Terra erano le pietre; così le pietre gettate da Deucalione, appena toccarono la terra, diventarono uomini e quelle gettate da Pirra, diventarono donne. In questo modo la Terra si ripopolò.
- Il momento in cui Apollo deride Cupido il quale si vendica lanciando due frecce che colpiscono Apollo e Dafne ma che hanno effetti contrari. Una d’oro che fa innamorare, l’altra di piombo che lo impedisce. È così che Dafne, per sfuggire agli assalti del Dio, implora il fiume Peneo suo padre e la terra Gea sua madre, di aiutarla a cambiare forma. La sua disperata richiesta verrà esaudita e si trasformerà nell’albero di alloro di fronte al dio che, abbracciando disperatamente il suo tronco, giura che da quel momento in poi il lauro sarebbe stata la sua pianta sacra usata come corona dal dio e dai massimi poeti.

I restauri della Sala delle Prospettive
Gli affreschi vennero completamente coperti nel 1863 da nuove decorazioni, ma recuperati dai restauri del 1976-1983. Il fregio rimase intatto, seppur con alcune lesioni. I restauratori hanno effettuate delle ricerche e successivamente una pulitura che ha confermato il buono stato di conservazione delle superfici originarie. Nella parte bassa della sala sono stati però riscontrati diversi danni: zone originali fortemente abrase e alterazioni cromatiche in corrispondenza delle finestrelle causate da infiltrazioni di umidità. Si è quindi dovuto procedere, dove possibile, con reintegrazioni a tempera. In prossimità di consistenti lesioni si erano verificati anche dei distacchi dell’intonaco. La parete est in seguito ad un cedimento, subì una lesione ampia circa 8 cm. Il cedimento è tuttora visibile sia nelle due grandi fessurazioni oblique, una delle quali interessa parte della figura di Apollo e il viso dell’amorino sottostante, sia nella posizione degli architravi delle due porte, che pendono sensibilmente verso il centro. Si cercò di ovviare a tale cedimento già nel 1775, con l’inclusione di una catena, mentre nel 1863-66 il duca di Ripalda costruì al piano inferiore un muro di sostegno. Per poter controllare eventuali movimenti delle murature sono stati applicati degli estensimetri alle fessurazioni, peraltro già documentati in antico, che sono stati rimessi in luce con l’asportazione della ridipintura ottocentesca sulle finestre [1]. Il film pittorico del fregio, corroso da precedenti puliture piuttosto drastiche soprattutto nei fondi azzurri e nei verdi, era stato ritoccato ad olio e a tempera e successivamente ricoperto da uno strato di protettivo (o resina ‘ravvivante’). In questo caso ci si è limitati a rimuovere i ritocchi e il protettivo che col tempo si erano scuriti, ma non si è intervenuti sulla pellicola pittorica perché, anche se solo in parte conservata, consente comunque una buona lettura delle figurazioni e dello stile degli artisti. Le pesanti ridipinture di colore marrone-rossiccio delle nicchie sopra le porte e le finestre, con le figure di divinità, come pure i ritocchi a olio effettuati sopra la ridipintura a tempera ottocentesca dei paesaggi e delle vedute tra le finte colonne, sono stati asportati mediante solventi. A seguito di queste operazioni, l’affresco cinquecentesco sottostante è tornato in luce in condizioni più che soddisfacenti, rendendo possibile oggi ammirarlo.
Conclusione
Queste pareti sono particolarmente ricche di storia, anche drammatica. Interessantissime sono le scritte lasciate dai Lanzichenecchi, i soldati mercenari di Carlo V che invasero la villa, ne asportarono i beni e in parte la distrussero. Fu il momento in cui una parte del Rinascimento finì nel Tevere - letteralmente e metaforicamente. Le scritte vandaliche, che hanno in parte rovinato gli affreschi, sono in lingua tedesca e sono datate al 1527; qualcuno dei soldati di Carlo V, con un pugnale o un altro strumento appuntito, ha inciso delle frasi sul muro affrescato. Una di queste recita più o meno: “Perché noi non dovremmo ridere, noi che abbiamo fatto scappare il Papa?”, riferendosi chiaramente all’episodio in cui Papa Clemente VII fu costretto a riparare a Castel Sant’Angelo. L’odio luterano fu quindi un aggravante in questa tragedia che colpì Roma, che subì un calo di popolazione notevolissimo tra la peste, le fughe e le uccisioni avvenute, appunto, durante il Sacco del 1527.

Note
[1] Cfr. http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=5&uid=68&rid=94
Bibliografia
Gli interventi dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (già ICR) presso la villa Farnesina-Chigi a Roma, Francesca Romana Liserre
Sitografia
www.villafarnesina.it
https://www.vidlab.it/
https://www.youtube.com/watch?v=rgx1FeyPTdg
LA SALA DEL FREGIO
A cura di Federica Comito
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Villa Farnesina. Ci troviamo ancora al pian terreno e, oltrepassando la porta sotto il pennacchio con Mercurio nella Loggia di Psiche, si giunge alla Sala o Stanza del Fregio che prende il nome dal fregio che corre lungo tutto il perimetro della stanza e la decora. Si tratta di un ambiente molto più piccolo rispetto alle stanze precedenti e, presumibilmente riservato a trattare affari privati, fungeva da studiolo privato di Agostino. È la sala in cui sono state lette le ultime volontà di Agostino dopo la sua morte, avvenuta l’11 aprile 1520. È stato il primo ambiente ad essere decorato nella Villa ed è anche una delle prime opere pittoriche di Baldassarre Peruzzi a Roma, per questo motivo lo stile risente ancora delle esperienze senesi del pittore.

La decorazione
La stanza presenta un soffitto a cassettoni suddiviso in forme geometriche con all’interno motivi floreali e vegetali a rilievo, dipinti d’oro su fondo blu o rosso. Sono presenti due iscrizioni in latino con lettere dorate su fondo blu rispettivamente sul lato nord e sul lato sud; volute da Salvator Bermudez de Castro duca di Ripalda e ambasciatore di Spagna alla corte di Francesco II di Napoli, in cui dichiara ti aver effettuato dei restauri alla Villa nell’anno domini 1863. Alle pareti invece, erano forse appesi degli arazzi.
Una cornice dorata raccorda il soffitto alle pareti, sotto di essa il fregio dove vengono ripresi motivi mitologici affrescati dallo stesso architetto della villa Baldassarre Peruzzi e allievi intorno al 1508- 1509. Qui colpisce l’ampio uso del giallo e del dorato tra le pareti e il soffitto, il fregio è in forte contrasto con il resto per l’uso abbondante del nero che narra, dal lato nord al lato est, le gesta eroiche di Ercole e altri miti tratti da ‘’Le Metamorfosi’’ di Ovidio. I fondi scuri sul quale si stagliano i personaggi sono realizzati dall’applicazione a secco dell’azzurrite su base scura, questa tecnica permette di dare massimo risalto alla preziosità delle figure.
Nel fregio sulla parete ovest sono raffigurate le seguenti scene:
- una ninfa con dei satiri.
- Bacco e baccanti.
- il satiro Marsia sconfitto con l’inganno da Apollo in una gara musicale mentre viene scorticato vivo per punirlo della sua superbia.
- il mito di Meleagro: la caccia a un cinghiale spaventoso inviato da Atena arrabbiata per le mancate offerte. Alla caccia partecipa anche una ragazza di nome Atalanta non sopportata dagli altri cacciatori, mentre Meleagro se ne innamora. Una volta abbattuto il cinghiale le dona pelle e zanne come trofei, questo scatena l’ira degli zii. Meleagro li uccide dando inizio a una faida famigliare con altri omicidi. Le Parche, che avevano assistito alla nascita di Meleagro, ne avevano predetto la morte quando il tizzone che bruciava in quel momento sul fuoco fosse stato consumato. Allora Altea, madre del ragazzo, nasconde il tizzone per tenere al sicuro il figlio. Le Parche fanno visita a quest’ultima e la invitano a gettare il tizzone nel fuoco cosa che Altea, incollerita per l’uccisione dei fratelli, esegue per poi pentirsene quando Meleagro muore.
- Il mito di Orfeo: Orfeo con uno strumento simile ad una viola, probabilmente la lira del mito, incanta gli animali grazie al meraviglioso suono che produce. Orfeo andato a riprendere Euridice negli Inferi, si volta a guardarla e, quest’ultima, viene quindi ritrascinata nell’ade a causa dell’impazienza dell’amato. Orfeo decidendo di non unirsi mai più ad altre donne, e forse preferendo i fanciulli come suggerisce Ovidio nel decimo libro delle Metamorfosi, viene picchiato a morte da un gruppo di Menadi. Anche se non è presente nell’illustrazione, il mito narra che la testa di Orfeo abbia continuato a cantare, dopo essere stata separata dal corpo e gettata nel fiume Ebro.

Nel fregio della parete nord sono affrescate dieci delle “dodici fatiche di Ercole” separate da tronchi d’albero:
- Ercole e il leone di Nemea;
- Ercole e i centauri;
- L’uccisione degli uccelli Stinfalidi;
- Ercole e l’Echidna, metà donna e metà serpente, madre del leone di Nemea, di Cerbero, dell’Idra di Lerna e altre mostruosità;
- Ercole e Cerbero;
- Ercole che combatte contro l’Idra;
- Il re Diomede che lo dà in pasto alle sue cavalle;
- Ercole contro il toro di Creta;
- Ercole contro Anteo il gigante che, essendo figlio di Gea (la terra) da cui traeva la forza, dovette essere ucciso sollevandolo dal suolo;
- La lotta con Gerione, al quale Ercole ha rubato i buoi.

Nel fregio della parete est troviamo ancora, a completare il ciclo, le ultime due fatiche di Ercole:
- Ercole che sostituisce Atlante per sostenere la volta del cielo;
- Ercole e il cinghiale di Erimanto.
Una statua femminile chiude la saga Eraclea. Agostino Chigi fa rappresentare in diverse occasioni la figura di Ercole all’interno della loggia, probabilmente appassionato dai miti che lo vedono come protagonista. Baldassarre Peruzzi riesce proprio nell’intento di glorificare il padrone di casa attraverso le fatiche di Ercole.
Continuando le scene affrescate sul fregio troviamo:
- Il ratto di Europa. Dall’unione tra Europa e Giove nascerà Minosse;
- Danae adagiata sul letto accoglie Giove sotto forma di pioggia dorata, dall’unione nascerà Perseo;
- Il mito di Semele: Semele, altra fanciulla amata da Giove che gli generò Dioniso, convinta da Giunone che aveva preso le sembianze della nutrice di far apparire Giove sotto le sembianze di Dio, muore colpita dal fulmine divino;
- Il mito di Atteone, trasformato in un cervo da Atena e sbranato dai suoi cani da caccia.
Altri episodi riguardano Re Mida, che vanno letti da destra verso sinistra, concludono la parete:
- Dioniso, mosso da pietà per il Re stolto che aveva chiesto di poter trasformare tutto ciò che toccava in oro, gli svela come liberarsi dall’incantesimo bagnandosi alla sorgente di un fiume;
- L’episodio in cui Re Mida assiste alla gara musicale tra Apollo e Pan e mette bocca nella contesa che vedeva vincitore Apollo, tanto che il dio permalosissimo gli fa crescere due orecchie d’asino. Anche qui la cetra di Apollo ha piuttosto l’aspetto di una viola;
- Un corteo marino con Poseidone, la moglie Anfitrite e il figlio Tritone su un carro che seguono il corteo che si snoda per l’ultima parete.

Nell’ultima parete, quella a sud, è affrescato un corteo marino: amorini che si divertono a pescare o si trovano sul dorso di delfini, altri personaggi che portano anfore, gruppi di famiglie di tritoni. Suscita qualche dubbio la presenza di una divinità fluviale che ha fatto pensare che il corteo si svolgesse in un fiume piuttosto che a mare.

Le scene allegoriche raffigurate, probabilmente fanno riferimento ad alcuni aspetti del carattere del padrone di casa Agostino Chigi. Sono raffigurate nell’intero fregio oltre 150 figure, questo dimostra la capacità sintetica e pittorica di Baldassarre Peruzzi nell’illustrare le scene importanti e rappresentarle fornendo una linearità alle storie. L'interpretazione complessiva è generalmente riferita al contrasto tra ragione e passione, tra sfera apollinea e sfera dionisiaca.
Questi cicli pittorici sono stati di grande ispirazione per altre Ville Romane, pensiamo al fregio di Palazzo Leopardi a Trastevere in cui è raffigurato un fregio mitologico fluviale che ripercorre gli stessi modelli e, in qualche modo, accentua la dimensione plastica e dinamica di quello di Baldassarre Peruzzi. Ci sono alcune figure quasi identiche ma c’è un cambiamento di linguaggio, di cromia, quasi un’accentuazione grottesca, mentre Peruzzi è più legato ad un equilibrio classico e ad una ricerca di raffinatezza.
Il restauro della Sala del Fregio
Tra il 2003 e il 2011 si svolge un restauro ad opera dell’Istituto Centrale per il Restauro nella Sala del Fregio. Prima dell’intervento di restauro, nella sala era presente un tessuto monocromo fissato con una sorta di punti metallici alle pareti. Il tessuto che tappezzava l’intera sala era riconducibile circa agli anni 1950-60. Grazie però alla documentazione fotografica antecedente e a saggi effettuati all’inizio dell’intervento, è stato possibile recuperare l’immagine complessiva dell’ambiente di come questo appariva alla fine dell’800. Le pareti erano caratterizzate dalla presenza di una decorazione a finti drappi, dipinti su carta applicata al muro che, agganciati alla cornice dipinta sotto il fregio figurato, ricadevano a coprire quasi interamente le pareti per 150 cm da terra. Lo stato conservativo si presentava critico, in particolare nell’angolo nord-est della parete a causa di pregresse infiltrazioni d’acqua e per le ampie lacune della decorazione a finti drappeggi, dovute ad ampi rifacimenti delle murature. Dopo il restauro del fregio con le storie mitologiche è stato affrontato il completo recupero delle superfici dipinte della sala, ossia il soffitto e le pareti. Si è poi giunti, attraverso il lavoro interdisciplinare di un’equipe di specialisti (architetti, storici dell’arte, restauratori, chimici e fisici) a una riproposizione organica dell’aspetto della sala così come si presentava alla fine dell’‘800. All’epoca infatti, la decorazione a drappeggi con i parati in tessuto rendeva le quattro pareti monocrome solo in funzione di un’esaltazione e di un ‘isolamento’ del fregio cinquecentesco, in quanto brado decorativo più importante. L’intervento particolarmente delicato e complesso, perché tiene conto delle tecniche esecutive utilizzate in origine e del pessimo stato di conservazione delle superfici dipinte, ha richiesto la messa a punto di un procedimento tecnico sperimentale appositamente progettato e realizzato dopo numerosi studi e test.
La “Saletta pompeiana”
Accanto alla Sala del Fregio si trova un ambiente più piccolo che mostra delle decorazioni risalenti al tempo del duca di Ripalda, 1861-63. Questi due ambienti sono sempre stati utilizzati come uffici o come studi privati dei vari padroni di casa, fino a giungere agli anni Trenta con Guglielmo Marconi, presidente dell’Accademia d’Italia, che decide di usare la Sala del Fregio come studio, e fa trasformare l’ambiente più piccolo in un bagno privato con anticamera. La Sala, nel primo Cinquecento, era un semplice pianerottolo della scala che scendeva alle cucine di Agostino Chigi. Nell’Ottocento, grazie a una serie di interventi fatti eseguire dal Duca di Ripalta, Salvador Bermúdez de Castro, viene invece trasformata in una splendida camera ornata con decorazioni ispirate allo stile pompeiano, da qui il nome “Saletta pompeiana”. In quegli anni infatti, gli scavi di Ercolano e Pompei, la riscoperta di Paestum, le sepolture con ricchi corredi messi in luce nell’antica Magna Grecia, appassionavano la nobiltà e la borghesia del XIX secolo. Da qui l'ispirazione per la realizzazione delle decorazioni ottocentesche della Villa, affascinanti riletture dei modelli antichi in chiave neoclassica e romantica.

Conclusione
In tutta la villa è forte il gusto rinascimentale di ritorno alla classicità rivisitato con i canoni del tempo, di cui Agostino Chigi si fa interprete, grazie soprattutto alla scelta di circondarsi di intellettuali e artisti di notevoli capacità. Peruzzi, per l’intera decorazione del fregio, si era ispirato a rilievi antichi, a sarcofagi e prototipi dell’età classica che Agostino Chigi, oltre ad amare profondamente, ha favorito grazie al suo mecenatismo che lo aveva addirittura portato a realizzare una tipografia nella sua Villa, trasformandola in un centro culturale di straordinario valore e di portata internazionale.
Bibliografia
Il fregio riscoperto di Palazzo Leopardi a Roma, Alessandro Zuccari.
Gli interventi dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Francesca Romana Liserre.
Sitografia
http://www.romainteractive.com/ita/trastevere/villa-della-farnesina/sala-del-fregio.html
artemagazine.it
www.villafarnesina.it
https://www.youtube.com/watch?v=amw0UB7iif4