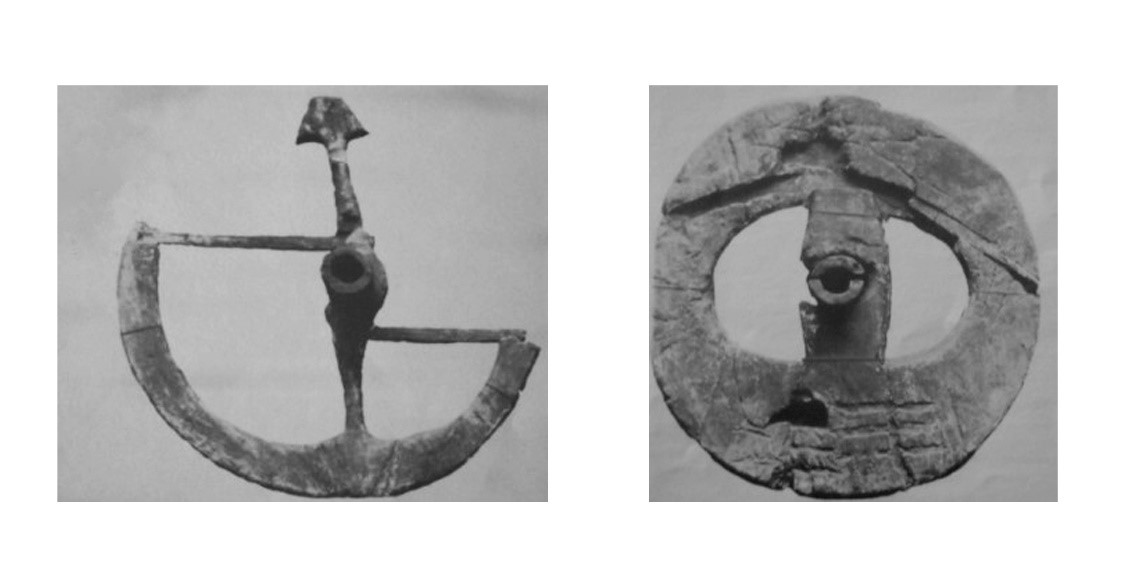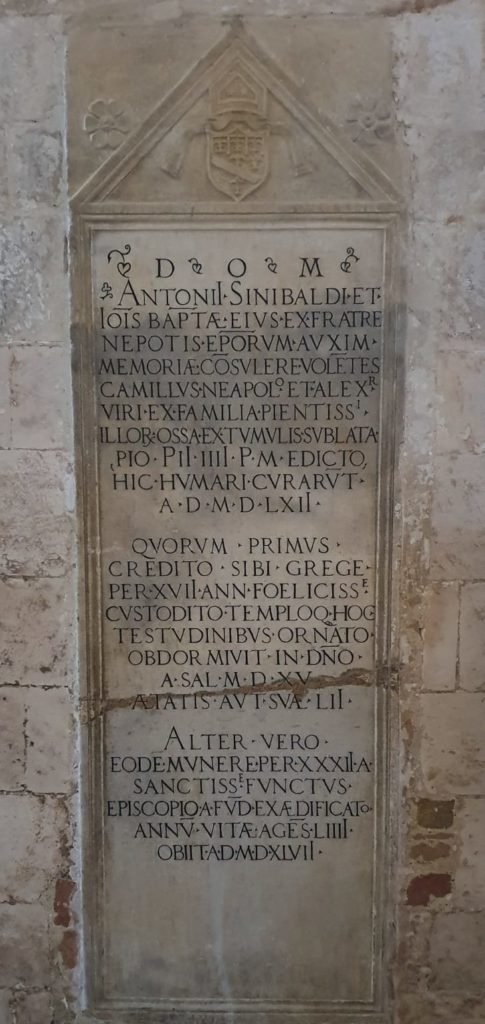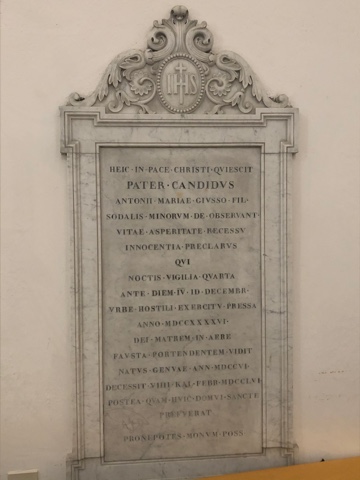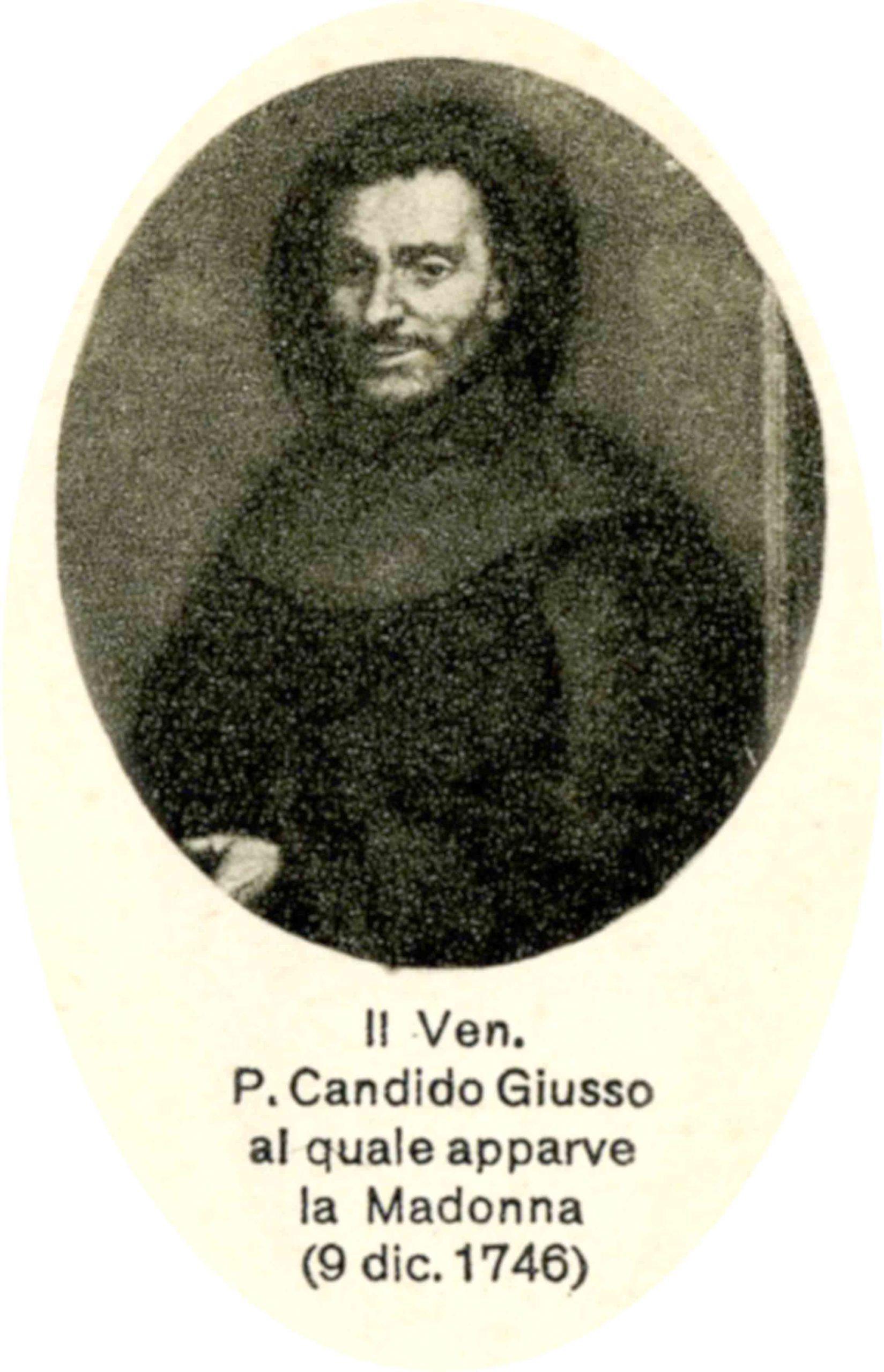IL PARCO DEI LAGONI DI MERCURAGO
A cura di Marco Roversi
L’Insediamento Palafitticolo dell’Età del Bronzo tra XVIII e XIII a.C. e Le Ruote di Mercurago
L’area protetta del Parco dei Lagoni di Mercurago (No) fu istituita nel 1980 su iniziativa popolare, ed è tutt’oggi gestita dall’Ente Parchi del Lago Maggiore, assieme ai Canneti di Dormelletto (NO) e alle Riserve di Fondotoce (VB). Dotato di un’intricata rete interna di sentieri, che consentono ai visitatori di addentrarvisi e di percorrerlo nella sua interezza, il territorio del parco si compone geologicamente di un terrazzo di origine morenica affacciato sul Lago Verbano, con due serie di collinette poco estese ed elevate (comunemente denominati motti). Ricca in ogni stagione di spettacoli naturali unici e suggestivi la Riserva Naturale racchiude, in una superficie relativamente limitata (473 ettari circa), una serie interessante e assai eterogenea di ecosistemi: lo stagno, la palude, il bosco, la brughiera e il coltivo, nonché una zona di torbiera e pascoli dedicati all’allevamento di cavalli purosangue. Sentieri tematici sono appositamente segnalati per consentire ai visitatori di apprezzare le ricchezze naturali, e non solo, offerte da questo parco, dai percorsi per i boschi e le zone umide (segnati in pinta rispettivamente con i colori rosso e azzurro), ai percorsi dedicati alle attività produttive e all’archeologia del luogo (ovvero i percorsi arancione e viola). Di recente realizzazione è, invece, l’allestimento di itinerari storici che collegano l’area protetta con i Comuni circostanti (Arona, Dormelletto, Comignago e Oleggio Castello), alcuni dei quali corredati di pannelli e bacheche illustrative degli aspetti storici di maggior rilevanza.

Nel giugno del 2011 il Parco dei Lagoni di Mercurago è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, rientrando tra i 111 Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. La riserva presenta, infatti, interessanti presenze archeologiche, testimoni di una lunghissima occupazione che va dall’Età del Bronzo sino all’occupazione romana, ma la documentazione archeologica relativa all’antico villaggio palafitticolo è certamente la più nota e la più rilevante. Le primissime presenze umane in situ risalgono alla fase del passaggio tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio (BA II/ BM I), tra 1600 e 1500 a.C. (secondo la periodizzazione cronologica dell’Età del Bronzo relativa all’Area Padana e Sud-Alpina). La cosiddetta Cultura di Mercurago, assimilabile per cultura materiale e modalità di insediamento alla cultura del vicino Lago di Monate (VA), presenta tracce di insediamenti palafitticoli, in parte oggi poco conservati e molto erosi. Di conseguenza non possediamo più strati con presenze archeologiche, e tutte le documentazioni proseguono per indagine tipologica sui materiali rinvenuti, specialmente sui reperti bronzei, i quali hanno permesso di stabilire che i suddetti abitati furono attivi per un lungo periodo dell’Età del Bronzo, almeno per tre secoli, con la fase più intensa di abitato e di presenza umana ascrivibile al periodo finale del Bronzo Antico.
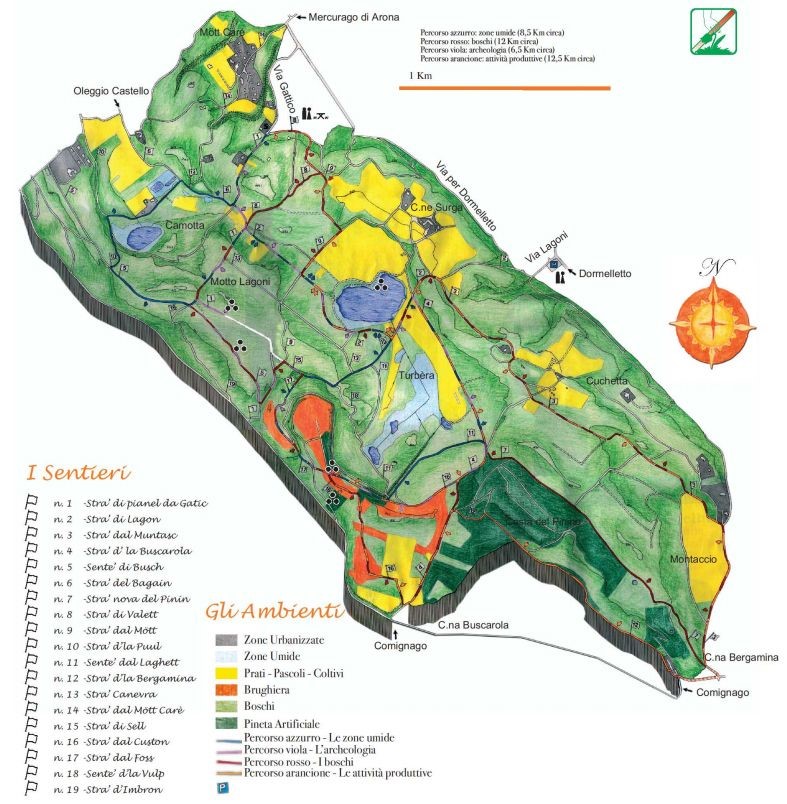
Il complesso dei ritrovamenti e l’abbondanza dei reperti che vennero alla luce immersi nei giacimenti ricchi di torba, fanno dei Lagoni una fra le più importanti stazioni preistoriche d’Italia. Le torbiere del Parco si sono, infatti, rivelate ottimi luoghi per la conservazione del passato e dei suoi tesori: torba e limo creano un ambiente anaerobico, ossia privo di ossigeno, il che impedisce l’ossidazione delle sostanze e dei materiali organici e l’azione decomponente di batteri e altri microrganismi. Ne consegue che i resti biologici di un antico insediamento, che l’acidità del terreno in certi casi può cancellare anche molto velocemente, in ambiente di torbiera vengono conservati presso che intatti anche per moltissimi secoli. Ecco che la particolarità ambientale del sito ha permesso di portare alla luce materiali in ottime condizioni di conservazione, dai reperti metalli in bronzo rinvenuti nel più piccolo dei due laghi del Parco, a manufatti in legno, fibre, corde, resti di cibo e cuoio. E si deve proprio a questa particolare condizione ambientale il ritrovamento più importante dell’area dei Lagoni: quelle delle celebri ruote da carro in legno.

L’iniziatore degli studi in situ fu il geologo torinese Bartolomeo Gastaldi, che nel 1860 per primo condusse operazioni di scavo e ricerca su ciò che rimaneva di un’antichissima palafitta, una delle più antiche di tutta l’Europa, rinvenuta all’estremità settentrionale della conca del più grande dei due specchi d’acqua che si estendono nel Parco, denominato Lagone. Il Gastaldi studiò a fondo quanto rimaneva di tale antica struttura, e realizzò anche calchi in gesso sui reperti lignei deperibili portati alla luce, continuando i suoi studio fino al 1866. La struttura si inseriva in un contesto insediativo di notevole estensione, composto da più settori abitativi aventi come fulcro centrale proprio il Lagone, un’area abitativa documentata dall’Antica alla Tarda Età del Bronzo, tra XVIII e XIII a.C., della quale non si conoscono ancora le annesse aree di necropoli. Gli antichi abitanti dei Lagoni costruirono un intero villaggio adottando criteri di urbanistica che, per l’epoca, potevano dirsi assai all’avanguardia: si può, infatti, pensare ad un complesso di capanne disposte su due file e divise da un canale centrale; le costruzioni, che poggiavano su quattro pali perfettamente arrotondati lunghi all’incirca 3 m e con un diametro di 20 cm circa, erano interamente in legno e terriccio, con coperture straminee, ossia in paglia, a doppia falda. La presenza umana, tuttavia, non fu continua, in quanto tra il 1550 e il 1450 a.C., nella fase centrale della Media Età del Bronzo, si può presumere un abbandono temporaneo del sito, forse in occasione di un impaludamento dello specchio d’acqua. Successivamente il sito del Lagone venne nuovamente occupato in modo stabile.
L’insediamento era sede di una comunità dedita alla pesca, alla caccia, all’agricoltura, all’allevamento del bestiame, alla lavorazione tessile e anche ben sviluppata nella produzione e nello scambio a lunga di stanza di merci e beni, anche di prestigio (come i bottoni in pasta vitrea di ispirazione mediterranea), attraverso il controllo dell’accesso a vie commerciali fluviali e di terra in diretto collegamento con gli abitati che, lungo gli alti terrazzamenti naturali del Ticino, tracciavano un asse commerciale nord-sud da Mercurago a Marano Ticino e Bellinzago Novarese (NO), e poi verso la Lomellina e la bassa pianura. Gli abitanti di tale comunità producevano ed impiegavano piroghe intagliate nei tronchi degli alberi, di cui ne sono state portate alla luce due esemplari, e di cui si conservano tutt’oggi due calchi presso il Museo Archeologico di Torino. I prodotti fittili, invece, erano forgiati a mano, cotti a fuoco libero e caratterizzati da un’argilla di colore quasi nerastro, con ornamentazione semplice a lineette oblique tracciate a stecca oppure disposte a fasce orizzontali parallele. Poco si conserva degli utensili impiegati per la caccia e delle armi, queste ultime rappresentate perlopiù da cuspidi di selce scheggiata e da coltelli in rame.
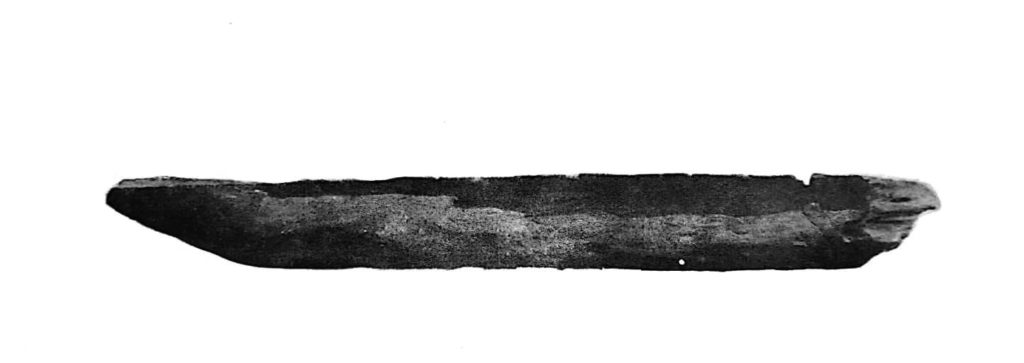
Ma sopra ad ognuna di tali testimonianze materiali spiccano le sopracitate ruote che senza alcun dubbio costituiscono il materiale più vivo di tale civiltà: tali ruote, rinvenute in numero di quattro (di cui solo di due furono realizzati i calchi in gesso, mentre le altre due non furono riprodotte), presentano alcune peculiari caratteristiche che le distinguono dalle più antiche ruote a disco pieno e di notevole pesantezza cronologicamente riferibili al 1650/1550 a.C. Le ruote di Mercurago, le cui dimensioni variano su diametri tra gli 82 e i 92 cm, sono costruite in tre sezioni, e hanno la caratteristica sostanziale di essere “folli” sull’asse, ossia che ne viene eliminata la sollecitazione facilitando, così, l’uso di un asse carraio più leggero e quindi più pratico. Dotate, inoltre, di raggi non convergenti, di bandelle di rame per assicurare stabilità e resistenza le ruote mercuraghesi costituiscono un evidente espressione di quelle genti nel creare e perfezionare tramite un’intelligenza tecnologica estremamente avanzata. Sono note principalmente due diverse tipologie: la prima tipologia era probabilmente impiegata per la realizzazione di carri pesanti da traporto, la seconda era forse adatta a carri più leggeri, destinati forse ad un uso bellico o cerimoniale. La ruota più massiccia pare essere stata impiegata in ambito rurale e appartiene probabilmente ad un carro pesante a traino bovino, mentre quella più leggera potrebbe essere riferita, per ovvi limiti di carico, ad un carro leggero a due ruote a traino equino, una tipologia ben comune agli scenari di guerra e anche simbolo di prestigio dei membri socialmente più elevati del tempo. Appare comunque singolare la presenza nello stesso sito di ben quattro ruote in realtà tutte differenti tra loro, riferibili a quattro diverse tipologie di carri, tanto da rafforzare l’ipotesi che non si trattassero di veicoli legati ad un uso quotidiano, ma alla vicinanza o alla presenza nel sito di un’officina specializzata per la riparazione o per la fabbricazione dei carri, dato anche il legno di noce impiegato per fabbricarle, che non proviene dall’area del Parco, e data anche l’incongruità dell’utilizzo di carri da guerra nell’area della Torbiera. Al di là delle diversità tipologiche, le ruote sono invece accomunate da tecniche realizzative presso che simili, impiegando tenoni (giunture) lignei interni e archi di rinforzo, “manicotti” in legno più tenero per prevenire il consumo dell’assale, l’ovalizzazione del foro della ruota e l’assenza di cerchiatura (sono cosi prive di battistrada in metallo solitamente impiegato per prevenirne l’usura).
Scoperte nel XIX secolo, quando ancora non si conoscevano le tecniche per la conservazione del legno antico estratto da ambienti umidi, se ne conserva solo il calco, prontamente effettuato dallo stesso Gastaldi nella torba al momento del rinvenimento. In un primo tempo le ruote furono attribuite all’Antica Età del Bronzo (XXI-XVII a.C.), ma una più attenta rilettura della serie stratigrafica ed un confronto con rinvenimenti analoghi in area elvetica sembrano portare ad una cronologia più tardiva, nell’ambito della Media-Tarda Età del Bronzo (XIV-XIII a.C.), vale a dire nell’ultima fase di occupazione della torbiera. I calchi originali delle ruote sono oggi conservati al Museo Archeologico di Torino, mentre una copia di uno di essi è oggi conservato e ed esposto presso il Museo Archeologico di Arona (NO). Inaugurato nel 1977, e sito nell’ala sinistra dell’ottocentesco mercato coperto di Piazza San Graziano, esso raccoglie alcuni dei rinvenimenti archeologici provenienti dalla città di Arona e dall’area del Basso Verbano e nelle prime vetrine del percorso espositivo si possono ammirare anche alcuni dei reperti dell’Età del Bronzo rinvenuti nella stazione palafitticola del Parco dei Lagoni di Mercurago.
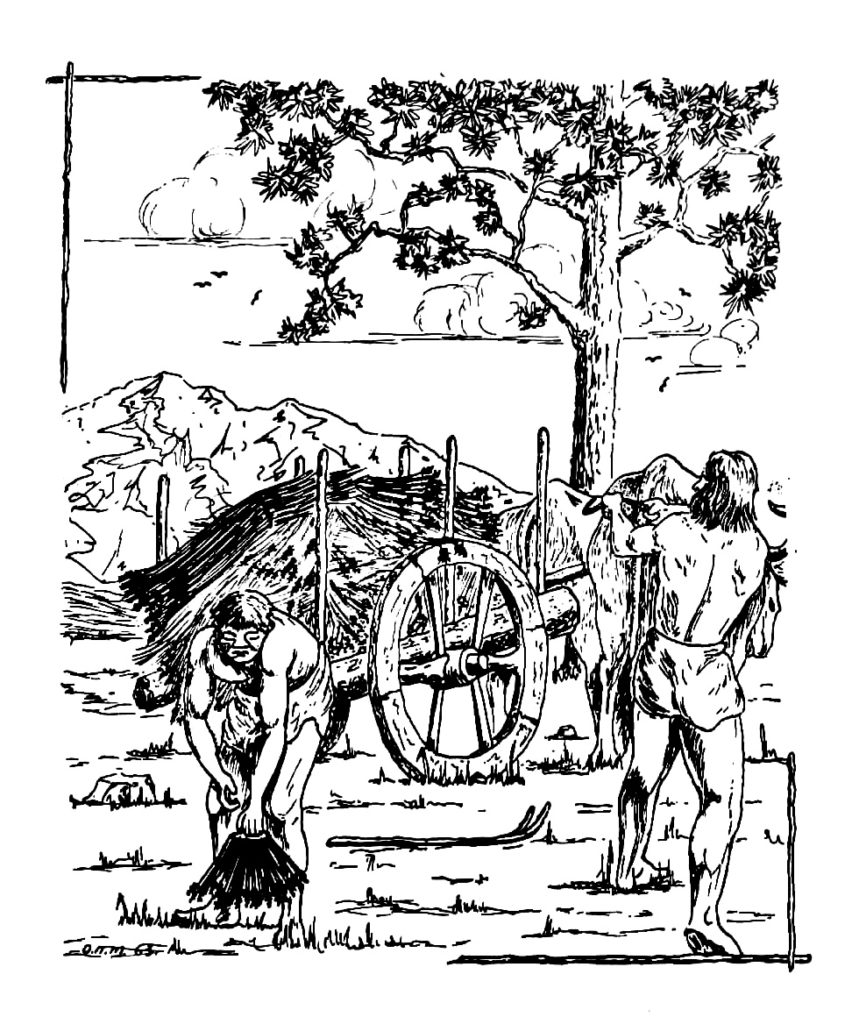
Bibliografia:
- “La Storia di Arona”, a cura di Peppino Tosi e Mario Bonazzi, Editrice Evoluzione, Milano, aprile 1964.
- “Arona nella Storia”, a cura di Carlo Manni, Edizione promossa dal Comune di Arona, Interlinea Edizioni, Novara, 2001.
Sitografia:
LA CHIESA DI SAN ROCCO A CANEVE DI ARCO
A cura di Beatrice Rosa
A pochi chilometri dalla cittadina di Arco di Trento, nella frazione di Caneve, vi è la chiesa di San Rocco (fig. 1), un edificio liturgico molto piccolo che nasconde però un grande tesoro: quando vi si entra, non si può infatti che rimanere estasiati dalla bellezza e ricchezza degli affreschi e delle pale d’altare che lo decorano.

L’edificazione della chiesa risale al XV secolo, in occasione del matrimonio tra Odorico d’Arco e Susanna Collalto avvenuto nel 1480; ipotesi confermata dalla presenza delle sigle e stemmi dei due nobili affrescati nell’arco santo (fig. 2). Dalle fonti si evince come i Conti d’Arco fossero particolarmente affezionati a questa chiesa, probabilmente per la presenza di un palazzo dei conti proprio nella frazione arcense. Degno di nota il fatto che l’edificio non sia citato nell'elenco delle chiese del luogo per decenni, probabilmente perché fino al 1537, anno della prima visita pastorale, aveva la funzione di cappella privata[i].

L’accesso alla chiesa è favorito da due ingressi: quello principale a sud e quello secondario ad est. Come già anticipato, è un edificio di piccole dimensioni con l’aula rettangolare larga 9 m, lunga 6 m e alta 7 m e l’abside a pianta quadrata con lato lungo 5 m e alta 4 m[ii]
La decorazione interna
La peculiarità della chiesa di San Rocco è la decorazione ad affresco su tutte le pareti, sia la parte del presbiterio che della navata, frutto essenzialmente di due campagne decorative: una di fine Quattrocento e l’altra di metà Cinquecento.
Gli affreschi del presbiterio
La prima campagna lavorativa, coeva con la costruzione dell’edificio di fine Quattrocento, riguardava gli affreschi del presbiterio, molto probabilmente ad opera del pittore rivano Gaspare Rotaldo[iii]. Accedendovi, non si può non notare la raffigurazione sulla parete di fondo di S. Antonio Abate e S. Agostino affiancati dai parzialmente visibili S. Sebastiano e S. Rocco (fig. 3). Gli affreschi sono molto rovinati perché, sicuramente dopo il 1519, è stata presa la decisione di dotare la chiesa di un vero altare e di una sacrestia, il che ha portato all'introduzione di una nicchia nella parete di fondo per contenere l’altare ligneo con il gruppo scultoreo della Madonna con i santi Rocco e Sebastiano e sulla parete di sinistra l’introduzione della porta per la sacrestia. Attualmente nell'altare ligneo c’è una Madonna con Bambino in marmo, in quanto sfortunatamente le tre sculture lignee sono state rubate nel 1987[iv].

I quattro santi citati precedentemente sono inseriti in un paesaggio esteso sulle pareti laterali, un’immagine familiare se si visita la chiesa di San Rocco dopo essere stati nella cittadina di Arco: nell'angolo tra la parete sinistra e quella di fondo è infatti rappresentato il borgo di Arco e sotto il fiume Sarca[v].
La parete più interessante del presbiterio è sicuramente quella di sinistra, dove è raffigurato un personaggio ben abbigliato sdraiato sullo stipite dell’ingresso alla sacrestia (fig. 4). Questo giovanotto non è un semplice pellegrino, ma è San Rocco: sdraiato con la testa appoggiata al braccio destro, lo sguardo languido rivolto verso di noi, come se non si stesse accorgendo dell’arrivo del cane che gli sta portando una pagnotta. Il santo è raffigurato con tutti i suoi attributi più comuni: l’abbigliamento e il bastone da pellegrino, la piaga sulla gamba destra indicata da lui con la mano sinistra e appunto, il fedele amico. Sulla stessa parete, si vede sbucare anche un altro personaggio, un ragazzo biondo, dal naso prominente e le labbra carnose che sembra salutarci con la mano destra. Si è molto discusso sull'identificazione di questo giovane, con la conclusione che si tratti dello stesso Odorico d’Arco in atteggiamento di saluto alla moglie, la cui effige era con tutta probabilità raffigurata sulla parete opposta, lato del presbiterio sfortunatamente molto rovinato e manomesso[vi].

Se si alza lo sguardo verso la volta a crociera, si noterà la rappresentazione dei quattro evangelisti in tondi, attorniati da dei simpaticissimi putti festosi occupati in svariate attività (fig. 5). La presenza di questi bambini alati è un meraviglioso esempio di convivenza di iconografia sacra e profana in un edificio liturgico[vii].

Gli affreschi dell’aula
Molto diversi sono invece gli affreschi caratterizzanti l’aula, frutto di una campagna decorativa di metà XVI secolo attribuita a Dioniso Bonmartini e aiuti. Dioniso Bonmartini era un pittore di Arco, che già nel 1537 aveva firmato gli affreschi del sottogronda del Palazzo del Termine. Tramite questa testimonianza e lo stile peculiare del pittore, riconoscibile per i tratti fisionomici caratterizzati, la varietà di atteggiamenti e movenze e l’attenzione particolare alla gestualità delle mani, è stato possibile attribuirgli il ciclo pittorico di Caneve[viii].
La volta a crociera è decorata, come nell'abside, con quattro medaglioni che iscrivono le figure degli Evangelisti con i loro attributi, essi sono poi circondati da un motivo a grottesche caratterizzato da fiori e rami che si tramutano poi in vasi e in uccelli (fig. 6)[ix].

Gli affreschi parietali hanno come soggetto la Passione di Cristo. Il racconto va letto partendo dalla parete di destra dove è raffigurato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: vediamo Cristo in groppa a un asino, accompagnato da vari personaggi tra cui S. Pietro, riconoscibile dalle chiavi nella mano destra e dalla tunica blu e il mantello giallo. A destra di questo episodio, c’è la scena successiva raffigurante l’Ultima Cena, più precisamente il momento in cui Gesù disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà” (fig. 7). La narrazione prosegue sulla parete di fondo con la scena della lavanda dei piedi sulla sinistra e Cristo nell'orto del Getsemani sulla destra, episodi sfortunatamente molto rovinati a causa dell’apertura della finestra in facciata[x].

Dalla parete di fondo ci si rivolge poi alla quella di sinistra dov'è presente la vicenda della cattura di Cristo (fig. 8): Gesù è nell'atto di rimproverare S. Pietro che ha reciso con la spada l’orecchio destro ad uno dei convenuti. A destra, sul medesimo registro, si scorge un gruppo di soldati romani che scortano Gesù verso Anna, suocero di Caifa, per il giudizio preliminare.

Il racconto riprende poi nel registro inferiore della parete di destra (fig. 7): nel primo episodio vediamo Caifa in trono, vestito sontuosamente mentre discute con uno dei tanti sacerdoti al suo fianco; sta aspettando Gesù che arriva da sinistra scortato dai soldati romani, con lo sguardo affranto rivolto verso il basso. I soldati ritornano anche nella scena seguente sulla destra, in questo caso stanno conducendo Cristo davanti a Pilato. Il pittore sceglie di illustrare in questa parte di parete un episodio narrato dall'evangelista Matteo, cioè il momento in cui Pilato si fa portare da due inservienti dell’acqua e un catino che utilizza per lavarsi le mani. La narrazione prosegue poi sulla parete di fondo dove si possono ammirare due episodi commoventi della Passione: sulla sinistra la flagellazione con Cristo alla colonna, sulla destra l’incoronazione di spine[xi].
A differenza degli affreschi visti finora, gli episodi nel registro inferiore sulla parete sinistra, gli ultimi due prima della crocifissione, sono molto rovinati ma ancora perfettamente leggibili: sulla sinistra è raffigurato Cristo davanti ad Erode e a destra l’affollata salita al Calvario (fig. 8)[xii].
La narrazione si conclude poi sopra l’arco santo con la straordinaria Crocifissione (fig. 9), episodio che occupa lo spazio che nelle altre pareti sarebbe stato investito per rappresentare due scene. Al centro vediamo Cristo crocifisso, con il corpo candido, la testa reclinata verso il basso in un atteggiamento di rassegnata accettazione. Al suo fianco i due ladroni in croce, con il corpo più rosaceo, in pose contorte e divincolate, probabilmente a causa del dolore che rende anche i loro volti quasi grotteschi. Ai piedi della croce si notano Maria Maddalena e S. Giovanni Evangelista con gli occhi rivolti verso l’alto; un dettaglio meraviglioso è quello in primo piano con le quattro donne che reggono la Vergine svenuta dal dolore nel vedere il figlio crocifisso[xiii].

Oltre al ciclo della Passione, è degno di nota anche l’affresco alla destra della porta laterale (fig. 10). Esso raffigura una mensa d’altare sulla quale, tra i candelabri, è presente un ostensorio in oro al cui interno si può scorgere l’eucarestia con il Cristo crocifisso, il tutto coperto da un leggerissimo velo trasparente[xiv]. Tra le due colonne sullo sfondo, è compresa la pala d’altare: essa ha come soggetto due santi, di cui noi oggi vediamo solo dal busto fino ai piedi, nonostante ciò, sono perfettamente riconoscibili come S. Sebastiano sulla sinistra e S. Bernardino sulla destra. Inginocchiati davanti all'altare riconosciamo S. Rocco, indicante con la mano destra la piaga sulla gamba, e S. Girolamo in vesti di eremita in preghiera, come i tre giovinetti al centro della composizione. Questo affresco non presenta discontinuità nella stesura dell’intonaco, il che fa pensare, considerate anche le molte analogie stilistiche, che sia stato realizzato dalla stessa mano degli affreschi della Passione di Cristo[xv].

Osservando le pareti dell’aula, si potrebbe rimanere invece perplessi nel vedere degli affreschi molto diversi rispetto a quelli descritti finora. Gli affreschi “anomali” sono essenzialmente tre: raffiguranti la Resurrezione di Cristo (fig. 11), le pie donne al sepolcro (fig. 12) e l’Assunzione in cielo di Maria (fig. 13). Essi sono atipici sia dal punto di vista stilistico che dal punto iconografico: basti pensare all'Assunzione della Vergine, un episodio alquanto slegato dal contesto della Passione in quanto non sono presentati altri fatti quali, per esempio, la Pentecoste[xvi].
Con tutta probabilità la narrazione comincia con la Resurrezione, un affresco molto rovinato e poco leggibile in cui si vede ancora Cristo che risorge con in mano il vessillo crociato, la sagoma del sarcofago e di un soldato. Contrariamente a quello appena citato, l’affresco della Pie donne al sepolcro verte in un ottimo stato conservativo che permette di leggerne tutti i dettagli: in primo piano si vede il sepolcro scoperchiato e l’angelo che lo indica. Alla scena assistono ben undici figure femminili, la più visibile e facilmente identificabile è Maria Maddalena, con il vasetto degli unguenti in mano e il canonico abito rosso. Questa scena è particolarmente interessante anche perché è “un episodio nell'episodio”, infatti con un po’ di attenzione, si può notare in basso a sinistra Gesù, nelle vesti di ortolano, che appare alla Maddalena. La coesione di due scene in una, è un fatto inusuale nella chiesa di San Rocco, come anche peculiare è lo stile utilizzato che fa pensare a una mano diversa rispetto a quella di Dioniso Bonmartini e aiuti. Sulla parete opposta è invece presente l’Assunzione della Vergine, il più rovinato degli affreschi dove si può solamente scorgere la figura sbiadita di Maria[xvii].
Gli altari laterali
Oltre ai meravigliosi affreschi, la chiesa di San Rocco è di grande importanza per le due pale d’altare che decorano gli altari ai lati del presbiterio di cui però vi parlerò in un’altra occasione![xviii] (fig. 14-15)
BIBLIOGRAFIA
Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994.
Il paesetto di Caneve d'Arco e la sua chiesina di San Rocco, a cura di F. Zendron, Trento 1964.
Podetti, Gli affreschi cinquecenteschi del Palazzo del Termine ad Arco, in “Sommolago”, XXV, 2008, 3, pp. 5-114.
CREDITI FOTOGRAFICI
- https://www.gardatourism.it/chiesa-di-san-rocco/
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g670770-d11963970-Reviews-Chiesa_di_San_Rocco-Arco_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adige.html
- https://elenaedorlando.wordpress.com/2013/10/20/passeggiate-domenicali/
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g670770-d11963970-Reviews-Chiesa_di_San_Rocco-Arco_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adige.html
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
- Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994
Note
[i] Ecclesiae: le chiese nel Sommolago, Arco 2000, p. 246.
[ii] Il paesetto di Caneve d’Arco e la sua chiesina di S. Rocco 1964, pp. 11-12.
[iii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 36-43.
[iv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 55-56.
[v] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 44-53.
[vi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 44-53.
[vii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 36-43.
[viii] E. Podetti, Gli affreschi cinquecenteschi del Palazzo del Termine ad Arco, in “Sommolago”, XXV, 2008, 3, pp. 21-29.
[ix] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.
[x] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.
[xi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.
[xii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.
[xiii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 75-86.
[xiv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.
[xv] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.
[xvi] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.
[xvii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 91-98.
[xviii] R. Codroico e R. Turrini, La chiesa di San Rocco a Caneve di Arco, Arco 1994, pp. 57-63.
LA CAPPELLA SANSEVERO DI NAPOLI
A cura di Ornella Amato
BAROCCO, ESOTERISMO, ALCHIMIA, ESALTAZIONE DINASTICA
“La cappella è glaciale.
Pavimento di marmo, marmo alle pareti,
tombe di marmo, statue di marmo”.
E ancora:
“Non ornamenti di oro, non candelabri, non lampade votive, non fiori,
tutto vi è gelido, tranquillo, sepolcrale“ - Matilde Serao
Napoli - Decumano Inferiore - Via Francesco de Sanctis 19/21:una segnalazione stradale turistica indica che si è giunti alla “Cappella Sansevero di Raimondo di Sangro”.
Il committente e l'origine della cappella Sansevero
Raimondo di Sangro, ottavo duca di Torremaggiore, settimo principe dei Sansevero, committente, mecenate generoso ma estremamente esigente, intellettuale, alchimista, esoterico, Gran Maestro massone, uomo carismatico per eccellenza, inventore, progettista, gentiluomo di camera al servizio di Sua Maestà il Re Carlo di Borbone, Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro.
La Cappella oggi è un museo privato tra i più noti e visitati della città di Napoli (nel 2019 le presenze sono state ben 750.000), ma soprattutto è un tempio carico di simbologia. Eppure l’origine stessa della Cappella ha la dolcezza della chiesetta gentilizia che fu edificata per voto e successivamente per accogliere le tombe di famiglia. I lavori edili per la costruzione della chiesa iniziarono nel 1593: si narra che un uomo innocente, incatenato e trascinato lungo San Domenico Maggiore, vide crollare una parte del muro di cinta del giardino dei Di Sangro e lì vi vide apparire un’immagine della Madonna, alla quale fece voto di donarle una lampada d’argento e un’iscrizione qualora fosse stato scarcerato e dimostrata la sua innocenza e così fu: l’uomo tenne fede al voto fatto.
Molte altre grazie furono elargite dall'immagine sacra e ne fu testimone anche il Duca di Torremaggiore Giovan Francesco di Sangro che, gravemente ammalato, fu miracolato dalla Madonna, dalla quale ottenne la totale guarigione: per gratitudine fece innalzare la cappella proprio dove era apparsa la Vergine e fu denominata “Santa Maria della Pietà” o “Pietatella”, ma successivamente, suo figlio Alessandro di Sansevero, Patriarca di Alessandria e Arcivescovo di Benevento, decise di ampliare la preesistente e piccola costruzione, per renderla degna di accogliere le spoglie di tutti componenti della famiglia di Sangro, come testimoniato dalla lapide marmorea datata 1613 posta sopra l'ingresso principale dell'edificio:
“ALEXANDER DE SANGRO PATRIARCHA ALEXANDIAE TEMPLVM HOC A FUNDAMENTIS EXTRVCTVM BEATAE VIRGINI SIBI AC SVIS SEPOLCRUM ANNO DOMINI MDCXIII “
Ovvero:
“ALESSANDRO DI SANGRO PATRIARCA DI ALESSANDRIA DESTINO’ QUESTO TEMPIO, INNALZATO DALLE FONDAMENTA ALLA BEATA VERGINE, A SEPOLCRO PER SE E PER I SUOI NELL'ANNO DEL SIGNORE 1613”.
Della fase Seicentesca della Cappella non resta quasi nulla, poiché il suo assetto attuale e le opere presenti sono il frutto dei lavori che volle realizzare Raimondo di Sangro.
Raimondo di Sangro nacque il 30 Gennaio 1710 a Torremaggiore in Puglia da Cecilia Gaetani dell’Aquila di Aragona e da Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. A causa della prematura scomparsa della madre e degli impegni del padre, fu ben presto trasferito dalla Puglia a Napoli nel palazzo di famiglia in largo San Domenico Maggiore, dove poi si stabilirà definitivamente nel 1737 a seguito della morte del padre.
La cappella Sansevero: descrizione interna
Il principe diede ben presto prova del suo intelletto e delle sue invenzioni, per le quali suscitò anche l’ammirazione degli ingegneri dello Zar di Russia Pietro il Grande, fu insignito delle cariche più elevate del regno di Napoli guidato da Carlo di Borbone, ma soprattutto, ampliò e arricchì la “Cappella di famiglia” che, a grandi linee, mantenne la struttura seicentesca con un’unica navata a pianta longitudinale e quattro archi a tutto sesto, al di sopra dei quali corre un cornicione, costruito con un mastice di invenzione del Principe, ed una volta a botte interrotta da sei finestre che illuminano l’intera Cappella ed una finta cupoletta all'altezza dell’abside, opera di Francesco Maria Russo di cui è certa la paternità anche della volta.

La volta della Cappella è stata infatti firmata da Francesco Maria Russo e datata dallo stesso al 1749 ed è un affresco noto come la “Gloria del Paradiso” o “Paradiso dei di Sangro” . E’ caratterizzato da squarci di angeli e figura varie che tendono a convergere verso il centro dove esplode la luce della colomba dello Spirito Santo.

Lungo il perimetro si trovano le finestre che rischiarano l’affresco e sono intervallate dai medaglioni nei quali sono raffigurati i Santi del Casato.
La pavimentazione settecentesca della cappella è estremamente complessa: anch'essa inventata dal Principe, presentava un motivo labirintico (da qui la denominazione corrente di “pavimento labirintico”) che è andato quasi completamente perduto nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1889, quando un’infiltrazione d’acqua provocò il crollo del ponte che collegava la Cappella al Palazzo stesso dei Sansevero.
I restauratori chiamati al ripristino della pavimentazione originale non riuscirono a risolvere e, nel 1901, si videro costretti a sostituire il preesistente pavimento con uno in cotto napoletano, realizzando al centro lo Stemma dei di Sangro in smalto giallo ed oro, riprendendo i colori della casata.
Del pavimento labirintico originale è possibile vederne i resti nel passetto antistante la tomba di Raimondo. Il pavimento labirintico, probabilmente, doveva rappresentare le difficoltà che s’incontrano sul cammino della conoscenza e di certo era parte integrante del “percorso” che all'interno della Cappella si snoda attraverso le statue presenti, che seguono un progetto iconografico voluto proprio da Raimondo di Sangro, di cui elementi fondamentali sono le 10 Virtù, di cui 9 di esse sono dedicate alle mogli degli esponenti della famiglia di Sangro e addossate a 9 pilastri, mentre la decima, il Disinganno, è dedicata al padre.
I monumenti funebri del casato, alla cui accoglienza la Cappella era da sempre destinata, si trovano invece all'interno delle cappelle laterali e tra le statue delle Virtù, nelle quali è anche possibile notare una serie di significati allegorici riferiti al mondo della massoneria, a cui il principe apparteneva in qualità di Gran Maestro.
Di tutte le sculture presenti, di certo la “triade d’eccellenza “ è rappresentata dal “Cristo Velato” che troneggia al centro della navata della Cappella, dalla “Pudicizia” alla sua sinistra e il “Disinganno” alla sua destra, tutte e tre che precedono l’Altare maggiore con l'altorilievo marmoreo della “Deposizione” di Francesco Celebrano.
L'opera raffigura l'episodio della Deposizione di Cristo dalla croce e, tra le figure, spiccano Maria e la Maddalena che assistono alla scena mentre sotto di loro si trovano due putti che sorreggono il sudario sul quale risalta un'immagine metallica del volto di Cristo.
Al di sotto del piano dell'altare altri due putti scoperchiano una bara, ormai vuota. La composizione dell'altare è completata lateralmente da due angeli in stile barocco realizzati da Paolo Persico, autore anche della cornice di angeli in stucco che circonda il dipinto della Pietà.
La datazione e l'autore del dipinto sono ignoti: probabilmente fu realizzata da un manierista napoletano prima del 1590 poiché a quella data risale infatti la prima testimonianza della sua esistenza, con il miracolo della sua apparizione all'uomo erroneamente arrestato ed alla cui storia è legata poi l’origine della cappella, sicché si tratta di un quadro a cui si è legati soprattutto per il significato intrinseco che esso stesso ha, piuttosto che per la qualità artistica.
Il Cristo velato: il capolavoro centrale della cappella Sansevero
Il Cristo Velato di Giuseppe Sammartino, datato 1753, è tra le opere più studiate, più controverse della storia dell’arte.
Il corpo esanime del Cristo è disteso su di un materasso marmoreo che diventa il giaciglio non solo del corpo senza vita del Redentore ma anche delle sofferenze patite nelle ore della Passione, e soprattutto di tutte le sofferenze dell’umanità intera, che Cristo ha salvato, nel momento in cui ha esalato l’ultimo respiro; il peso del corpo morto è delicatamente ricoperto dal velo.
Il velo, appunto, discusso e controverso. La diceria più famosa afferma che il velo fosse in origine in vero tessuto che sia stato trasformato il marmo attraverso un misterioso processo alchemico, con speciali prodotti, la cui formula sarebbe tutt'oggi segreta, un velo che conferisce leggerezza, una leggerezza che, in concreto, non ha.
E’ poggiato su un basamento su cui poggia un primo velo marmoreo su sui risalta il merletto lungo tutto il perimetro e sul quale, ai piedi del Cristo, sono poggiati la corona di spine e le tenaglie con le quali erano stati tolti i chiodi. Il capolavoro del Sammartino ha alimentato anche diverse dicerie, non solo legate al modo di realizzazione, ma si racconta che il Principe, dopo la realizzazione dell’opera, accecò il Sammartino per evitare che potesse realizzare opere di valore pari o addirittura superiori.
La sua imponente maestosità è tutta nelle parole di Antonio Canova quando, dopo averla vista, dichiarò che “…avrebbe rinunciato a ben 10 anni di vita, per averla tutta per sé…”.
In un primo momento pare che la statua fosse destinata ad essere collocata nella cavea sotterranea e sarebbe dovuto essere illuminato da una lampada di luce perpetua, ma l’imponente peso ne rese impossibile lo spostamento, sta di fatto che non sempre è stata al centro della navata, poiché, come dimostra uno scatto ottocentesco del fotografo tedesco Giorgio Sommer, era posta ai piedi della statua della Pudicizia.

Le statue laterali
Alla sinistra del Cristo Velato, maestosa, s’innalza la statua della Pudicizia, dedicata alla madre del Principe Raimondo di Sangro, una delle dieci Virtù rappresentate.

E’ considerata il capolavoro di Antonio Corradini e raffigura un nudo di donna ricoperto da un velo trasparente, il cui straordinario virtuosismo tecnico inaugura il genere delle “statue velate”; è datata 1752. La scultura raffigura una donna completamente coperta da un velo semitrasparente, cinta in vita da una ghirlanda di rose che le scende lungo il fianco destro, sfiorato dalla mano e, nella parte alta, il velo avvolge il capo lasciando intravedere le forme e i tratti del viso.

La composizione è carica di significati: la lapide spezzata sulla quale la figura appoggia il braccio sinistro, come - stando a diverse letture fatte da più critici – se fosse avvenuta una scossa di terremoto, magistralmente realizzata dallo scultore, lo sguardo come perso nel vuoto e l'albero della vita che nasce dal marmo ai piedi della statua simboleggiano la morte prematura della principessa Cecilia.
Di fronte ad essa, invece, si eleva la statua del Disinganno, realizzata da Francesco Queirolo.

E’ un corpo di uomo avvolto in una rete. Ma è semplicemente così? O forse è molto di più?

La scultura è opera del Queirolo è dedicata ad Antonio di Sangro, padre del principe Raimondo e raffigura sì un uomo che si libera da una rete, ma nella lettura più accettata vuole simboleggiare il peccato da cui era oppresso: in seguito alla morte della giovane moglie, il duca iniziò a condurre una vita disordinata e dedita ai vizi e ai viaggi, mentre il giovane Raimondo era stato affidato al nonno.
Ormai anziano, Antonio di Sangro tornò però a Napoli e, pentito dei peccati commessi, abbracciò la fede e si dedicò a una vita sacerdotale.
L’opera è di una straordinarietà disarmante. I nodi della corda con cui è fatta la rete, gli stessi nodi che la reggono, le dita delle mani infilate all'interno dei vuoti tra un nodo e l’altro rendono il tutto di un realismo stupefacente. Si dice che nessun aiutante dello scultore avesse il coraggio di dare le ultime rifiniture ai nodi della rete per paura di romperli.
La cappella Sansevero, però, è soprattutto il luogo in cui si trovano le tombe degli esponenti del casato e, ovviamente, tra di esse, si trova anche la tomba di Raimondo di Sangro, eretta quando lo stesso committente era ancora in vita e realizzata da Francesco Maria Russo nel 1759.

L’aspetto è semplice e sobrio, è composta da una grande lapide in marmo rosa sulla quale è scritto l’elogio funebre del Principe: le lettere bianche che lo compongono non sono incise, ma sarebbero state realizzate con un composto di solventi chimici di invenzione del Principe che, probabilmente, dovevano risaltare sul fondo rosa.
Sovrasta l’elogio un ritratto in età avanzata dello stesso di Sangro, raffigurato con indosso una corazza e all'interno di una cornice di marmo, mentre il tutto è sormontato da un grande arco decorato con armi, libri, strumenti scientifici, emblemi commemorativi e militari che celebrano le glorie del Principe.
Interessante è poi la presenza dell’Altare di Santa Rosalia, che sebbene la tradizione la voglia patrona della città di Palermo per aver salvato la città dalla peste, è “presente” nella Cappella di famiglia, in quanto apparteneva proprio alla nobile famiglia dei di Sangro, poiché figlia di Sinibaldo, conte dei Marsi e di Sangro.
Sotto la cappella Sansevero si trova la Cavea sotterranea dove sono conservati, all'interno di due teche, la cosiddette “Macchine Anatomiche”, ovvero gli scheletri di un uomo e di una donna in posizione eretta con il sistema arteo-venoso perfettamente integro.

Per quel che concerne tali strutture, molto si è detto e ancora si dirà e si scriverà, poiché leggende, studi ed oscurità ruotano intorno a questi due scheletri.
La storia ufficiale racconta che sono state realizzate dal medico palermitano Giuseppe Salerno e sarebbero state acquistate nel 1756 dal Principe a seguito di una esibizione pubblica dello scheletro maschile che l’anatomopatologo palermitano tenne e Napoli e, a seguito di questo acquisto, gli fu commissionato la realizzazione di quello femminile e lo scopo era legato a studi di anatomia e per questo era stato riprodotto un sistema arto venoso con diversi materiali, in particolare la cera d’api colorata.
Sta di fatto che leggende popolari giunte fino a noi raccontano – e lo stesso Benedetto Croce riferisce di tali credenze popolari – che non si tratti di “macchine anatomiche ” ma di veri e propri corpi di essere umani, in particolari di due servi del Principe che il di Sangro “fece uccidere e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie, le vene”; si racconta addirittura che i due poveri sventurati, ancora in vita abbiano subito un’iniezione contenente particolari antidoti che avrebbero indurito i vasi capillari, il ché avrebbe anche consentito lo studio anatomico su scheletri veri. A conferma di tale teoria, sarebbe il segno profondo di una corda su uno dei due scheletri, quasi a voler bloccare un uomo in fuga da morte certa.
La storia delle “macchine anatomiche” non fa altro che aggiungere altro mistero ad un luogo già di per sé particolare, che attira sempre più turisti e visitatori, tanto da raggiungerne la quota dei 750.000 , divenendo il museo più visitato di Napoli.
L’ultima parte della cappella Sansevero, posta alla fine dell’intero percorso espositivo, è la Sagrestia, oggi bookshop del museo.
Ad essa si accede attraverso un passaggio, posto accanto alla nicchia all'interno della quale è collocata la tomba dello stesso Raimondo.
Completamente rinnovato nel 2017, con arredi ultramoderni e dal layout funzionale, ma ispirati all'originale pavimento labirintico di cui in essa sono conservate grandi lastre di marmo.

Ospita non solo due monumenti funebri anch'essi dedicati a membri della famiglia, ma espone nelle vetrine strumenti di laboratorio probabilmente appartenuti allo stesso principe, oltre che conservare grandi lastre di marmo dell’originario pavimento labirintico.
Dal 2005 conserva la “Madonna col Bambino “ che fu commissionata dal di Sangro per farne dono a Re Carlo di Borbone.

Nella Sagrestia è in fase di collocazione il “Ritratto di Raimondo di Sangro principe di Sansevero” del pittore napoletano Francesco De Mura, che recentemente è entrato a far parte della collezione permanente delle opere esposte nel museo e che è stato presentato al pubblico ed alla stampa il 28 Gennaio 2020, in concomitanza del compleanno del principe che ricorre il 30 Gennaio.

Copyright museosansevero on Instagram.
L'opera, acquisita nel settembre 2019 dall'istituzione museale, proviene dal mercato antiquario madrileno, è databile intorno all'anno 1750, è stato acquistato dal museo Sansevero dalla Galleria Porcini di Napoli.
La nostra “visita” alla Cappella Sansevero, che era nata ed era stata concepita anzitutto come “cappella di famiglia”, e che oggi è un polo museale noto all'intero mondo dell’arte per essere divenuta lo scrigno di inestimabili capolavori, finisce qui.
Uscendo fuori dalla Cappella, volgendo lo sguardo al cielo – direbbe Dante – “per riveder le stelle” ci si sente arricchiti dentro, ma delle domande restano :
“Chi era realmente Raimondo di Sangro?”
“La mano dell’uomo, dell’artista che magistralmente muove e guida lo scalpellino, come ha potuto realizzare tutto ciò?”
“La mano dell’artista e quella dello scultore sono realmente guidate da Dio?”
Ai posteri l’ardua sentenza.
Sitografia:
museosansevero.it
ilmattino.it
repubblica.it
repubblica.napoli.it
napolimagazine.com
napolike.it
wikipedia.it
10cose.it
Vesuviolive.it
Social Network di riferimento:
museosansevero on Twitter
museosansevero on Instagram
Bibliografia:
F. Negri Arnoldi “Storia dell’Arte Vol. III” Fabbri Editori – Milano 1997
I RESTAURI ALLA LOGGIA DI PSICHE
A cura di Federica Comito
Introduzione
Gli affreschi di Amore e Psiche che oggi vediamo sono il risultato di una serie di restauri avvenuti nel tempo, che hanno modificato l’originale causando delle perdite irreparabili. In un percorso a ritroso analizzeremo tutto il percorso dell’opera, dalla sua ideazione a oggi, individuando eventuali interventi e manomissioni grazie allo studio dei materiali. Nel 1990 l’Istituto Centrale per il Restauro coordinato da R. Varoli Piazza procede al controllo degli affreschi della Loggia. Dopo aver indagato le problematiche strutturali, si è posta particolare attenzione ai restauri alla loggia di Psiche di Giovan Pietro Bellori e Carlo Maratti del 1693-94, eccezionali per l’innovazione concettuale e per la tecnica di intervento. È in questo momento storico che ci si pose il problema di quanto fosse lecito intervenire su un’opera così notevole, anche se lo scopo era di ripararne i danni. A guidare tale intervento il criterio, straordinariamente moderno, di utilizzare materiali reversibili affinché, come affermò Maratti “se qualcuno più degno di me di associare il suo pennello a quello di Raffaello, verrà un giorno, possa cancellare la mia opera e sostituirvi la sua”. In questo senso Bellori e Maratti precorrono l’odierna filosofia del restauro, inteso come rispetto della materia dell’opera d’arte.
Come avviene un restauro?
Il restauro contemporaneo si caratterizza per l’utilizzo di tecniche analitiche applicate alla chimica, fisica e biologia che permettono di non alterare l’integrità dell’opera e sono utilissime per lo studio diagnostico permettendo un’accurata indagine preliminare e un successivo prelievo di materiale per analisi più specifiche e approfondite. Tra queste, la tecnica fotografica; la riflettografia infrarossa; l’indagine radiografica; le tecniche spettrofotometriche. Il campionamento deve essere il più rispettoso possibile dell’integrità fisica dell’opera, limitato nel numero e nelle dimensioni dei prelievi. Lo studio di un campione richiede sofisticate metodologie analitiche, basate sull'impiego di tecniche strumentali altamente sensibili e selettive (tecniche microscopiche: microscopia ottica, mineralogico-petrografica, elettronica a scansione; microanalisi a raggi X; spettroscopia infrarossa; tecniche cromatografiche). Le successive tipologie di intervento sull'opera sono molteplici: la pulitura, la disinfestazione, la stuccatura e l’incollaggio, la foderatura dei dipinti su tela, il consolidamento, le reintegrazioni di dipinti, la stesura di protettivi.

I restauri alla loggia di Psiche del 1990
Le campagne di indagine nella loggia iniziano nel 1989-90 e sono state esclusivamente di osservazione diretta al fine di individuare la tecnica di esecuzione e di stabilire lo stato di conservazione dei dipinti, i problemi connessi con il restauro marattesco e quali fossero gli interventi successivi. La fase esecutiva si è svolta tra il 1990 e il ‘97. Di rilievo l’indagine di quei frammenti superstiti dell’azzurro di Raffaello e di quello usato da Maratti per rifare i cieli che si erano anneriti e la loro rimozione successiva ad opera di un restauro avvenuto nel 1930, che volendo eliminare per sempre quello che veniva considerato l’azzurro di Maratti, aveva asportato anche quello sottostante di Raffaello. Al termine delle operazioni di pulitura e assestamento, ci si è concentrati sull'aspetto estetico. La loggia appariva totalmente sbilanciata per l‘asportazione violenta dell’azzurro che lasciava in vista il celeste di preparazione o addirittura l’intonaco e per la presenza di grandi lesioni sul testo figurativo.

L’attenzione degli studiosi si è concentrata sul percorso progettuale della decorazione: si iniziava dagli schizzi per la definizione della prima idea, seguiva lo studio di singole parti della composizione, con la definizione successiva di un primo disegno particolareggiato dell’insieme, si proseguiva poi con lo studio analitico e dettagliato di tutte le parti; infine si realizzava il modello definitivo in scala ridotta. A questa fase di studio seguiva la fase operativa del cantiere, cioè la realizzazione del cartone principale con dimensioni rapportabili alla superficie muraria da dipingere. Poi si ricavava un “cartone secondario” che, sezionato, permetteva il trasferimento del disegno sull'intonaco ancora umido, come previsto dalla tecnica dell’affresco (così chiamata perché si esegue su un intonaco appena steso e non ancora asciutto).
I moderni restauri alla loggia di Psiche hanno permesso di delineare una possibile organizzazione del cantiere dove operarono Raffaello e la sua bottega. Il ponteggio utilizzato, probabilmente posto alla stessa altezza di quello cinquecentesco, ha consentito di osservare la volta dalla stessa angolazione visiva dei pittori, apprezzandone così ogni dettaglio tecnico. In particolare si è posta l’attenzione sulle varie tipologie di tratteggio, distinti in tratteggi cosiddetti “liquidi”, ovvero quelli effettuati a pennello, e quelli a “secco” realizzati a sanguigna o grafite. Questi ultimi, riferibili ad un intervento di restauro, sono segni rapidi e poco precisi orientati a conferire maggiore incisività alle ombre. Su quelli a pennello, trovandosi principalmente su porzioni di volto, si è preferito non effettuare prelievi di campioni da analizzare, preferendo attendere tecnologie più avanzate. Il loro aspetto e colore, chiaramente estraneo e di sovrapposizione alla policromia degli incarnati, conferma che sono successivi alla stesura pittorica che presenta già una modulazione cromatica e tonale di chiari e di scuri. Invece, alcuni dei tratteggi dallo stile più libero potrebbero essere attribuiti ad uno o due artisti della bottega di Raffaello che avevano il compito di realizzare dei ritocchi in una sorta di revisione finale della decorazione. Sembrerebbe che questo compito, unito alla realizzazione di particolari decorativi, spettasse a Giovanni da Udine insieme alla stesura dell’azzurrite sui fondi.

Il restauro di Maratti
Nel maggio 1693 hanno inizio i restauri alla loggia di Psiche a opera di Carlo Maratti, che si pone come il primo restauratore moderno in pieno rispetto della materia. Grazie alle indagini svolte negli anni ‘90 è possibile affermare che quello del Seicento fu un intervento scrupoloso e attento, in cui ogni fase pratica era preceduta da un’attenta valutazione. Gli affreschi di Raffaello coprono la parte centrale della volta, i dieci pennacchi e le quattordici vele, tutto il resto è posteriore. Bellori riferisce che i due o tre palmi inferiori dei pennacchi non erano dipinti, ponendo Maratti di fronte ad un problema di armonizzazione visiva. La sua integrazione delle parti mancanti è un’abile imitazione delle ghirlande e delle nubi dipinte da Giovanni da Udine; nonostante questo è evidente la discontinuità con l’originale che dimostra come Raffaello abbia realmente lasciato incompiuta la pittura, ma facendo intuire come intendesse completarla.

Il problema degli azzurri nei restauri alla loggia di Psiche
Il pesante intervento di rimozione degli azzurri operato durante il restauro del 1930, ha reso arduo lo studio dei cieli della Loggia di Psiche e di quelli sovrapposti nei secoli successivi. L’azzurro chiaro che costituisce lo sfondo su cui si stagliano le figure e i festoni vegetali è semplicemente la preparazione che Raffaello stese prima della finitura a secco in azzurrite, che doveva essere caratterizzata da una tonalità molto più intensa. Tale stesura preparatoria è stata eseguita a fresco a smalto (un pigmento a base di vetro colorato al cobalto), applicato su un sottile strato bianco ottenuto con calce e polvere di marmo posto a diretto contatto con l’intonaco con l’evidente funzionalità di costituire una base riflettente, che rendesse più luminosa la tonalità finale ottenuta attraverso le varie stesure di azzurro. Della finitura a secco in azzurrite, che ricopriva integralmente la preparazione a smalto, rimangono purtroppo solo i frammenti scampati alla violenta raschiatura degli anni ‘30. Si tratta di frammenti conservatisi al di sotto dello stucco che ricopriva le 850 grappe metalliche a forma di T o L lunghe dai 9 ai 13 cm applicate da Maratti e quindi in queste zone il pigmento è rimasto protetto dagli agenti esterni e si è conservato indenne da qualsiasi sostanza estranea.

La finitura a secco in azzurrite è servita inoltre nel caso di alcuni ripensamenti, per correggere quei dettagli che l’artista voleva modificare, andando a coprire porzioni già realizzate.
Le analisi effettuate su prelievo e le selezioni stratigrafiche della finitura dei cieli della Loggia di Psiche hanno evidenziato che si trattava di un’azzurrite di origine naturale, di tono intenso, applicata a secco utilizzando la colla come legante. Il problema centrale relativo alle alterazioni degli azzurri della Loggia riguarda il fenomeno di annerimento dell’azzurrite. Tracce di azzurrite annerita sono presenti lungo i bordi dei festoni vegetali di Giovanni da Udine. È difficile identificare con certezza il fattore di degrado che ne ha causato l’annerimento: è possibile pensare a una pulitura aggressiva effettuata con sostanze chimiche, oppure a fonti di calore accese al di sotto della Loggia, come per esempio i grandi bracieri utilizzati per il riscaldamento dell’ambiente.

L’equivoco
Stando alle fonti storiche, Maratti effettuò una ridipintura dei fondi basandosi su quelle parti originali di azzurrite che non erano alterate. Il suo intervento fu soggetto a polemiche e giudizi negativi per secoli, relativi anche al cattivo stato di conservazione che mostravano gli affreschi. Tra il 1915 e il 1930 si giunse all'infausta decisione di liberare i fondi allo scopo di recuperare quello che si presumeva fosse l’azzurro di Raffaello coperto dall'operato di Maratti. L’intervento di rimozione, effettuato in maniera del tutto irrispettosa delle tecniche originali e dei precedenti interventi di restauro, si basò su un grosso equivoco: l’azzurro da rimuovere non era stato applicato da Maratti, ma risaliva all'Ottocento, come è risultato dall'esame chimico. Dalle tracce rinvenute nel corso dell’intervento diretto da Varoli Piazza è stato possibile evincere che Maratti effettuò la ripresa dei fondi originali utilizzando dello smalto, volendosi avvicinare il più possibile allo sfondo di Raffaello senza sconvolgerlo.
I problemi di stabilità e le indagini
Le indagini svolte dall’ICR dal 1994 sulla struttura architettonica della villa hanno confermato che le cause dei dissesti debbano essere imputate a fattori climatici e idrologici, ai difetti costruttivi e alla pericolosa vicinanza del Tevere. La novità, importantissima, che gli studi di stabilità hanno messo in luce è che sono ancora presenti movimenti strutturali nell'intera costruzione. È stato compiuto uno studio geognostico e geotecnico al fine di indagare le caratteristiche del suolo, e dai risultati è apparso evidente che potrebbe esserci nel tempo un peggioramento delle condizioni statiche della villa con la conseguente distruzione dei dipinti murali. Tra le probabili cause troviamo: la costruzione dei muraglioni del Tevere, la costruzione delle strade e le conseguenti vibrazioni provocate dal traffico incessante. Particolare attenzione è stata posta alla Loggia di Psiche che risultava particolarmente compromessa per la presenza di gravi lesioni trasversali alla volta, dalle quali derivano una serie di lesioni minori con andamento longitudinale alla volta. Grazie all'ultimo intervento di restauro sono state ristabilite la coesione e l’adesione del film pittorico, l’adesione delle dorature e degli strati preparatori, il distacco e la riadesione dei frammenti; la pulitura e i ritocchi (incarnati, festoni vegetali, bordi degli arazzi, sottarchi), la rimozione di stuccature e oggetti metallici non idonei, il trattamento delle grappe metalliche e, infine, è avvenuta la reintegrazione pittorica con acquerelli.
Conclusione
Tramite i restauri alla loggia di Psiche coordinati da Varoli-Piazza è stato dimostrato che Maratti, alla fine del Seicento, si preoccupò di proteggere gli affreschi eliminando le cause di deterioramento ambientale ed effettuando un restauro di tipo conservativo, una novità per il periodo. Inoltre è stato possibile smentire categoricamente tutte le accuse rivolte al rovinoso intervento marattesco, dimostrando che si trattasse di un restauro molto più tardo. È stato evidenziato invece un comportamento rispettoso dal punto di vista metodologico per l’organizzazione del lavoro, e dal punto di vista tecnico per la scelta dei materiali impiegati, molto più rispettoso di restauri più recenti.
BIBLIOGRAFIA
Shearman, Studi su Raffaello.
Varoli-Piazza, Raffaello, La Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina.
Bellori, descrizione delle immagini dipinte di Raffaello d’Urbino.
Enciclopedia Treccani.
LA BASILICA DI SAN GAVINO A PORTO TORRES
A cura di Alice Oggiano
Cenni storici sulla basilica
La basilica di San Gavino si erge sul tratto di costa a sud dell’abitato della colonia medievale di Turris Libisonis, attuale Porto Torres. La chiesa si configura nel territorio isolano come un unicum, complici non solo la maestosità ed ampiezza delle sue forme, ma soprattutto l’assoluta singolarità nell'impianto longitudinale a due absidi opposte. Tale iconografia, rarissima nell'Italia continentale, fu soggetta a studi particolarmente arditi sotto il profilo storico-artistico, nel tentativo di restituirne una genesi strutturale il più attendibile possibile. Sappiamo con certezza che San Gavino fu cattedrale arcivescovile dal 484 d.C, anno durante il quale un suo vescovo partecipo’ al concilio di Cartagine. La sede verrà trasferita a Sassari nel 1441 d.C.
Le fonti più antiche inerenti alla basilica sono rintracciabili nella carta n.43 risalente al regno di Barisone I o Mariano I. Passando al vaglio delle testimonianze leggendarie ed agiografiche, particolarmente interessante è l’inventio del rinvenimento dei corpi dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, risalente al XIII-XIV secolo. L’inventio doveva costituire l’appendice della Passio relativa ai tre protomartiri turritani ai quali venne titolata la chiesa. La venerazione nei confronti dei tre santi in età giudicale deriva da una più ampia devozione risalente all'età paleocristiana. L’erezione della basilica e la presenza delle reliquie insite in essa vengono attribuite al giudice Comita, come ex voto pronunciato da quest’ultimo a San Gavino per la guarigione dalla lebbra. Comita, per adempiervi, oltre alla costruzione della basilica, vi fece traslare le reliquie dei santi dalla basilica di Balai nella quale subirono il martirio, detta di S.Gavino iscabittatu (‘’decapitato”). L'edificazione venne commissionata a maestranze pisane, già presenti in Sardegna in altre fabbriche. Altre preziose nozioni ci vengono fornite dal Condague (documento amministrativo in uso nella Sardegna bizantina e giudicale) di fondazione e consacrazione, apografo del 1620. Stando ad esso, la fabbrica venne edificata in due tempi distinti, a cavallo tra il regno di Comita e di Barisone I (fig. 1).

Recenti studi hanno inoltre rilevato il carattere cimiteriale della chiesa. Recenti indagini archeologiche attestano, oltre a lacerti musivi ed elementi di corredo funebre, la presenza di due basiliche erette in una fase precedente a quella romanica. Una di esse, causa l’abside rivolta ad ovest, si postula essere stata certamente edificata in periodo precedente al V secolo, durante il quale entrò in uso la norma liturgica dell’abside orientata. Nei pressi della chiesa, contrapposta alla seconda fabbrica preromanica con abside ad est, furono rinvenute sufficienti costruzioni e fondamenta per classificarla come adibita ad uso cimiteriale. Venne tuttavia scartata dagli studiosi l’ipotesi relativa all'eventuale condizionamento da parte delle fabbriche poste nell'area di costruzione della fabbrica romanica, in quanto durante l’epoca in cui quest’ultima venne edificata non furono più visibili. Questi dati ci permettono però di restituire maggiore veridicità agli scavi intrapresi tra il 1614 e il 1616 dall'arcivescovo di Sassari Gavino. Manca nell'ambito della ricerca dei corpi santi, durante i quali venne rinvenuto il sacello cruciforme contenente le reliquie dei martiri posto al di sotto dell’altare maggiore ed identificabile come memoria.
La basilica di San Gavino
La basilica romanica, realizzata in blocchi di pietra calcarea posti magistralmente in opera, presenta una pianta longitudinale a tre navate (laterali voltate a crociera e centrale a capriate lignee), con absidi opposte sui lati brevi. Collocati all'interno vi sono sette altari, successivamente andati perduti. L’ingresso avviene mediante il portale realizzato in forme gotico-catalane posto a sud, o tramite il portale romanico situato a nord (fig. 2 e 3).
La presenza delle due absidi deve essere letta alla luce delle vicende storiche in cui la basilica sorse: tra l’XI-XII secolo il giudicato logudorese si trovava ad esprimere una sempre più marcata autonomia da Bisanzio e da Cagliari (fig. 3a).

È possibile perciò che si scelse, nell'edificazione di San Gavino, di volgersi a stilemi di tipo imperiale con un forte richiamo all'arte di tipo carolingio-ottoniano, nonostante vi siano ipotesi tese a naufragare questa tesi, vedendovi assonanze con prototipi renani. Accese discussioni videro inoltre coinvolto il portale romanico, dalla dubbia e ormai suffragata attribuzione all'ambito gotico. D’estremo interesse la lunetta del portale romanico, la quale riporta una scena di combattimento realizzata con la tecnica del basso rilievo, probabilmente parte di un ciclo iconografico più complesso e denso di significato (fig. 4).

Dovevano essere inoltre comprese nel progetto le mensole-capitelli riportanti sculture ad altorilievo, chiaramente identificabili come un uomo e una donna (Adamo ed Eva?). Si osservino inoltre i girali fitomorfi posti sulla superficie esterna delle mensole-capitelli, in cui possibili chiavi di lettura hanno voluto identificare la presenza di un serpente, con un rimando perciò dell’intero ciclo scultoreo all'Eden, connotato da un evidente horror vacui (fig. 5).

Caratteristiche peculiari della basilica di San Gavino sono l’utilizzo di elementi e materiali di reimpiego a fine antiquario con un forte richiamo alla classicità e l’evidente legame ai modelli pisani. Le colonne e capitelli antichi provengono da epoche diverse e sono organizzati con cura: la maggior parte tardoromani, quattro bizantini e uno altomedievale. Notevole il riutilizzo di tre capitelli isiaci, rilavorati con colombe affrontate alla croce che spuntano da foglie d’acanto. Riportanti colombe anche altri due capitelli di reimpiego, uniformati alla lavorazione bizantina “a due zone”, assai diffusa tra la fine del III e la metà del IV secolo d.C (fig 6 e 7).
Nel corso del XVIII secolo verrà posta all'interno della chiesa la statua equestre, con anima lignea e superficie policroma, di San Gavino, patrono di Porto Torres, ad opera di bottega romana (fig. 8).

Sono presenti inoltre tre simulacri lignei policromati che ritraggono i SS. martiri Gavino, Proto e Gianuario, realizzate da anonimi intagliatori-pittori, verosimilmente appartenenti ad una bottega napoletana dei primi anni del 1600. Le statue raffigurano i martiri distesi sul letto funebre, coi polsi legati e con un netto taglio alla gola, dalla quale sgorga un rivolo di sangue in riferimento al martirio subito. Secondo la tradizione agiografica, i tre santi vennero decapitati poiché cristiani durante le persecuzioni ad opera degli imperatori Diocleziano e Massimiano. Le statue, oltre a costituire un'importante opera d'arte, sono motivo di culto popolare: ogni anno, il 3 Maggio, vengono trasportate dalla basilica di San Gavino sino alla chiesetta di Balai ove rimangono sino alla Pentecoste (fig. 9).

Al di sotto della basilica è situata la cripta, alterata dal restauro sei-settecentesco ma tutt'oggi accessibile al pubblico (fig. 10).

E' preceduta da una maestosa anticripta che richiama per forme e stilemi l'età rinascimentale classica. Poste entro edicole intervallate da lesene scanalate vi sono le statue marmoree di martiri e vescovi locali, realizzate con abile maestria, connotate da una grande resa plastica ed estremamente naturalistica. Tramite una scalinata d'accesso qui posta, si raggiunge la cripta. L'ambiente, lungo e basso, è interamente voltato a botte. All'estremità occidentale è collocata la cappella con alcuni sarcofagi contenenti le reliquie dei martiri turritani. Altri sarcofagi d’epoca classica sono posizionati all'interno dell’ambiente. Tra essi, esemplari il sarcofago romano delle muse ed il sarcofago romano strigilato con la figura del buon pastore, entrambi ascrivibili alla fine del III secolo d.C. L'utilizzo dello strigile come mezzo e tecnica incisoria, oltre all'utilizzo stesso del marmo, è un ulteriore dato teso a dimostrare come la Sardegna fosse perfettamente inserita in uno scenario storico-artistico nel solco della tradizione classica e di quanto accadeva nell'Urbe, dalla quale importava marmi probabilmente già parzialmente lavorati da botteghe ostiensi. Elemento che ci aiuta a collocare temporalmente il sarcofago è la presenza del buon pastore, teso a rappresentare la presenza divina di Cristo senza tuttavia servirsi di un'iconografia propriamente cristiana, ma nel solco del paganesimo (fig. 11 e 12).
E' importante ricordare a tal proposito che la religione cristiana venne riconosciuta ufficialmente solo a partire dall'editto di Costantino del 313 d.C, divenendo religione di stato con Teodosio I nel 380 d.C con la promulgazione dell'editto di Tessalonica. Notevole la presenza dell’architrave marmoreo riportante l’epigrafe marmorea in greco bizantino, databile alla metà del VII secolo. Quest’ultima celebra la vittoria del dux Costantino sui Longobardi e “altri barbari”, rimandandoci all'ormai evidente indipendenza del regno logudorese da Costantinopoli, secondo una direttiva tutta occidentale dei giudici bizantini. La basilica di San Gavino è attualmente la più importante di Porto Torres e sede parrocchiale, oltre ad esser la chiesa romanica più grande della Sardegna. Al nome del santo è inoltre legata la festa più sentita dell'intero paese: la Festha Manna (festa grande), volta a onorare i santi martiri turritani. Durante la celebrazione, indice di grande devozione, la traslazione delle menzionate statue lignee dei santi nella chiesetta di San Gavino "decapitato" (fig 13).

Bibliografia e sitografia essenziale:
Sardegna preromanica e romanica, Roberto Coroneo - Renata Serra
Treccani, enciclopedia dell'Arte Medievale
Sito ufficiale del comune di Porto Torres
FRANCESCO COLELLI PITTORE
A cura di Felicia Villella
Introduzione: la famiglia di Francesco Collelli
Le notizie relative alla famiglia Collelli e al suo arrivo nella città di Nicastro non sono del tutto chiare. Dai registri della Cattedrale di Nicastro è possibile risalire ai nomi di alcuni componenti della famiglia a partire dalla fine del 1500, ma con molta probabilità si tratta di una famiglia nobile proveniente dalla città di Rieti, trasferitasi in Calabria. Di sicuro si sa che Francesco Colelli nasce a Nicastro il 27 gennaio del 1734, figlio di Domenico e di Teodora De Napoli. Anche Domenico quasi certamente faceva il pittore, ma non ci sono giunti documenti che lo attestino, dunque è difficile attribuire delle opere alla sua mano.
La famiglia era fregiata del titolo di magister, già il nonno Antonio aveva questo appellativo, sicuramente perché aveva familiarità con pratiche artistiche o forse artigianali: è possibile ipotizzare una professione come architetto o capomastro.
La casa in cui abitava la famiglia di Francesco si trovava in Contrada San Francesco, in quella definita ruga di Blasco, di fianco al giardino di don Francesco Blasco, padrino, tra l’altro, dell'artista.
Francesco Collelli visse in questo quartiere fino al giorno del suo matrimonio, ed è proprio nella chiesa di San Francesco che troviamo l'opera più antica a lui attribuita, oltre che ad una serie di affreschi e tele più tarde che testimoniano la sua continua affezione nei confronti di questo luogo sacro.
In seguito ritroviamo una firma del Colelli nell'anno 1758 su documenti notarili che rimandano ad un gruppo di affreschi andati perduti realizzati nella chiesa di Santa Caterina a Nicastro.
Gli anni che succedettero a queste prime committenze segnarono profondamente il territorio; il 1764, ricordato come l’anno della fame a causa di una segnante carestia, portò la famiglia D’Ippolito a commissionare una Ultima Cena all'artista, perduta anch'essa, da presentare in Cattedrale al posto della consueta offerta in olio e noci.
Tra il ‘68 e il ‘70 morirono sia Domenico Colelli che la moglie Teodora, lasciando ai figli l’intera eredità; la famiglia possedeva all'interno della chiesa di San Francesco una sepoltura, in cui furono seppelliti oltre al nonno Antonio anche i genitori del nostro artista, fuorviando ogni dubbio sull'attaccamento per questo luogo.
Nel 1770 sposò Costanza Gigliotti, originaria di Falerna, che da anni viveva presso la sorella a Nicastro; dal matrimonio nacquero due figli, Domenico Antonio, nato 10 anni dopo il matrimonio, e Giovanna, nata nel 1792.
L'attività artistica
Iniziano gli anni di fervente attività artistica: Francesco Collelli realizza la Madonna del Carmine di Carlopoli con lo stesso stile pittorico riconducibile alle opere presenti a San Domenico a Nicastro; seguono la Madonna del Carmine di Castagna e gli affreschi presenti nella chiesa di San Giovanni Battista a Nocera Terinese ed un ciclo pittorico di Badolato.
A causa dell'alluvione del torrente Piazza che distruggerà parte del quartiere di Terravecchia, Francesco fa richiesta alla Cassa Sacra di un terreno nel Boschetto dei Riformati, ma con molta probabilità non usufruirà mai di tale donazione proprio perché in quegli anni il figlio Domenico Antonio sposa la catanzarese Mariangela Scalfaro; ne seguirà un definitivo trasferimento dell'artista nella città di Catanzaro.
Il suo trasferimento non dipende solo dal matrimonio del figlio, ma è dovuto soprattutto all'avvio delle opere di ricostruzioni del capoluogo che sono seguite al terremoto del 1783, che devastò diversi edifici ecclesiastici e civili, richiamando a sé numerose maestranze.
Non era la prima volta che Francesco si recava nel comprensorio catanzarese, anzi aveva in passato intrapreso diversi viaggi tra cui quello a Taverna, città del Cavaliere Calabrese, un incontro quello con le opere del Mattia Preti che lo segnerà sicuramente nella sua esecuzione stilistica.
Il problema è che in questo periodo di veloci restauri raramente i lavori eseguiti vengono riportati nei registri delle ristrutturazioni causate dal terremoto del 1783, di fatti, tranne che per il ciclo di affreschi di Marcellinara di cui l’attribuzione è sicura, per le altre opere si può ragionare solo per paragoni tecnico esecutivi e resa stilistica.
La fama del Colelli cresce e l'artista ormai anziano continua ad avere un elevato favore sia per commissioni di impronta religiosa che privata; a lui è attribuito un altro ciclo pittorico presente nella Matrice di Magisano del 1813; si tratta di un vasto affresco, forse il più grande da lui eseguito, in cui probabilmente si può riscontrare l'intervento non solo del figlio, che nel frattempo ha intrapreso la via paterna, ma anche di artisti minori.
È recente l’attribuzione di due dipinti che raffigurano Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando IV di Borbone, attribuzione concepita dal prof. Mario Panarello a cura della mostra "Riverberi pittorici" tenuta nella città di Lamezia Terme nell'autunno del 2019. Con molta probabilità la realizzazione delle opere dei due coniugi si rifà ad alcune stampe che proponevano il sovrano all'età di otto anni, quando ascese al trono, e la regina ripresa con molta probabilità dal frontespizio dell’opera enciclopedica del monaco Benedetto Tromby che tratta la storia dell’Ordine Certosino dei primi anni del 1770 [1].
Il 6 gennaio del 1820 muore nella sua casa di Gimigliano il figlio Domenico Antonio Colelli, ed esattamente 11 giorni dopo, il 17 gennaio 1820, morirà anche Francesco Colelli a Zagarise, dopo che la nuora si era ivi trasferita insieme alla figlia [2].
Note
[1] M. Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;
[2] M. Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.
Bibliografia
Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli. Corigliano – Rossano 2019, pp.197 -199;
Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999, p.26.
IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO
A cura di Giulia Pacini
STORIA DELL'EPISCOPIO
BREVI CENNI STORICI SULL'EDIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO
Il complesso monumentale del duomo di Osimo, chiamato anche complesso dell’Episcopio, è stato creato nel corso del tempo dagli interventi dei vescovi osimani che ne hanno voluto la realizzazione, e che hanno dato vita alla attuale diocesi. Gli interventi che caratterizzano questo insieme sono vari, perché riflettono appunto le varie fasi storiche che ne hanno visto la graduale realizzazione. La documentazione che racchiude in sé la storia di questo edificio è stata raccolta e sistemata da Monsignor Carlo Grillantini, uomo di chiesa e storico, a cui si deve la più completa indagine storiografica riguardante la città di Osimo e la sua cattedrale. La residenza vescovile, edificata, si ipotizza, dal vescovo Leopardo e diventata poi dimora del vescovo Berardo (1283-1288), crollò, venne ricostruita e poi crollò nuovamente. Tra il 1295 ed il 1320, sotto Giovanni Ugoccione, vescovo al tempo di Bonifacio VIII, furono compiuti i lavori di rifacimento, in quanto alcune parti del palazzo vescovile erano andate distrutte in seguito a eventi naturali (si registrarono scosse di terremoto che distrussero tale area). Non abbiamo tuttavia alcuna notizia di restauri o di ampliamenti consistenti. I grandi lavori che invece portarono la struttura ad essere quella che oggi conosciamo sono dovuti a due vescovi della nota famiglia osimana Sinibaldi, ossia Antonio (1498-1515) e Giovan Battista (1515-1547): dopo la ribellione di Boccolino di Guzzone, nel 1484, e i danni all'Episcopio che ne seguirono, al loro servizio episcopale fu riservato il compito della ricostruzione della cattedrale in primo luogo, e successivamente dell’Episcopio. Tale impegno ed operosità fu riconosciuto affiggendo una lapide con lo stemma Sinibaldi all'esterno delle mura a nord, all'altezza del Presbiterio, dove tuttora si trova (fig. 1 e 2).
Giovan Battista Sinibaldi si occupò in special modo dei lavori dell’Episcopio, che consistettero nell'unione dei due corpi di fabbrica già costruiti da Berardo ed Ugoccione, e cioè quello caratterizzato dai grandi finestroni che anche oggi sono visibili da nord-est e quello che corrispondeva alla cucina ed al tinello dei vescovi finché vi ebbero la loro abitazione. Furono costruiti anche altri corpi di fabbrica facilmente individuabili per la presenza di scritte e di stemmi dei Sinibaldi: l’architrave di una finestra del cortile interno del duomo, altri architravi delle finestre rivolte verso il palazzo comunale e, all'interno del palazzo, stipiti in pietra del piano nobile. Il Cardinal Anton Maria Gallo (1591-1620) fece costruire la parte che unisce il fabbricato dei Sinibaldi alla cattedrale; costruì anche la sacrestia con balcone a nord. Il Cardinale Agostino Galamini (1620-1639) ingrandì a nord il palazzo vescovile, innalzò un torrione per venerare la Basilica della Santa Casa di Loreto, costruì la cancelleria: l’opera del Galamini riguarda il corpo di fabbrica addossato al battistero da ogni lato. Lo stemma del Cardinale, collocato nella lunetta di ferro battuto che sovrasta l’attuale portone di entrata dell’episcopio, testimonia che la sua opera ha riguardato, sia pur marginalmente, anche il corpo centrale del fabbricato. Opera del Vescovo Pompeo Compagnoni (1740-1774) è il portone in legno massiccio, come indicano i due stemmi in legno e l’anno (1770). Un documento di eccezionale importanza per comprendere meglio le fasi di costruzione e la storia del complesso Duomo-Episcopio-Battistero, è stato rintracciato a Jesi, presso la Biblioteca comunale. Si tratta di un disegno che mostra nel dettaglio la planimetria del Duomo, del Battistero e del Palazzo Episcopale di Osimo, così da farci notare le differenze e le modifiche che sono state apportate all'antico complesso al tempo del Cardinal Bichi (1656-1691). Sulla base degli studi effettuati da Claudia Barsanti, è possibile pensare che la planimetria della nuova ala fosse stata eseguita su richiesta dello stesso Cardinal Bichi e destinata forse a suo fratello, Vescovo di Todi, che, non a caso, ebbe come successore Mons. Giuseppe Painetti, di cui ampiamente trattano i documenti jesini. La datazione di questo intervento pertanto si propone intorno al 1680.
IL COMPLESSO DELL'EPISCOPIO A OSIMO: PRINCIPALI INTERVENTI ARCHITETTONICI
Da un confronto dei dati acquisiti attraverso l’attenta lettura del disegno e di quelli già noti, emergono significative novità, come ad esempio la collocazione dell’altare maggiore del Duomo in posizione sopraelevata di alcuni gradini all'interno dell’abside, una sistemazione questa tra l’altro inedita. Solo qualche decennio dopo il Cardinale Giacomo Lanfredini (1734-1740) lo farà spostare verso la fronte del Presbiterio sostituendo quello del Bichi con un sontuoso manufatto incrostato di marmi policromi. Si deve al Cardinal Bichi anche lo spostamento della cattedra-trono episcopale che nel disegno compare addossata all'angolo sud dell’abside. Va inoltre segnalata la presenza di sei altari addossati alle pareti delle navate laterali, rimossi alla fine del XIX secolo, e di una scala esterna, addossata al campanile ed in parte alla parete sud del Duomo, attribuibile con ogni probabilità agli interventi del Card. Galamini: si notino i due archetti “faccia a vista” della parete attuale della Curia verso il cortile dell’Episcopio che potrebbero denunciare una relazione con tali rifacimenti. Altre novità, ma non di natura architettonica, riguardano il disegno, fino ad oggi sconosciuto, del giardino, con la esatta ripartizione degli spazi, dall'altezza della costruzione sopra Porta S. Giacomo. Anche se in forma schematica, il disegno appare piuttosto accurato ed è accompagnato da legende esplicative, corrispondenti ai numeri arabi posti nella planimetria. Troviamo riscontro dei lavori, specie per quanto riguarda il Palazzo episcopale, grazie alle informazioni che ci lascia Flaminio Guarnieri (1604-1684), il quale descrive nel dettaglio i lavori fatti eseguire dal Cardinal Bichi, a completamento di quelli precedentemente realizzati dal Cardinal Galamini, al cui nome si deve infatti ricondurre l’erezione di tutto il corpo di fabbrica meridionale addossato al Battistero, destinato al Vicariato ed alla Cancelleria. Non è difficile, commenta Grillantini, individuare quel nuovo corpo di fabbrica: Bichi costruì infatti il piano superiore che sovrasta la vecchia sacrestia del Vescovo Gallo, dando nuovo assetto agli ambienti settentrionali dell’ Episcopio fatto costruire dal Sinibaldi, creando una serie di stanze sopra le mura castellane, corrispondenti agli ambienti a nord segnati nella pianta al n. 24. Per quanto riguarda i sotterranei Grillantini fa notare che in quei camminamenti vi era uno stemma dei Bichi su una colonna di tufo. Viene infine descritto tutto il corpo di fabbrica annesso all'Episcopio che guarda la piazza del Comune, cioè l’alto palazzo addossato a levante del giardino, dove ora hanno sede gli uffici e gli ambulatori dell’ Unità sanitaria locale e la Banca Popolare di Ancona. Sullo spigolo sud-orientale di quella sorta di sperone che fronteggia il lato occidentale del Palazzo Comunale, risalta un’iscrizione fatta porre proprio dal Bichi che così recita: PARTEM HANC ARCIS / IAM DIRUTAE NOVUM / REDEGIT IN OPUS / ANT(onius) BICHIUS / EP(iscop)US AUX(imanus) / 1668 (Antonio Bichi Vescovo di Osimo ha trasformato in una nuova costruzione questa parte della Rocca già demolita Anno 1668). Un’altra iscrizione, posta in passato verso l’interno del giardino ed ora nell'androne della Curia, recita: D(eo) O(ptimo) M(aximo) / AD SUCCESSORUM COMMODA / HORREA CRIPTAS EQUILIA CARCERES / NOVAE MOLIS ACCESSIONE CONSTRUXIT / / ANTONIUS CARD BICHIUS EP(iscop)US / ANNO MDCLXX (A Dio Ottimo Massimo. Il Vescovo Antonio Cardinal Bichi costruì, con l’aggiunta di nuovi grandi edifici, i magazzini, le cantine, le scuderie, le carceri, per utilità dei Successori Anno 1670). Dopo il Bichi non furono realizzate altre grandi costruzioni: l’intervento dei vari Vescovi riguardò solo lavori complementari, tra i quali ricordiamo alcuni interventi significativi: il Cardinal Guido Calcagnini (1776-1807) abbellì l’interno dell’ Episcopio e fece costruire la loggia che dal giardino guarda la Piazza del Comune; Michele Seri-Molini (1871-1888) destinò il piano superiore dell’Episcopio a sede di un piccolo seminario da lui direttamente curato; Egidio Mauri (1888-1893) trasformò il piano superiore dei magazzini del Bichi in teatro. Qualche intervento lo fece anche Monalduzio Leopardi (1926-1944); si devono al Vescovo Domenico Brizi (1954-1964) un completo restauro, la ristrutturazione interna della parte dell’edificio vicina all'ingresso e la nuova sistemazione del cortile interno del Duomo, abbassato con il ripristino della vera da pozzo.

| 1. scale e loggia del Domo; | 2. Chiesa del Domo; | 3. Choro; |
| 4. Sedia trono episcopale; | 5. Stallo sedie de canonici; | 6. Sedie de benefitiati; |
| 7. Sedie de Magistrati; | 8. Loco da far Credenza | 9. Per li coristi – Scala di mezzo per andar al presbiterio, scale laterali per andare al medesimo e per di sotto di una chiesa sotterranea devota; |
| 10. Ingresso al palazzo; | 11. Cortile dove gira la muta; | 12. Sala de staffieri; |
| 13. Anticamera; | 14. Cappella; | 15. Camera d’udienza; |
| 16. Retrocamera; | 17. Screteria; | 18. Camerini d’estate e d’inverno; |
| 19. Appartamento da levante bono in ogni tempo per dormire nell’ultima camera verso il giardino; | 20. Studiolo secreto; | 21. Camera per la guardia; |
| 22. Camera per robba da vestir; | 23. Libraria senza libri; | 24. Anticamera forestaria; |
| 25. Corritore vicino alla sacrestia dove si va in chiesa nei tempi cattivi, e di dove si cala segretamente di sotto alle officine | 26. Sacrestia della chiesa; | 27. Stanza del capitolo; |
| 28. Cortile; | 29. Cimiterio; | 30. Cancelleria del piano; |
| 31. Di sopra appartamento per il vicario; | 32. Galleria sopra vi sono tre camerini da sole; | 33. Chisa di San Giovanni con un battistero di bronzo singolare; |
| 34. Campanile; | 35. Salone da passeggio, e per comedie, e per granaro; | 36. Porta della città di San Jacopo. Dalla detta porta e strada sarà alto il detto piano delli detti appartamenti , circa quattro picche per esser nel colle. Sopra il numero 12, 14, 19 sino al 24 verso il cortile vi è commodo per tutti li cortigiani, di sotto le officine. Il giardino al piano nobile, come si è detto è attorniato di pergole di ferro; |
| 37. Cortile basso; | 38. Archivio secreto; | 39. Pollaro e gallinaro; |
| 40. Granari e per le biade; | 41, Stalle capaci, e sopra pagliare e fenile; | 42. Cortile della stalla. Sotto il numero 35, 38, 39 vi è un magazzeno detto de pilastri e più sotto habitat ione per li sbirri e carcere civili, e più sotto altre carcere e secreti al pian del cortile della stalla, dal quale per una scaletta è commodo pubblico si va al cortile del n. 11; |
| 43. Altre rimesse per le carrozze. Sotto il palazzo vi è una grotta riguardevole, è con la cantina vi era circa cento botti. Stanze solide appararsi sono del numero 15, 16, 19, 24. |
LO STATO ATTUALE DELLA STRUTTURA: IL MUSEO DIOCESANO
Nel 1978-79 furono rinnovati tutti i tetti; qualche anno dopo, nel piano superiore furono ricavati alcuni piccoli appartamenti per il Clero, usati poi per finalità di solidarietà e di carità, mentre nei primi anni ’90 alcuni importanti interventi hanno trasformato i piani seminterrati in accogliente sede per l’esperienza scoutistica, giovanile ed adulta; negli anni 1995-98 il piano nobile fu totalmente restaurato e dotato degli impianti a norma di legge per ricavarne la sede del Museo Diocesano, inaugurato il 24 ottobre 1998: sono 15 sale più un atrio ed un salone per il Museo e per gli usi pastorali della Parrocchia. La finalità museale degli ambienti recuperati ha guidato fin dall'inizio la progettazione del restauro, l’inserimento degli impianti negli ambienti e la predisposizione dei percorsi e dei servizi nel modo più funzionale possibile alle problematiche espositive delle opere del Museo, evitando le relazioni di conflittualità tra contenuto e contenitore tipiche di questo genere di realizzazioni in edifici storici a forte caratterizzazione architettonica. L’intervento architettonico progettato per l’ex sede vescovile, luogo naturale per la storia della Chiesa osimana e dei suoi vescovi, è stato intrapreso quindi dopo uno studio attento della collezione, avendo già stabilito percorsi, organizzazione degli spazi, ed una sufficiente definizione di quello che sarebbe stato l’allestimento, permettendo una precisa e corretta realizzazione del restauro. La situazione delle sale prima di tale intervento era quella di ambienti disomogenei e fortemente compromessi da precedenti modifiche ed alterazioni negli anni settanta, soprattutto nei pavimenti, con materiali diversi ed incongrui su tutta la superficie. Nel progetto di recupero, quindi, oltre al restauro conservativo delle decorazioni, pittoriche dei soffitti delle sale è stato introdotto, con l’applicazione di un pavimento di legno posato a secco dalle coloriture neutre a calce delle pareti, quell'elemento ulteriore che potesse costruire un contesto di continuità il più possibile omogeneo per lo svolgersi dell’esposizione. Per l’allestimento, il lavoro di ricerca storica e di selezione dei materiali svolto dalla committenza osimana è stato la base per la prima fase del progetto, svolto insieme ai progettisti con la precisa volontà di rendere comunicativa la nuova organizzazione delle opere da esporre, con le caratteristiche dimensionali ed architettoniche degli spazi, con l’unico obiettivo di rendere armonica la presenza dei materiali storici ed artistici all'interno degli ambienti recuperati. Un certo principio di mimesi sembrava essere, in questo caso, l’unico modo per poter superare l’innaturalità della raccolta museale in stanze di palazzo, e chiave di accesso alla relazione simbolica tra i materiali della storia religiosa osimana e la sede vescovile che li ospita. L’esposizione è organizzata in modo da indurre il visitatore a muoversi, da opera in opera, lungo lo sviluppo del racconto storico e gli spazi che furono della sede vescovile. Lungo il percorso compaiono i ritratti dei principali vescovi osimani, esposti con un pannello – cornice per contraddistinguerli dalle altre opere, contestualizzando la fruizione estetica con un ulteriore spunto di analisi in relazione alle figure della committenza. Tutte le strutture espositive e le vetrine sono state eseguite su misura e disegnate in modo da costituire un fondo neutro per il maggior risalto delle opere e, al tempo stesso, per una loro armoniosa presenza all'interno del museo, così fortemente caratterizzati dal punto di vista architettonico. Il coordinamento in fase di progettazione e realizzazione delle strutture espositive ha permesso di ottenere una perfetta omogeneità degli elementi che vi sono contenuti al suo interno.
Bibliografia
M. Massa, E. Carnevali Opere d' Arte nella città di Osimo, Ancona, 1999.
C. Grillantini Storia di Osimo, Recanati, 1985.
GLI ABITATI PALAFITTICOLI DELL’AREA BENACENSE
A cura di Dennis Zammarchi
Le palafitte nell'età del Bronzo
Nell'immaginario comune gli abitati palafitticoli sono identificati come un villaggio sull'acqua realizzato con pali di legno nelle vicinanze di un bacino idrico o di un corso fluviale, in realtà grazie a numerosi studi si è visto come non fossero unicamente localizzati in area umida.
Sebbene si possa parlare di strutture abitative caratteristiche dei siti circondati da corsi d’acqua, durante l’Età del Bronzo, infatti, si riconoscono diverse soluzioni strutturali e differenti situazioni ambientali (Fig. 1).
In più di un secolo di ricerche gli archeologi che hanno scavato numerosi siti palafitticoli europei hanno riportato alla luce insediamenti lacustri e fluviali, che sorgevano sulla riva o in acque più profonde, con case poggianti su lunghi pali isolati o su pali corti, con fondazioni a reticolo autoportanti o ancora case su bonifiche di cassoni lignei, cioè costruite su grandi recinti quadrangolari formati da tronchi incastrati tra loro, riempiti con ghiaia o altro materiale drenante in grado di filtrare l’acqua e creare così un piano di calpestio piatto.

La maggior concentrazione dei siti palafitticoli la troviamo al nord delle Alpi, mentre in area italiana si trovano soprattutto compresi nell'area del bacino inframorenico del Garda, settore dove si diffuse la facies di Polada. Questa cultura prende il nome dalla località di Polada, nei pressi di Lonato del Garda (BS) e si sviluppa in un periodo compreso tra il 2200 e il 1600 a.C. e la successiva “cultura delle Palafitte e Terramare” del Bronzo Medio e Recente (databile tra il 1600 e il 1200/1150 a.C.).
In realtà le più antiche palafitte della penisola italiana risalgono al Neolitico antico, con il sito della Marmotta sul lago di Bracciano agli inizi del VI millennio a.C. (5800-5600 a.C.), mentre in Italia settentrionale si trovano nella zona di Varese (datate al 5200 a.C. circa),tuttavia, più che siti palafitticoli sono siti localizzati in area umida, o più probabilmente sono strutture su bonifica. Queste strutture realizzate in area umida sono state ritrovate anche nel gruppo dell’Isolino e a Fiavé (Trentino) che conosce un periodo di colonizzazione tra il 3800 e il 3600 a.C.
Una domanda che spesso gli studiosi si sono posti è il perché venissero edificate gli abitati palafitticoli: inizialmente si supponeva che la sopraelevazione garantita dall'impalcato ligneo garantisse una protezione dagli animali feroci. Nel corso degli anni e degli studi questa ipotesi è stata smentita, attualmente si ritiene che il successo di queste modalità insediative durante l’età del Bronzo sia riconducibile all'agricoltura.
Per combattere le difficoltà causate da una fase secca e arida, infatti, gli esseri umani si spostavano all'interno del lago per sfruttare l’area lasciata libera dalle acque, divenuta abbastanza fertile e facilmente lavorabile.
La facies di Polada durante l’Età del Bronzo antica e media
Il Bronzo Antico
Durante l’Età del Bronzo antica (2200-1800 a.C., suddiviso da De Marinis in Bronzo Antico I 2200-1800 a.C. e 1800-1600 a.C. Bronzo Antico II) la facies archeologica più conosciuta e famosa per l’Italia settentrionale è sicuramente quella di Polada, una fase culturale limitata, nel momento più antico, alla fascia prealpina dei laghi e degli anfiteatri morenici posizionati allo sbocco delle valli glaciali.
La concentrazione maggiore degli abitati caratteristici di questa facies è situata attorno al lago di Garda, al confine tra le regioni Lombardia e Veneto, con le palafitte di Polada, Barche di Solferino, Bande di Cavriana, Lavagnone e Lucone.
Secondo le ipotesi dello studioso Lawrence Barfield la comparsa in Italia della cultura di Polada potrebbe essere il risultato di un movimento di alcuni gruppi provenienti dalla Svizzera e dalla Germania meridionale, territori dove si vede un’interruzione degli abitati palafitticoli in corrispondenza dell’Età del Bronzo antica e media.
La facies di Polada si sviluppa per tutto il corso della IEB (prima Età del Bronzo, 2200-1600 a.C.), secondo la cronologia proposta da De Marinis sulla base di numerose date dendrocronologiche, ossia un sistema di datazione basato sul conteggio degli anelli di accrescimento annuale degli alberi che permette di avere una precisione annuale.
La cultura materiale tipica dei gruppi Polada comprende ceramica d’impasto eseguita a mano (la parte prevalente dell’insieme archeologico) di colore scuro e di livello tecnico ed estetico modesto, con prevalenza di forme chiuse (nel momento più antico vi sono boccali globulari, anfore, vasi biconici) e quasi sempre priva di decorazione nelle fasi antiche (Fig. 2).

Le classi ceramiche utilizzate per contenere derrate alimentari hanno superfici più scabre, mentre quelle con possibile uso da mensa evidenziano una maggior cura, presentando una coloritura più uniforme, spesso nera, e maggiormente lisciate. I fondi spesso sono convessi, anche se non mancano forme ceramiche a fondo piatto.
Molto caratteristica di Polada è l’ansa con il bottone plastico alla sommità, le decorazioni comprendono cordoni e listelli plastici e motivi incisi a puntini.
Nel Bronzo Antico II il repertorio ceramico cambia sensibilmente, portando alla maggioranza delle tazze sui boccali, inoltre, compare una forma carenata d’impasto fine con ansa ad anello o gomito. La novità maggiore, tuttavia, è la comparsa della decorazione a punti e cerchietti impressi, che compare sui boccali e sui vasi conici.
La facies di Polada era caratterizzata oltre che dalla lavorazione ceramica, anche da un’industria metallurgica non molto sviluppata, con collegamenti transalpini e lavorazione su larga scala di corno ed osso, produzione di industria litica e lavorazione dei materiali organici deperibili, come l’osso e il legno, sia per il mobilio che per la costruzione delle strutture.
Gli abitati del periodo più antico sono piccoli villaggi situati vicino al lago di Garda, a breve distanza gli uni dagli altri, caratterizzati da fasi di occupazione variabili, anche molto brevi in alcuni casi. Ciò era spesso dovuto a incendi e crolli, come visibile dai ritrovamenti effettuati durante gli scavi e alle successive analisi.
I gruppi Polada insediatisi in quei territori erano soggetti quindi a spostamenti e rioccupazioni all'interno dello stesso bacino.
Gli abitati nella fase più antica sono costruiti su palafitte con impalcato aereo sulle rive dei laghi e sull'acqua. Nella fase avanzata, invece, gli abitati palafitticoli sono costruiti su bonifiche sostenuti da cassonature di travi orizzontali e paletti verticali, con case a pianta rettangolare disposte regolarmente. Il modulo di occupazione era costituito da villaggi vicini e collegati, con una densità demografica compresa tra alcune centinaia e un migliaio di persone.
Per quanto riguarda le attività economiche dei gruppi umani insediati nell'area benacense la produzione agricola è documentata dai ritrovamenti di aratri in legno, falcetti con lame realizzate in selce, semi combusti di legumi e cereali. Sono state rinvenute, inoltre, rappresentazioni artistiche di buoi aggiogati su alcuni massi incisi e statue-stele.

L’allevamento era rivolto principalmente a ovini, caprini, suini e bovidi, con differenze legate all'ambiente dov'erano situati gli insediamenti, mentre la caccia aveva un’importanza marginale. Sono stati rinvenuti anche resti di semi e tessuti di lino oltre che resti di cuoio a testimonianza delle attività tessili e di conciatura delle pelli che veniva realizzate.
Importantissimi per gli studi legati sia alla metallurgia che all'identità culturale e cultuale dei gruppi afferenti alla facies di Polada, sono stati i ritrovamenti di ripostigli di bronzi, formati da oggetti integri, solitamente una sola categoria, come asce, collari o pugnali, deposti volontariamente in aree isolate rispetto alla distribuzione degli insediamenti. Uno dei più antichi potrebbe essere quello di Torbole (BS) composto da 13 asce a margini rialzati (Fig.3)
Tali ripostigli potrebbero documentare i modi e le vie della circolazione del metallo sia come prodotto finito (per esempio le asce) che come lingotti. Altre testimonianze della produzione metallurgica locale sono i ritrovamenti di strumenti legati alla fusione dei metalli come crogioli e ugelli di mantice.

Gli usi funerari dei gruppi umani sono poco documentati, probabilmente perché non vi erano specifiche aree destinante al seppellimento dei defunti, infatti si hanno ritrovamenti di resti umani provenienti da settori di abitato.
Le più note manifestazioni di culto della cultura di Polada sono le statue stele e in massi incisi della Valtellina e Valcamonica (in continuità dell’Età del Rame) che associano elementi antropomorfi maschili e femminili con rappresentazioni solari, di armi, di scene di aratura, caccia e animali domestici.

Infine, un accenno alla struttura sociopolitica di questi gruppi nel Bronzo Antico sembra necessario, la struttura sociale e politica sembra essere tribale, con insiemi di comunità villaggio che occupano comprensori gravitanti attorno a bacini lacustri.
Questo è conforme alla relativa uniformità della facies archeologica insieme all'evidenza di collegamenti e scambi che indicano contatti tra le comunità interessate.
Sembra esserci anche una coesione culturale garantita da luoghi di culto come quelle della Valcamonica, mentre non si ipotizza un’organizzazione politica permanente con un rapporto gerarchico fra le diverse entità del territorio.
Il Bronzo Medio
A Nord del Po, fra la Lombardia orientale, Trentino e pianura padana centro orientale, l’aspetto culturale dell’Età del Bronzo media e recente si sviluppa, ancora una volta, negli abitati palafitticoli dei bacini inframorenico, con la massima concentrazione attorno al bacino del Garda e in una serie di abitati arginati di pianura. La continuità con Polada è visibile, sia nella facies culturale che nella distribuzione territoriale, differenziandosi ora dall’area a sud del Po, solo da questa fase occupata e caratterizzata dalla presenza delle terramare.
La ceramica della MEB (media Età del Bronzo) comprende tazze e scodelle emisferiche, vasi biconici, bicchieri, boccali e grandi vasi utilizzati per conservare gli alimenti. La cultura di Polada cambia, prima era caratterizzata prevalentemente da forme chiuse mentre ora iniziano a prevalere forme aperte.
Si diffondono nuovi stili decorativi caratterizzati dall'uso di solcature e motivi geometrici incisi, un altro aspetto tipico di questa fase sono le forme vascolari con l‘ansa sopraelevata. La produzione metallurgica è molto ricca, così come nell'area terramaricola, vi sono falci e diversi tipi di strumenti come spade e pugnali, rasoi a doppio taglio asce.
Molto sviluppata diviene la lavorazione delle materie organiche, come quella del legno, soprattutto a Fiavé, dell’osso e del palco di cervo.
Per quanto riguarda le pratiche cultuali, si ha l’enfasi dei rituali funerari sugli uomini portatori di armi, documentata anche nell'Italia meridionale; questo continuerà fino all’Età del Bronzo recente dove le armi scompariranno dai corredi.
Questo cambiamento nei corredi delle sepolture è probabilmente dovuto, secondo alcuni studiosi, ad una volontà di slegare la rappresentazione della comunità come gruppo rappresentato dalla propria componente guerriera e dalla capacità della comunità nel suo insieme di affidare ad un singolo capo la decisione politica, testimoniando così un processo diffuso della centralizzazione politica.
Con l’Età del Bronzo recente, gli insediamenti in queste regioni mostrano aspetti di crisi e di discontinuità e gli abitati arginati di pianura si interrompono. Tuttavia, le ricerche in corso indicano per la zona del lago di Garda una certa continuità con il Bronzo finale a differenza dell’area delle terramare dove l’interruzione dell’insediamento è definitiva.
Il Lavagnone
Il sito e la storia delle ricerche
Il bacino del Lavagnone, situato all'interno del comune di Desenzano (BS), è una conca lacustre dalle ridotte dimensioni delimitata da cordoni morenici di origine glaciale che caratterizzano il paesaggio a sud del Garda. Oggi del lago antico, lentamente trasformatosi in una torbiera, sopravvive solamente una piccola zona paludosa ricoperta dalla vegetazione. Il bacino, trasformato progressivamente in una torbiera sin dall'età preistorica è stato bonificato e coltivato nel corso del Novecento. Il sito deve il suo nome alla piccola conca lacustre di origine glaciale, che si trova a 3,4 km a sud del lago di Garda tra i comuni di Desenzano (BS) e di Lonato (BS). Il toponimo “Lavagnone” stesso conserva la memoria del luogo, significa infatti “bacino d’acqua” e “luogo umido”. Il Lavagnone è uno dei più importanti abitati palafitticoli dell’Età del Bronzo, frequentato già in età mesolitica e neolitica (tra il 6500 e i 4500 a.C.). Le prime tracce di frequentazione umana, datate a circa 8000 anni fa, hanno evidenziato la fase di frequentazione mesolitica grazie al rinvenimento di alcuni strumenti in selce. Sempre l’industria litica, raccolta anche lungo l’antica linea di riva, restituisce l’evidenza della frequentazione neolitica e eneolitica (Età del Rame, III millennio a.C.). Solamente durante l’Età del Bronzo, dalla fine del III millennio sino al XIII-XII sec. a.C., però il bacino fu occupato stabilmente. Per questa sua caratteristica, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso sono state avviate indagini scientifiche sistematiche sia della sequenza degli stati archeologici, sia del deposito torboso, in cui si sono conservati resti lignei che si sono poi rivelati utili per effettuare analisi dendrocronologiche, oltre che resti organici di semi, frutti e altri resti vegetali.
Per tali motivazioni il sito archeologico Lavagnone è fondamentale per lo studio della cronologia dell’epoca e per gli studi paleo-ambientali del nord Italia. La dendrocronologia ha reso infatti possibile ricavare importanti informazioni sulle datazioni assolute dell’Età del Bronzo, rendendo il Lavagnone uno dei contesti di riferimento per comprendere la cronologia di quest’epoca in Italia settentrionale, potendo scandirne le fasi e la loro successione. I primi ritrovamenti archeologici di cui si ha notizia al Lavagnone risalgono agli anni Ottanta del 1800 (tra il 1880 e il 1886) in seguito ai lavori di estrazione della torba per fini commerciali, al centro dell’antico bacino, che portarono alla luce ceramiche e manufatti in selce scheggiata. Altri rinvenimenti fortuiti avvennero grazie ai contadini che cominciarono a intaccare con le arature gli strati archeologici più superficiali riportando alla luce centinaia di manufatti di quello che appariva ormai come un sito preistorico.
Esclusi questi primi rinvenimenti saltuari, nessuno si occupò di questo sito fino alla fine degli anni ’50 del 1900 quando Ferdinando Fussi, assieme al Gruppo Grotte di Milano, effettuò delle raccolte di superficie e cinque piccoli saggi di scavo, dalle dimensioni ridotte, in diversi punti del bacino, pubblicando le prime notizie di questa eccezionale scoperta. Le ricerche nell'area si intensificarono negli anni Settanta del secolo scorso: nel 1970 inizialmente sotto la direzione di Ornella Maria Acanfora, Soprintendente del Museo Preistorico–Etnografico Luigi Pigorini di Roma, poi con Barbara Barich.
Le ricerche proseguirono poi a partire dal 1974 sotto la direzione di Renato Perini, un grande esperto di abitati palafitticoli, per conto della Soprintendenza al Museo Pigorini e della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, con l’apertura di quattro aree di scavo e sei campagne, dal 1974 al 1979. Durante quegli anni, l’analisi delle stratigrafie di uno dei settori del sito portò Perini a definire 7 orizzonti crono-tipologici, ovvero 7 fasi di occupazione per il Lavagnone, rivelate dalla presenza negli strati archeologici di alcune caratteristiche tipologie di oggetti utilizzati durante le varie fasi dell’Età del Bronzo.
Le sue ricerche fornirono così la base della periodizzazione dell’Età del Bronzo in Italia settentrionale. Nello stesso settore Perini scoprì un aratro in legno degli inizi del Bronzo Antico, uno dei più antichi esemplari noti al mondo (vedi Fig. 3).Dopo un decennio di pausa, gli scavi sono stati ripresi nel 1991 da parte dell’Università degli Studi di Milano, che conduce ancora oggi le ricerche nel sito, inizialmente sotto la direzione scientifica di Raffaele Carlo De Marinis e ora di Marta Rapi.
Nonostante le ricerche scientifiche siano in corso da tempo, si è lontani dall'aver esaurito le potenzialità del sito. Il Lavagnone è stato infatti occupato stabilmente per almeno mille anni durante l’Età del Bronzo e questo ha comportato la presenza di numerose situazioni e contesti archeologici scavati solo parzialmente in modo analitico.
In aggiunta, nel corso dei decenni sono cambiati anche gli approcci e le strategie di ricerca. Per questo, i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano hanno avviato un programma interdisciplinare di ricerche, attivando collaborazioni specifiche per diversi settori tra cui la dendrocronologia, l’archeobotanica, la palinologia (studio dei pollini), il paleo-ambiente e ancora per lo studio dei macroresti vegetali (carpologia per l’analisi di semi e frutti), per la micromorfologia, per l’archeo-zoologia (lo studio dei resti faunistici con tracce di sfruttamento antropico) e per l’archeo-metallurgia.
Attualmente gli scavi dell’università ambrosiana interessano l’area nord-orientale dell’antico bacino lacustre; i settori di scavo sono cinque, identificati con lettere da A ad E e distribuiti lungo un asse nord-est/sud-ovest. Questa disposizione consente di studiare differenti ambienti antichi, tra cui l’antica sponda del bacino, nel settore B, o l’area umida centrale situata in antichità dove si trova il settore D. L’area del settore A, scavata da De Marinis, si trova invece a ridosso del cosiddetto settore I di Perini ed è stata ampliata progressivamente fino a inglobarlo.
Questo ha permesso di verificare la sequenza degli strati archeologici individuata da Perini, e anche di rivedere la periodizzazione del sito. Grazie ai risultati dei nuovi studi le fasi archeologiche individuate sono 8 e non più 7, si è inoltre rivista la cronologia del sito in relazione alle diverse fasi dell’Età del Bronzo in Italia settentrionale.
Queste classificazioni sono afferenti alla cultura di Polada e tardo-poladiana nel Bronzo Antico (2200-1600 a.C. circa) e alla cultura delle Palafitte e Terramare nel Bronzo Medio e Tardo (1600-1200 a.C. circa). Le ricerche hanno mostrato la graduale evoluzione degli aspetti culturali, soprattutto per quanto concerne la produzione ceramica dal Bronzo Antico al Bronzo Recente.
Un altro aspetto fondamentale è l’utilità del Lavagnone per comprendere l’interazione tra uomo e ambiente in un arco di tempo molto lungo grazie alla presenza di resti organici animali (come le ossa) e vegetali (semi, frutti e pollini) all'interno della stratificazione archeologica.
Questi fattori sono stati decisivi nel 2011, per la candidatura e il riconoscimento del sito nella Lista dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino del Patrimonio mondiale dell’UNESCO”. Si tratta di un sito seriale transnazionale perché comprende 111 abitati palafitticoli selezionati tra i circa 1000 attualmente noti, datati tra il 5000 e il 500 a.C. e distribuiti nei territori della Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera e Austria.
La struttura dell’abitato
L’abitato del Lavagnone restituisce una documentazione molto articolata e differenziata durante i secoli. La sequenza del sito infatti evidenzia un’articolata vicenda di fondazioni e ristrutturazioni, di temporanei abbandoni e rioccupazioni oltre che di ciclici spostamenti tra aree più interne e umide a zone prossime alla riva e asciutte.

A questa varietà di situazioni corrispondono altrettante diversificate strutture d’abitato, il tutto in relazione, plausibilmente, a cambiamenti di carattere ambientale avvenuti nel corso dell’evoluzione del bacino. Gli aspetti meglio conservati riguardano l’abitato all'epoca della sua fondazione, all'inizio del Bronzo Antico.
In una prima fase (risalente al 2100-2000 a.C. circa) le abitazioni erano costruite su piattaforme lignee aeree sostenute da lunghi pali di quercia, in una zona periodicamente esondata a circa 80 metri dall'antica linea di costa. In direzione della terra asciutta il villaggio era delimitato da una palizzata ed era raggiungibile dalla sponda nord-orientale percorrendo una passerella formata da assi di legno accostate le une alle altre, disposte sul suolo torboso.
È noto, inoltre, che l’abitato venne modificato nel corso del tempo ampliandosi continuamente. Inizialmente l’area occupata dalle abitazioni era superiore a 6 kmq, raggiungeva forse persino un ettaro (10 kmq). La stabilità dell’insediamento si correla al progressivo ampliamento dell’abitato (fino a 3 ettari) e a un incremento demografico lento, ma costante.
Le fasi successive restituiscono diversi tipi di architetture del legno, infatti, passati alcuni decenni dalla prima fase dell’abitato e dopo che la palafitta più antica era andata a fuoco, vennero costruite case su pali corti autobloccanti infissi in tavole orizzontali (plinti). L’utilità di questi plinti a racchetta era di evitare che i pali sprofondassero. Successivamente, dopo una fase di abbandono temporaneo, dovuta probabilmente ad una fase di clima arido e secco che comporta un grosso incendio (1900-1800 a.C.), vengono realizzate delle abitazioni costruite su bonifica con cassonature lignee riempite di pietrame e limo.
In conclusione, per ciò che concerne le strutture del Lavagnone, si può notare che durante alcune fasi strutture di tipo palafitticolo coesistettero con case costruite all'asciutto direttamente al livello del suolo.
Alcune aree del bacino furono occupate per periodi più brevi, altre vennero ciclicamente abbandonate e rioccupate, rendendo l’abitato dell’Età del Bronzo un villaggio dinamico e in continua evoluzione, anche in relazione all'ambiente circostante, alle risorse disponibili, al modello demografico e ai rapporti più o meno conflittuali con le popolazioni limitrofe.
Il Lucone di Polpenazze
L’area del Lucone, come per il Lavagnone, è costituita da uno dei bacini inframorenici meglio conservati del lago di Garda. Si tratta di un’ampia conca, ora in gran parte bonificata, ma un tempo occupata da un piccolo specchio d’acqua. Le caratteristiche ambientali e i numerosi materiali ritrovati fanno di questa località un complesso fondamentale per lo studio delle modalità d’insediamento nell'Età del Bronzo.
Il Lucone era già parzialmente conosciuto nel 1800, ma venne praticamente riscoperto agli inizi degli anni ’60 da Isa Marchiori, un’insegnante di Polpenazze. Grazie ad una sua segnalazione, il Gruppo Grotte Gavardo, autorizzato dalla Soprintendenza, iniziò ad occuparsi dell’area avviando tra il 1965 e il 1971 cinque campagne di scavo.
Questi scavi portarono alla luce ampi tratti dell’insediamento e numerosi reperti archeologici, tra i quali si annoverano la celebre piroga e le numerose tavolette enigmatiche (tavolette di terracotta o pietra, incise, rinvenute in diverse zone dell’Europa, di cui non è ancora chiara la funzione e non sono ancora state decifrate le incisioni).

Dagli studi è emerso che il bacino del Lucone, dopo una fase neolitica (zona C), è stato abitato con continuità dall'inizio del Bronzo Antico ad una fase avanzata del Bronzo Medio, momento in cui la sua popolazione sembra diminuire fortemente. Durante l’ampio periodo cronologico di frequentazione il bacino è stato caratterizzato da più abitati in ambiente umido, presumibilmente di tipo palafitticolo o su bonifica.
Una divisione topografica suddivide l’area in cinque zone, contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, che potrebbero corrispondere all'incirca agli antichi insediamenti.
La zona C è datata al Neolitico Recente, mentre le zone A e B si presentano come aree pluristratificate comprendenti sia fasi di Bronzo Antico che di Bronzo Medio.
La zona D (identificata nel 1986) presenta invece due fasi insediative inquadrabili in un momento iniziale del Bronzo Antico. La zona E, invece, è stata individuata da recenti ricognizioni di superficie organizzate dal Museo di Gavardo. Nel 2007 il Museo Archeologico della Val Sabbia (MAVS, Gavardo) ha intrapreso nuove ricerche, in concessione ministeriale e con il sostegno finanziario di Regione Lombardia e dei comuni di Gavardo e di Polpenazze del Garda, tralasciando per ora il sito più grande (Lucone A) per concentrarsi sul più piccolo Lucone D, per avere la possibilità di ricostruire le caratteristiche dell'abitato, di definire le tipologie di abitazioni e le modalità di edificazione/abbandono.
Allo stato attuale delle ricerche portate avanti dal Dottor Marco Baioni, direttore del MAVS, la storia del Lucone D sembra iniziare nel 2034 a.C. quando un gruppo umano sceglie di abbattere delle querce per costruire un nuovo villaggio. Da ogni tronco vengono ricavati pali di notevole lunghezza, che verranno poi infissi nel suolo lacustre per sorreggere gli impalcati lignei delle case, costruite direttamente sull'acqua.
Inizierà così a formarsi, nei pressi del villaggio, un deposito archeologico costituito dai materiali che cadono o che sono gettati dagli impalcati, formando così dei livelli colmi di elementi vegetali e di materiali organici caratteristici della parte più bassa della stratigrafia. In questi strati la forte umidità ha permesso la conservazione di molti materiali deperibili: strumenti agricoli in legno, tessuti in fibra di lino, frutti e semi.
Ad un certo punto però, in un momento attualmente non datato con precisione, nel villaggio scoppiò un violento incendio. Il fuoco devastò gran parte delle strutture abitative che crollarono nell'acqua, favorendo così la conservazione dalle numerose assi e travi, che formavano l'alzato, rinvenute semicarbonizzate. L’incendio dovette essere improvviso poiché sono presenti numerosi vasi, rinvenuti a volte con ancora il proprio contenuto, che mostrano evidenti segni di una forte esposizione al fuoco. Dall'incendio non risultarono termoalterati solo elementi vegetali, ma anche parte delle abitazioni, che solitamente non si conservano poiché realizzate in argilla essiccata al sole.Vennero così conservati vari frammenti di intonaco, di pavimenti, di piani di focolare e di strutture per la conservazione delle derrate.
Successivamente, il sito non venne abbandonato, ma si decise di rifondare un nuovo villaggio. Probabilmente alla rifondazione è collocato un rito propiziatorio, beneaugurante per la nuova fondazione dell’insediamento. Sul fondo del lago è stato ritrovato un cranio di un bambino di tre-quattro anni, rinvenuto coperto da cortecce forse appartenenti ai nuovi pali utilizzati per l’edificazione (Fig. 8).

Questo nuovo villaggio ebbe maggior fortuna del precedente, a giudicare dal maggior spessore e dalla ricchezza dei depositi che si sono formati alla base della palificata. La stratigrafia è caratterizzata da grandi cumuli di scarico ricchi di frammenti ceramici e reperti di svariata tipologia, nonché da resti di rifacimenti edilizi e da rifiuti organici. Successivamente tutta l'area dell’insediamento appare sigillata da uno strato di colore biancastro di origine carbonatica: il lago probabilmente ha avuto aumento di livello dell'acqua e la zona non è stata più frequentata.
Bibliografia:
Anna Maria Bietti Sestieri - L’Italia nell’età del bronzo e del ferro, dalle palafitte a Romolo (2200 – 700 a.C.)
Civico Museo Archeologico della Valle Sabbia – Annali del Museo, 19, 2001-2002
Aratro, cultura di Polada - Lombardiabeniculturali.it
Lavagnone – sites.unimi.it
Il Lucone e il Museo Archeologico della Val Sabbia - museoarcheologicogavardo.it
Museo Rambotti Desenzano - museiarcheologici.net
LA CHIESA DI SANTA TERESA A GALLIPOLI
A cura di Stefania Pastore
Introduzione
La chiesa di Santa Teresa rappresenta uno dei tanti esempi di Barocco leccese, uno di quelli non troppo conosciuti perché situata nella città di Gallipoli, nota meta turistica estiva nel Salento per divertimenti giovanili, spesso sottovalutata dal punto di vista artistico. La città, infatti, offre numerose testimonianze storiche perché affonda le sue radici in un passato lontano, risalente al 1000 a.C., e ha visto nel corso dei secoli la dominazione di diverse etnie.

La chiesa di Santa Teresa: la struttura
La chiesa di Santa Teresa vede la sua costruzione, insieme al Monastero delle Carmelitane scalze, tra il 1687 e il 1690 a cura del vescovo Perez de la Lastra. A discapito dell’interno barocco, l’esterno è molto lineare e conta due ingressi, di cui quello principale è sovrastato dalla statua di Santa Teresa con una lunga epigrafe che narra della nascita della chiesa, mentre l’altro ingresso presenta lo stemma dell’ordine dei Carmelitani scalzi.
L’interno è costituito da un’unica navata che conta ben quattro altari in stile barocco, di cui tre in pietra e il quarto marmoreo. Sul lato destro della navata, rispetto alla porta principale, vi sono la tela di S. Agostino e di S. Ignazio di Loyola, attribuita alla scuola leccese del pittore Antonio Verrio, sull'altare più vicino all'entrata, mentre sull'altro altare la tela dell’Immacolata insieme ai santi Giovanni Evangelista e Luigi Gonzaga. Sul lato sinistro della navata si trova l’altare con la tela di S. Maria Maddalena e quello con la statua lignea di S. Teresa del Bambino Gesù. Inoltre, sempre sul lato sinistro, la chiesa custodisce il busto in onore del vescovo De la Lastra, sepolto sotto l’altare maggiore. Sulla cantoria del presbiterio è collocato l’imponente organo settecentesco, attribuito al maestro organaro pugliese Carlo Sanarica.

L’altare maggiore
Il maggiore degli altari, sempre in pietra, era dedicato all'Immacolata. Tuttavia, già dal 1753 si ebbe la necessità di inserire nella grande struttura lapidea, che già accoglieva la tela con la Sacra famiglia, un altare marmoreo. L’opera fu commissionata ad Aniello Gentile, famoso maestro napoletano marmoraro. Egli sfrutta al massimo le potenzialità della chiesa, trasformando il tabernacolo in una quinta scenica. Fedele alla tradizione dei maestri marmorari napoletani, Gentile scolpisce bouquet di gigli nei pilastri dell’altare, putti capi-altare che riprendono quelli dell’altare del Sacramento a Brindisi. La tradizione napoletana della lavorazione dei marmi vede il suo apice nella prima metà del ‘600 con Cosimo Fanzago a Napoli, per poi diffondersi nelle province del Meridione e in alcune della Spagna, in maniera più capillare, nel ‘700 con l’affermarsi del gusto per l’altare marmoreo.

La storia della chiesa di Santa Teresa
La chiesa vede la sua intitolazione a Santa Teresa di Lisieux, altrimenti conosciuta come Santa Teresina per distinguerla da Teresa d’Avila. Teresa di Lisieux fu dichiarata Santa proprio a seguito di un miracolo accaduto a Gallipoli nel 1910, miracolo che permise alla chiesa di continuare a sopravvivere. Nel 1861, infatti, fu emanata una legge con cui si stabiliva che molti beni ecclesiastici, soprattutto meridionali, fossero espropriati e soppressi. Tra questi vi era anche il monastero delle Carmelitane di Gallipoli con l’annessa Chiesa. Questo negli anni si era mantenuto economicamente grazie ai contributi della facoltosa gallipolina Ida Piccinno, poi diventata priora del monastero con il nome di madre Carmela. Nel 1909, come testimoniano i libri dei conti, la chiesa si trovava economicamente in passivo per trecento lire. Madre Carmela decise, così, di rivolgersi alla beata Teresa (non ancora diventata Santa) con un ciclo di preghiere.
La priora aveva conosciuto la Santa grazie ad una sua biografia, nota con il nome “Storia di un’anima”, che le era stata donata dalla priora delle suore Marcelline di Lecce. Poco prima della fine del triduo, quando madre Carmela era a letto a causa di una pleurite, avvenne il miracolo: le apparve in sogno Teresa di Lisieux, la quale la invitava a recarsi presso la cassetta delle offerte perché lì avrebbe trovato ciò che le occorreva. Infatti madre Carmela trovò le cinquecento lire promesse. Questo fatto prodigioso permise di avere dati sufficienti alla beatificazione prima, e alla canonizzazione poi, della Santa. che avvenne nel 1925 ad opera di papa Pio XI.
Nel 2010, in occasione del centenario del miracolo della Santa, è stata esposta l’urna di Santa Teresa a coronare un ciclo di manifestazioni ed eventi.
Sitografia
http://www.cattedralegallipoli.it/il-monastero-di-s-teresa/
http://www.salento.info/1975-chiesa-santa-teresa-in-gallipoli-storia-miracoli/
http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/2031/il-miracolo-di-santa-teresina-a-gallipoli/
Bibliografia
Pasculli Ferrara M., L’arte dei Marmorari in Italia meridionale, De luca editori d’arte, Roma 2013.
IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO
A cura di Irene Scovero
Tra apparizioni e moti risorgimentali
Vi è un luogo a Genova dove leggende, architettura e storia si intrecciano. Il luogo dove sorge il santuario di Nostra Signora di Loreto è intriso di una antica religiosità popolare e di storia patriottica.
Il quartiere di Oregina, a Genova, sorge in una zona collinare situata fuori dalle antiche mura cittadine e inglobata nella cerchia difensiva del Seicento. È del XVI secolo la prima testimonianza di urbanizzazione nella zona, così la descrive il vescovo e storico Agostino Giustiniani nei suoi annali. Uscito che si è dalla porta di S. Michele occorre, primo: la villa di Oregina, col fossato di S. Tomo [San Tommaso] il quale dà fortezza alla città; sono in questa villa insieme col fossato trentotto case, venti di cittadini e diciotto di paesani, quali tutte hanno terreno lavorativo[1].
L’accesso a questa area abitativa era consentito da una ripida salita ancora oggi percorribile[2], che dall'attuale piazza Principe seguiva esternamente le mura cinquecentesche giungendo al bastione di San Giorgio, che dal 1818 è Osservatorio Astronomico e Meteorologico della Marina Militare.
Negli ultimi anni del Cinquecento fu costruita sulla sommità della collina una cappella dedicata alla Madonna di Loreto che nel Seicento venne ampliata e inglobata in una chiesa con convento francescano. Secondo la tradizione il nome del quartiere deriverebbe dall'invocazione ‘’O Regina’’ riportata su un’immagine della Madonna collocata in cima alla collina, e che poi avrebbe finito per designare il luogo stesso dove sarebbe sorta l’attuale chiesa di Nostra Signora di Loreto e il quartiere intorno. Il tessuto abitativo vicino al colle si mantenne estremamente rado fino ai primi decenni del XX secolo, quando il tracciato collinare costellato di ulivi e vigne venne interrotto dalla costruzione di via Napoli e vie limitrofe, anche se il quartiere mantenne inalterato il dominio sulla vista del porto, la costa e la vegetazione attorno.
La fondazione dell’edificio ebbe inizio nel 1634 quando si stabilirono sul colle di Oregina un gruppo di monaci[3] che viveva di elemosine. È possibile che durante la loro breve presenza abbiano iniziato a costruire una cappella che riproduceva la Casa di Loreto, nel luogo dove secondo la tradizione si trovava l’effige di Maria.
Attigua alla piazza davanti il santuario, donata in quegli anni dal Senato, si trovava una villa posseduta dai fratelli Fernano, Gio Batta e Gio Agostino. Quest’ultimo prese gli ordini diventando Minore Osservante e donò parte della propria villa alla chiesa. Caduti in disgrazia i monaci fondatori, perché sospettati d’eresia dal tribunale dell’Inquisizione, nel 1635 la chiesa passò in mano ai Francescani Minori Osservanti i quali stabilirono in Oregina una loro comunità. L’immagine dell’edificio come ci appare oggi risale alla costruzione avvenuta tra il 1650-1655 ed era concepito come un contenitore della preesistente cappella che venne distrutta nel 1928, cancellando così la testimonianza più antica del santuario, che presentava sul prospetto un affresco con il Trasporto della Santa Casa dipinto da Filippo Alessio[4]. Nel XVIII secolo fu terminata la facciata, la cupola, il piazzale antistante la chiesa e vennero condotti importanti ampliamenti nel convento, di cui un’ala venne poi demolita agli inizi del Novecento per la costruzione del retrostante belvedere. La semplice facciata del santuario, realizzata nel 1707, è decorata nella parte superiore da lesene affiancate da due nicchie e dalla triplice finestra a serliana di stile barocco, sormontata da un fastigio che riproduce il simbolo dell’ordine dei francescani. Sopra il portale d’ingresso è visibile l’affresco di Angelo Vernazza[5] eseguito nel 1906 che raffigura la visione di Padre Candido Giusso.
Le soppressioni napoleoniche del 1810 e del 1872 e i danni subiti durante le due guerre mondiali hanno impoverito l’arredo del santuario che in ogni caso è molto luminoso e caratterizzato da sobri ornati architettonici. La zona absidale subì molti danni nel 1945 e andarono perduti una tela raffigurante la Vergine, l’organo e il coro che è stato ristrutturato interamente. Entrando la prima cosa che salta agli occhi è la forte luminosità e la semplicità degli ornamenti architettonici. Il volume interno e la chiarezza delle linee compositive sono dovute alla sua originale funzione di contenitore della primitiva cappella. L’interno, a navata unica, misura 42 metri di lunghezza per 20 di larghezza mentre la cappella che stava nel mezzo misurava metri 9x4. Il tempietto primitivo aveva all'esterno un altare dedicato a Santa Margherita da Cortona e poi San Pasquale e sulla facciata un affresco di Filippo Alessio che riproduceva il Trasporto della Santa Casa.

Ai lati dell’ingresso si trovano due monumenti funebri, uno dedicato allo scultore Bartolomeo Carrega[6] e l’altro al patriota Alessandro de Stefanis[7].
Appena entrati sul muro di destra, sopra l’ingresso degli uffici di segreteria, è presente una tavola di recentissima acquisizione, che non è di proprietà della chiesa, ma rimane dell’Ordine dei Frati Minori. L’opera del XVII secolo di scuola genovese reca l’immagine dell’Immacolata tra Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista. La tavola, insieme a 12 panche piccole, è stata trasportata nella chiesa di N.S. Signora di Loreto dopo la chiusura della chiesa del Celesia a Genova.
Nelle pareti laterali dell’edificio sono inserite in nicchie le statue di santi francescani. Sull'altare di destra troviamo la tela di Giovan Maria delle Piane[8], detto Molinaretto (1660-1745) che raffigura l’Angelo Custode; in quest'opera i colori sono vivi e luminosi e l'altare in marmi misti è databile intorno al 1736. Sull'altare di sinistra si trova la tela di Giovan Andrea Carlone[9] (1639-1697), raffigurante San Giuseppe con Gesù fanciullo. Anche in quest'opera prevalgono i colori accesi e brillanti, i personaggi sono tutti in movimento, dando così al quadro un senso di dinamicità. Questi ed altri dipinti conservati in chiesa e nel convento formavano e abbellivano la chiesa di Sant'Andrea demolita nel 1903. Alle spalle del nuovo altare consacrato nel 2001 troviamo l’antico altare maggiore di struttura settecentesca, con due porte laterali che permettono l’accesso al retrostante coro come nei tipici altari conventuali. Dopo la distruzione dell’antica cappella, la statua della Vergine nera fu trasferita nella nicchia sull'altare maggiore. Sul lato sinistro del presbiterio vi è la lapide di Padre Candido Giusso e all'interno della chiesa sono conservate statuine settecentesche di scuola genovese. Sulla facciata della chiesa sul lato destro prospettante il piazzale è infissa una lapide recante i nomi dei caduti della prima e Seconda guerra mondiale che incornicia la statua in bronzo La vedetta alpina, opera dello scultore Gino Faita[10]. La bellissima piazza su cui affaccia la chiesa è abbellita da alberi secolari, lastricato in ardesia e acciottolato alla genovese, mentre inserti di pietra grigia segnano gli ingressi al santuario. Sul piazzale sono presenti alcune panchine che la tradizione vuole siano state costruite con massi dei vecchi moli, perché sono visibili fossili di conchiglie. Fino ad una ventina di anni fa alla sommità delle scale d’accesso al santuario era presente un crocifisso ligneo, poi scomparso per far posto a colonnine in ferro.

La Statua di Nostra Signora di Loreto
La Vergine, scolpita in un legno nero e rivestita di panni preziosi, fu trasferita nella nicchia dell’altare costruito dopo il 1928 quando venne soppressa la cappella antica per cui era sorta la chiesa intorno ed è una copia della Vergine lauretana. Secondo la leggenda, il culto lauretano è sorto nel luogo secondo cui la Vergine Maria sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli dalla casa di Nazareth a Loreto nelle Marche la notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294. Questo luogo è meta di continui pellegrinaggi e viene considerata la Lourdes italiana. Non ancora conosciuto è il motivo per cui l’iconografia della Vergine riporti una Madonna nera. È possibile presumere che i primi fedeli che entrarono nella casa di Loreto trovarono raffigurazioni di Maria con la pelle nera dovuta al fumo dei ceri e delle lampade ad olio accese, che con il tempo avrebbero alterato la superficie pittorica di tali raffigurazioni. Alcune documentazioni antiche ci fanno presumere che il colore della pelle scuro fosse invece un fatto volontario. Nel “Cantico dei Cantici” sono state trovate delle frasi che potrebbero giustificare la scelta. Si parla nello specifico di citazioni come “Bruna sono, ma bella” o “Non state a guardare che sono bruna, perché mi ha abbronzata il Sole”. Sembra quindi che il colore nero della pelle della Madonna di Loreto sia dovuto sia ad un motivo concreto per questioni di materiali rovinati nel tempo, ma anche per una motivazione culturale documentata negli scritti.

Visione di Padre Candido Giusso e insurrezione popolare genovese 5-10 dicembre 1746
La famosa visione che ebbe Padre Giusso, il guardiano del santuario, è da collegare alla rivolta di Genova del 5 dicembre 1746 quando la città, capeggiata dal giovane Balilla[11] insorse contro gli austriaci. Il fatto è passato alla storia anche grazie alle azioni del giovane ragazzo che per primo con il lancio di pietre si oppose al comando austriaco. Fu tale rivolta che successivamente contribuì a porre le basi per il pensiero risorgimentale italiano. Nella notte tra il 9-10 dicembre del 1746, mentre in città continuavano i combattimenti, padre Giusso ebbe in visione la Vergine con ai piedi un serpente e un po’ più in giù notò anche la figura di Santa Caterina inginocchiata con le mani giunte. Nella giornata seguente, la giornata della festa del santuario, vi fu la vittoria sul nemico e contemporaneamente si sparse la notizia della visione di padre Giusso. Il senato genovese ritenne che era stata Maria, supplicata da Santa Caterina, ad aver salvato la città dall'assedio nemico, e per ringraziare la Vergine, da allora, ogni 10 dicembre ci si reca in pellegrinaggio al santuario.
Le parole di Candido Giusso:
« E viddi la luna alzata tutta fuoco con raggio di nuvole che ascendevano l’una sopra l’altra con propri chiari et in mezzo di quella vidi l’Immagine della SS. Vergine quale distinsi per l’Immagine dell’Immacolata Concezione col serpe a piedi che gettava fuoco dalla bocca dall’orecchie e dalla coda sulla luna, quale a mia vista era a tre palmi di lontananza e di bassezza tre sotto il serpente, viddi ivi genuflessa Santa Caterina da Genova in atto supplichevole con le mani giunte, col vestito oscuro appuntato davanti con una giacchetta sanguinolenta con un cordoncino bianco e sottile come portano i religiosi Padri di Castelletto. E questa vista è durata più di un quarto d’ora porgendo io continuamente orazioni ».
Il Giusso si esprime con cautela nel riportare la visione della Madonna come Immacolata, è il XVIII secolo e la questione della concezione senza peccato originale di Maria è ancora materia di dibattito teologico. Se i francescani, come il Giusso, ne facevano una posizione caratteristica della loro scuola (sulla scia di Duns Scoto) i domenicani erano ancora contrari (al seguito di san Tommaso).
La facciata settecentesca della chiesa mostra sopra l’ingresso un affresco dei primi del Novecento raffigurante Visione di Padre Candido Giusso realizzato nel 1906 da Angelo Vernazza. La popolazione per ringraziare la Madonna dell’intercessione miracolosa durante la rivolta popolare commissionò a Francesco Maria Schiaffino nel 1746 una statua a grandezza naturale della Madonna Immacolata, oggi conservata nel Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo di Genova. Il doge Brignole Sale ne fece dono alla cattedrale disponendo che l’8 dicembre di ogni anno venisse portata in processione. Sempre all'interno del duomo, nella cappella dell’abside di destra, è presente una vetrata con la visione di Padre Candido Giusso che ritrae l’Immacolata con san Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Genova. L’opera fu realizzata nel 1954 da Raffaele Albertella in occasione del centenario dell’Immacolata Concezione.
Inno di Mameli e Tricolore
Le vicende religiose del Santuario si intrecciano con la nostra storia risorgimentale. Il 10 dicembre 1847 in occasione dell’anniversario della rivolta dei genovesi del 1746, patrioti provenienti da tutta Italia si unirono alla manifestazione con l’intento di sensibilizzare re Carlo Alberto di Savoia ad aderire all'Unità d’Italia. Le cronache parlano di un corteo di circa 35000 persone che partì dalla zona dell’Acquasola, attraversò Strada Nuova, oggi Via Garibaldi, e arrivò sul piazzale di Oregina. Goffredo Mameli[12] partecipò e animò la manifestazione con le bandiere tricolori della Giovine Italia, poi donate al santuario[13]. Per la prima volta venne intonato il nascente Inno d’Italia composto pochi mesi prima dalla stesso Mameli e musicato da Michele Novaro[14].
Il Museo del Risorgimento che sorge in via Lomellini, nel centro storico di Genova, nella casa natale di Giuseppe Mazzini, conserva l’originale autografo del Canto degli Italiani, meglio noto come l’Inno di Mameli, scritto nell'autunno del 1827 dall'allora ventenne Goffredo e suonato per la prima volta a Genova. Fratelli d’Italia divenne l’Inno Nazionale Italiano soltanto dopo la proclamazione della Repubblica italiana e precisamente il 12 ottobre 1946, ma quando Giuseppe Verdi nel 1862 compose l’Inno delle Nazioni accanto alla Marsigliese per la Francia e a God save the Queen per l’Inghilterra, a rappresentare l’Italia inserì Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, ritenendo che in esso si riconoscesse l’Italia appena unificata, sebbene l’inno nazionale ufficiale dell’epoca fosse la Marcia reale in uso dai tempi di Carlo Felice re di Sardegna, esteso poi al Regno d’Italia, e utilizzato fino alla caduta di Mussolini.
L’inno fu stampato per la prima volta su foglio volante a Genova dalla tipografia Casamara e fu distribuito il 10 dicembre a coloro che presero parte al corteo in Oregina. La copia conservata ha correzioni a penna di mano dello stesso Mameli; provocatoriamente egli aggiunse a penna l’ultima strofa del suo inno, che era stata censurata perché conteneva concetti troppo palesemente anti-austriaci. Dopo il 10 dicembre il canto di Mameli si diffuse in ogni parte d’Italia, portato dagli stessi patrioti che erano venuti a Genova.
Per quanto attiene alla creazione della melodia , una preziosa testimonianza ci è giunta nelle parole di Anton Giulio Barrili, scrittore e giornalista nativo di Carcare nel savonese, che raccolse la testimonianza diretta dello stesso Novaro della particolare atmosfera patriottica in cui musicò i versi dell’inno di Mameli:
“In una sera di mezzo settembre in casa di Lorenzo Valerio si faceva musica e politica insieme… In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, l’egregio pittore che tutti i genovesi rammentano; giungeva egli appunto da Genova e, voltosi al Novaro con un foglietto che aveva cavato di tasca in quel punto: ‘To’! - gli disse - te lo manda Goffredo’. Il Novaro apre il foglio, legge, si commuove. Gli chiedon tutti che cos’è. Gli fan ressa d’attorno. ‘Una cosa stupenda!’ esclama il Maestro e legge ad alta voce, e solleva ad entusiasmo tutto l’uditorio.
Io sentii - mi diceva il maestro -, io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario. Piansi, ero agitato e non potevo star fermo. Mi posi al cembalo coi versi di Goffredo sul leggio e strimpellavo, assassinavo con le dita convulse quel povero strumento, sempre con gli occhi all’inno, mettendo giù frasi melodiche, l’una sull’altra, ma lungi le mille miglia dall’idea che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai, scontento di me… presi congedo e corsi a casa…
Là, senza pur levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi tornò alla mente il motivo strimpellato in casa Valerio; lo scrissi su di un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani; nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo, e per conseguenza anche sul povero foglio. Fu questo l’originale dell’inno Fratelli d’Italia"[15].
Salita Oregina, l’antica mattonata, via di pellegrinaggio.
Come detto in precedenza, l’antica salita che conduceva al luogo di devozione mariana è ancora percorribile ed è testimonianza della via di pellegrinaggio che i devoti intraprendevano per arrivare sulla sommità della collina. La via iniziava da piazza Acquaverde, attuale Stazione Principe e partiva dalla Porta di San Tommaso (cinta muraria del XIV secolo). La salita oggi inizia un poco più in alto, in via Giuseppe Avezzana, perché la costruzione della stazione ferroviaria tra 1853-60 mutò radicalmente l’aspetto della zona. La mattonata mantiene ancora il selciato centrale in mattoni rossi, elemento che ritroviamo nelle antiche creuse genovesi. Il lato monte è contenuto da alti muri e ripide scalinate che portano a case e palazzi di fine Ottocento in cui è possibile riconoscere mescolanze di stili artistici tra cui il Liberty. Superato il Forte San Giorgo, costruito nel 1818, si incontra via Napoli, costruita agli inizi del XX secolo che taglia in tutta la sua lunghezza la collina. È interessante constatare come sia possibile ancora oggi vedere la presenza di fontanelle in ghisa “a pigna” che un tempo erano molto numerose lungo la via ed erano indispensabili per dissetare i pellegrini e gli animali da soma che giungevano da lontano e percorrevano la rapida salita.
La mattonata sale stringendosi e serpeggiandosi tra antichi palazzi di villeggiatura e case popolari, la creusa è sempre caratterizzata da mattoni rossi al centro e il risseu ai lati. A metà della salita, su una piazzetta si affaccia un edificio del 1857 che ha ospitato l’Albergo dei Fanciulli Umberto I fondato nei primi anni del Novecento. Oggi l’edificio ospita una residenza per anziani. L’ultimo tratto in salita è scandito da tre fatiscenti edicole distanti da loro circa una decina di metri che sono quel che rimane di antiche stazioni della Via Crucis. Arrivati alla carrozzabile emerge la chiesa circondata da alberi secolari. Con l’ultimo breve tratto della via che prosegue a fianco della canonica si raggiunge il belvedere panoramico che si affaccia sulla città e sul porto. La ‘rotonda’, cosi chiamata dai cittadini, è un punto di transito per raggiungere il parco del Peralto e i forti.

Note
[1] A.Giustiniani "Annali della Repubblica di Genova", 1537
[2] Salita Oregina
[3] L’Alizieri riporta che li guidava un certo Guglielmo Musso di Voltri, sfuggito alla forca da Venezia e poi convertito alla religione.
[4] Filippo Alessio (1770-1841) pittore genovese formatosi alla scuola del Baratta a Roma orientato verso il neoclassicismo. Tornato a Genova insegnò all’Accademia di Belle Arti. In città rimangono suoi affreschi in una sala di Palazzo Pallavicini in piazza Fontane Marose e nella chiesa della Consolazione.
[5] Angelo Vernazza (1869-1937) pittore attivo soprattutto in Liguria, approfondì la sua formazione a Parigi e tornato in Italia fondò una scuola d’arte con sede in via XX settembre a Genova. Nella sua produzione si contano affreschi in stile liberty e di ispirazione religiosa.
[6] Bartolomeo Carrega nacque a Gavi (Alessandria) nel 1746 e studiò scultura a Genova sotto la guida di Niccolò Traverso presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Ebbe una personalità artistica poco definita e spesso lavorò insieme con altri scultori, tanto che riesce difficile distinguere la sua mano da quella dei collaboratori. Lavorò nei principali palazzi dell’aristocrazia genovese e il biografo Alizeri ne sottolinea la dipendenza artistica dal Traverso. Morì a Genova l'8 gennaio 1839.
[7] Alessandro de Stefanis (1826-1849), amico di Goffredo Mameli, cadde combattendo nell'insurrezione repubblicana di Genova del marzo-aprile 1849. E’ considerato una figura cardine del patriottismo legato alle vicende preunitarie della Repubblica di Genova e del Regno di Sardegna. La città di Genova gli ha intitolato un corso nel quartiere di Marassi.
[8] Giovan Maria delle Piane frequentò la bottega di G. B. Merano e poi si trasferì a Milano dove lavorò a stretto contatto con G. B. Gaulli detto il Baciccio. Trovò molti committenti sia in Roma che a Genova. Negli anni trenta del XVII secolo si trattenne alcuni anni a Napoli alla corte di Carlo di Borbone. Nel 1741 tornò a Genova e vi rimase fino al 1744 quando si spostòin provincia di Piacenza e morì l’anno seguente.
[9] Giovan Andrea Carlone, artista genovese, completò la sua formazione a Perugia e poi a Roma alla scuola del Maratta. A Genova trascorse l’ultima parte della sua vita e nel 1691-92 esegui affreschi nell'attuale Palazzo Rosso e successivamente a Palazzo Reale. Altre sue opere genovesi sono i quattro quadri per la cappella Gentile all’Annunziata del Guastato, affreschi nella cappella Senarega nella cattedrale di san Lorenzo e molte altre tavole disseminate nelle varie chiese di Genova e di altre località liguri.
[10] Gino Faita, artista fiorentino, a partire dagli anni 50 affrontò nella sua produzione l’utilizzo della creta con un impianto essenzialmente realista.
[11] Balilla, ballin, balletta (pallina in genovese) è il nomignolo che la tradizione attribuisce al giovane ragazzo che il 5 dicembre 1746 accese la prima scintilla dell’insurrezione che cacciò gli Austriaci da Genova, scagliando un sasso contro un drappello di soldati. Nessuna cronaca o documento dell’epoca ne riferisce il nome, un secolo più tardi viene identificato in Giovan Battista Perasso. Un mito che è rimasto indelebile nel tempo e nel cuore dei genovesi che lo hanno sempre considerato un eroe nazionale. Divenuto simbolo di patriottismo, il regime fascista gli dedicò l’opera Nazionale Balilla, organizzazione giovanile che raccoglieva i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, fondata nel 1926, nel 1937 assorbita nella Gioventù italiana del Littorio. Nel 1947 il famoso calcetto da tavola venne chiamato anche calcio balilla. In una piccola piazzetta di fronte al tribunale di Genova si trova il monumento in bronzo a lui dedicato ad opera dello scultore Vincenzo Giani (1831-1900).
[12] Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 settembre 1827 e morì a soli 21 anni, combattendo a difesa della Repubblica Romana, il 6 luglio 1849. Poeta – scrittore – patriota - soldato, Mazzini lo prediligeva fra tutti i suoi seguaci perché la sua personalità racchiudeva la perfetta sintesi di pensiero e azione. Discendeva da una famiglia aristocratica: la madre, la marchesa Zoagli Lomellini, amica d’infanzia di Mazzini, ne comprese la sensibilità e le aspirazioni. Il padre, d’origine sarda, era invece un fedele di Casa Savoia ed aveva fatto carriera nella marina militare. A Goffredo facevano riferimento i tanti giovani legati a Mazzini e ai suoi ideali di unità e di repubblica. Scrisse opuscoli politici, fondò un giornale, fu l’anima di tutte le manifestazioni che sin dal 1846 miravano ad ottenere da Carlo Alberto riforme costituzionali. Organizzò la manifestazione patriottica del 10 dicembre a Genova e corse in aiuto dei milanesi insorti contro gli Austriaci. Partecipò alla prima guerra di Indipendenza e dopo la sconfitta accorse tra i primi a Roma, dove, fuggito il Papa, il 9 febbraio 1849 era stata dichiarata la Repubblica.
[13] Le bandiere che erano al Santuario ora sono al Museo Risorgimentale di Genova in via Lomellini. Il tricolore sventolò per la prima volta a Genova. Un tricolore lo issava Goffredo Mameli, che lo consegnò poi al Rettore dell’Università’, dove e’ tuttora conservato; l’altro, portato dal genovese Luigi Paris, oggi e’ esposto nel Museo Risorgimentale.
[14] Michele Novaro nacque a Genova il 23 dicembre 1818. Sin da bambino frequentò l’ambiente teatrale e musicale (il padre era tecnico di scena al Teatro Carlo Felice; la madre, Giuseppina Canzio, era sorella di Michele, artista famoso e autore di numerose scenografie teatrali). Novaro si formò culturalmente alla scuola di canto e di composizione, annessa al teatro Carlo Felice. Quando musicò i versi di Mameli lavorava a Torino come secondo tenore e maestro del Coro dei teatri Regio e Carignano. Tornò più tardi a Genova dove fondò una scuola di musica, impartendo lezioni gratuite ai giovani più poveri. Fu compositore fecondo e, soprattutto, ottimo maestro e organizzatore di concerti, quasi sempre per beneficenza o per sostenere il movimento risorgimentale. Patriota e altruista, viveva di un misero sussidio; quasi dimenticato morì a Genova il 20 ottobre del 1885.
[15] Testo riportato dal sito del Museo del Risorgimento
Bibliografia
“A Compagna” Rivista mensile illustrata, Genova, 1930
Puncuh, (a cura di ) Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai giorni nostri, Atti della Società Ligure di Storia Patria Nuova Serie – Vol. XXXIX (CXIII) Fasc. II, Genova, 1999
Boggero, Museo del Risorgimento e Istituto Mazziniano, Genova, 1980
F.Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, 1847
Baghino, N.S. di Loreto una chiesa dimenticata?, Genova, 2000
Magnani, Santuario di N.Signora di Loreto, Genova, 1979
Rosselli, La piazza dell’inno d’Italia, Genova, 2019
Sitografia