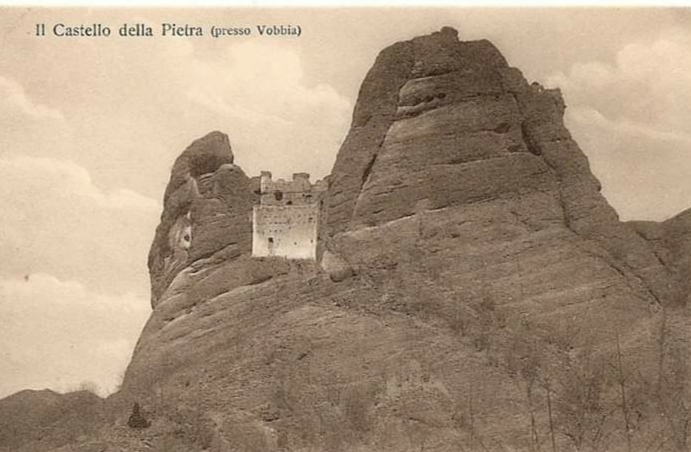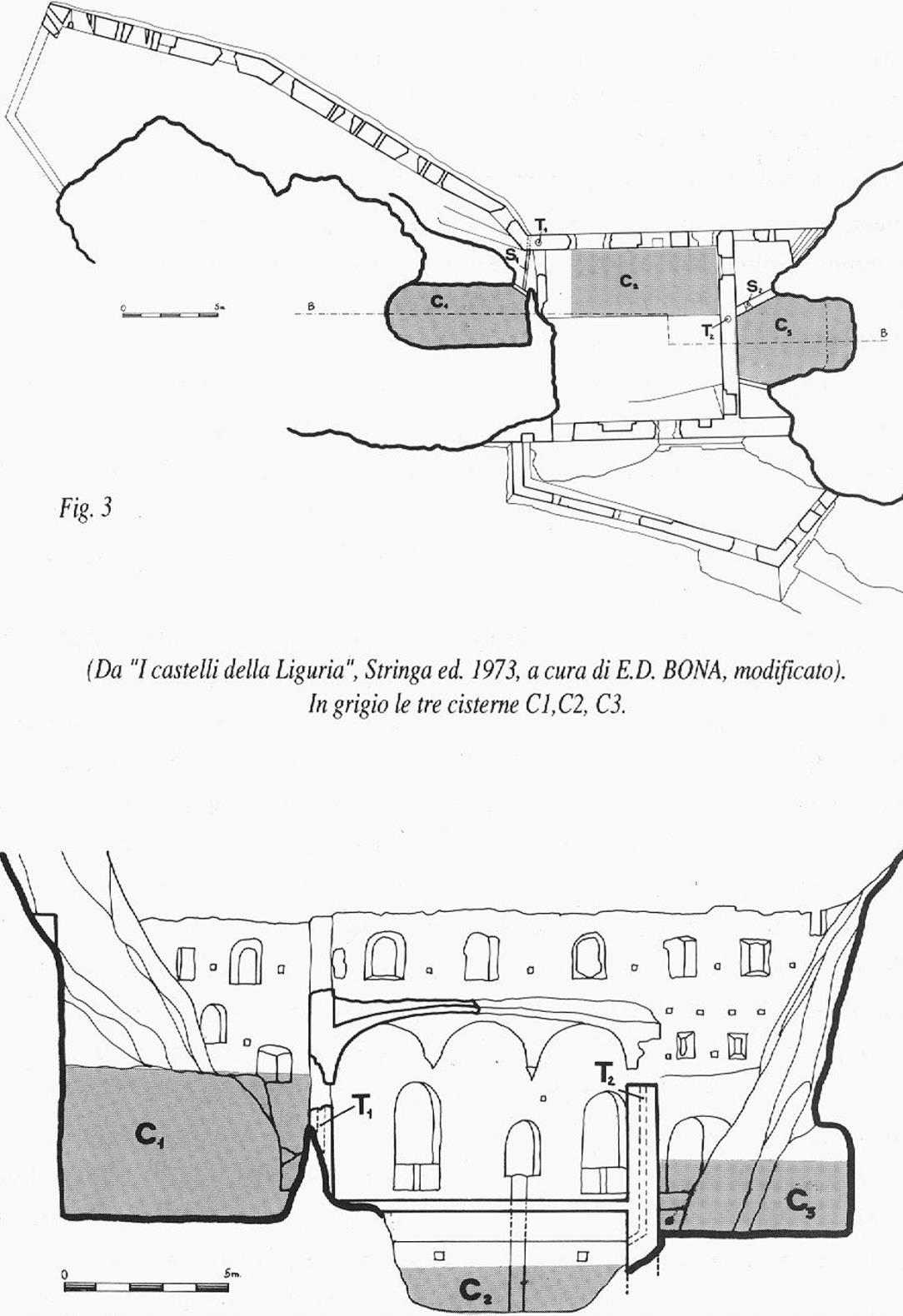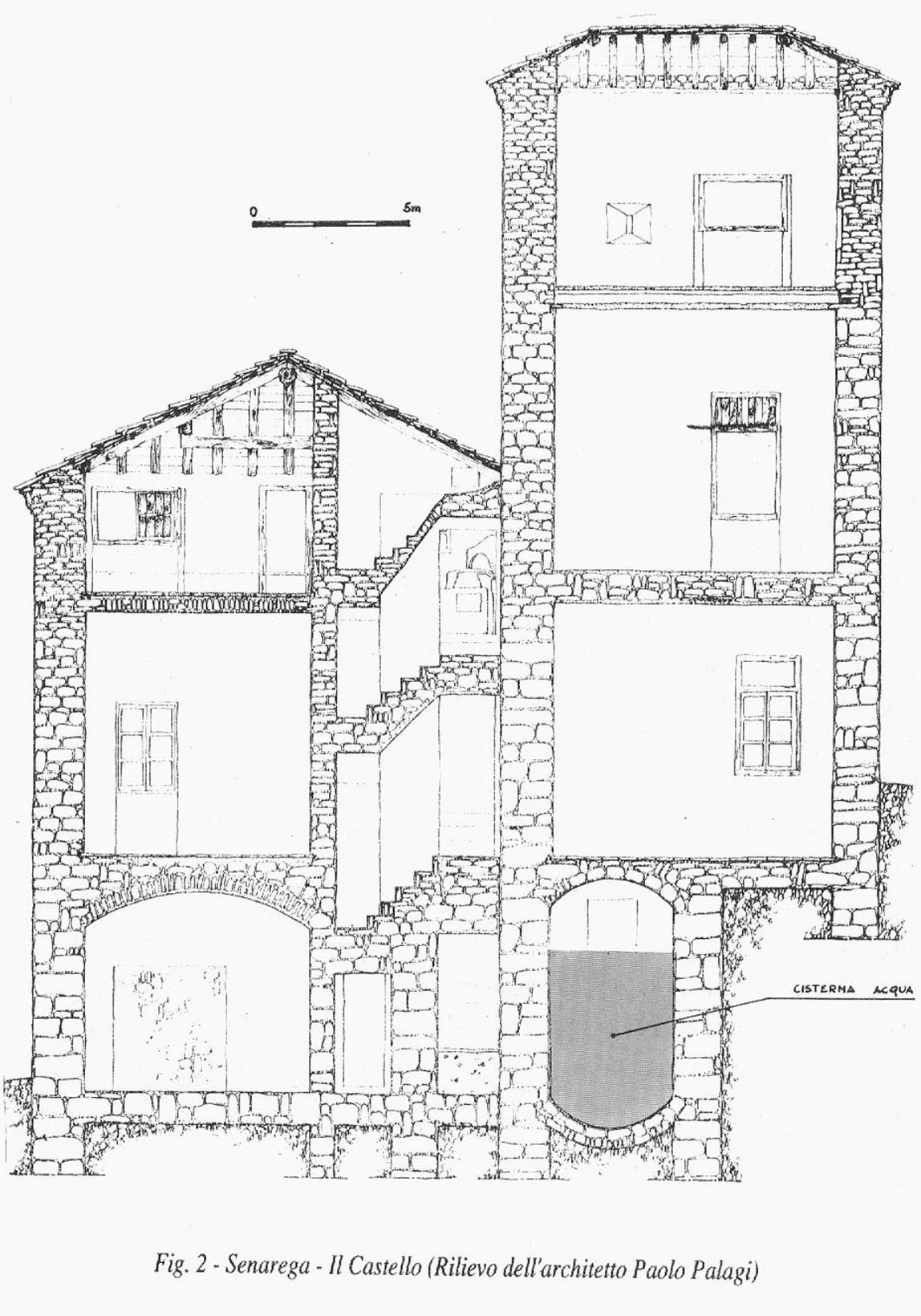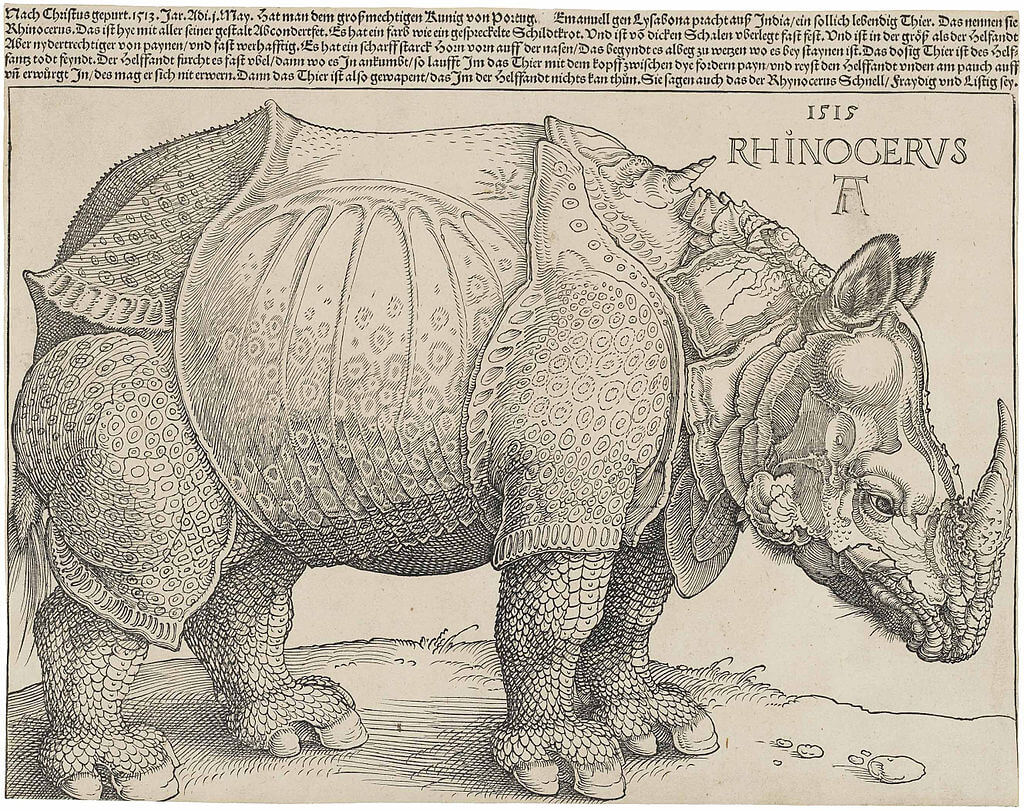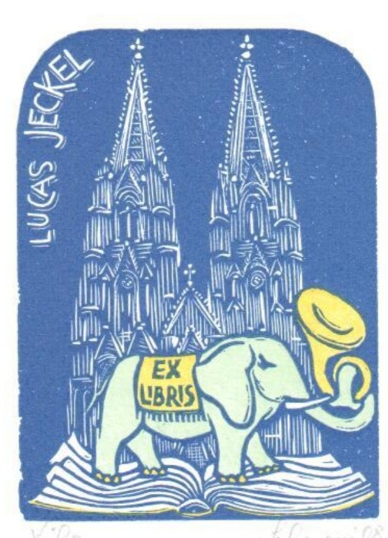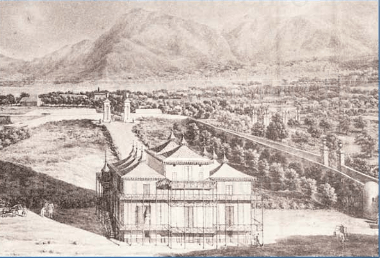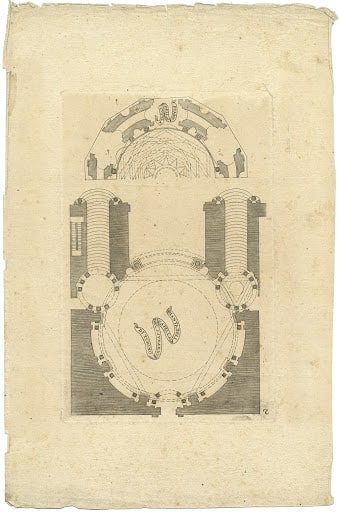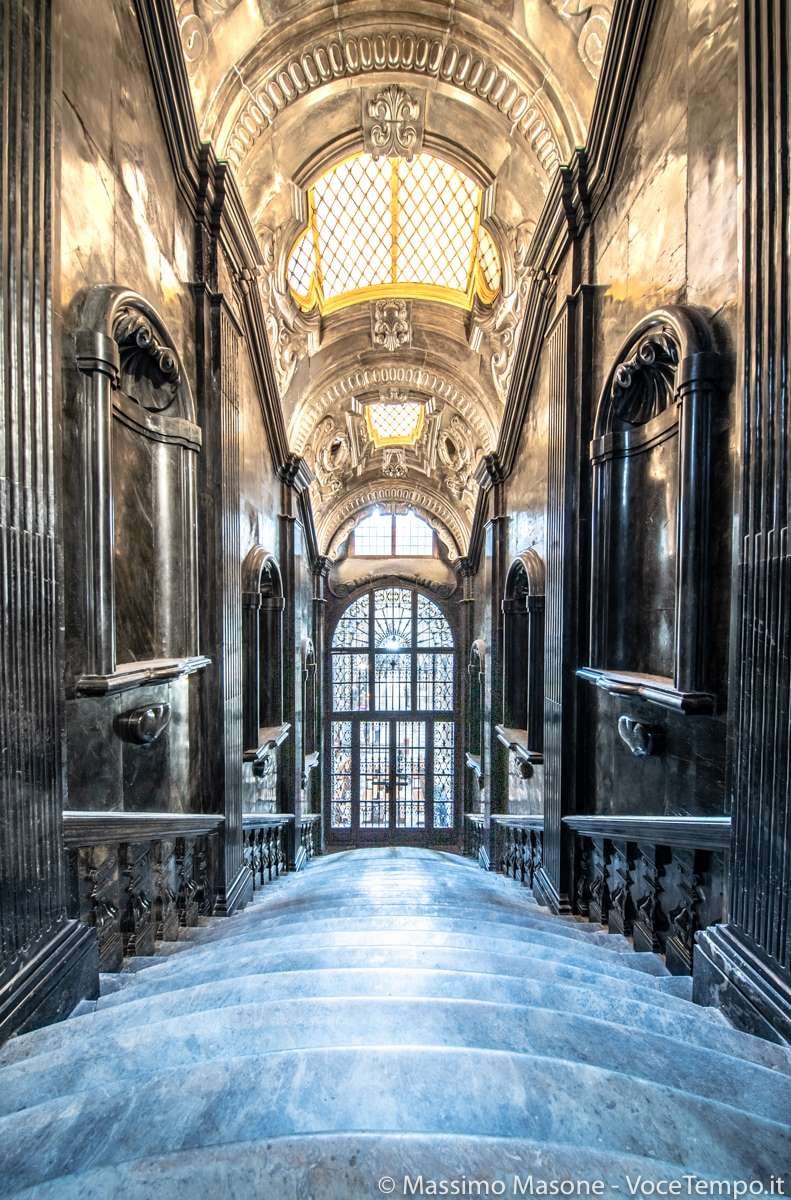IL CASTELLO DELLA PIETRA
A cura di Simone Rivara
Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.
In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.
Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).
Storia del castello della Pietra
Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.
Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).
In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.
Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.
Storia di un restauro
Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.
Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).
Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.
I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).
Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.
Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:
Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.
(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)
Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.
La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.
Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.
Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.
- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -
Bibliografia
PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.
PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.
Sitografia
http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214
L'ICONA DELLA MADONNA DEL PILERIO
A cura di Antonio Marchianò
Il culto della Madonna del Pilerio
L’icona della Madonna del Pilerio attualmente custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è un pregevole dipinto su tavola risalente al XII sec. voluta dall'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo per favorire l'afflusso dei pellegrini. Il culto cattolico della Madonna del Pilerio risale all'anno 1576, quando una devastante epidemia di peste si accanì sulla città di Cosenza facendo numerose vittime. Secondo la tradizione cattolica la popolazione ormai allo stremo, visti gli infruttuosi tentativi umani di arginare l'epidemia, si rivolse a Dio. Si narra che un devoto, che pregava dinanzi all'antica icona della Vergine Maria posta all'interno del Duomo cittadino, si accorse che sul viso della Madonna si era formato un bubbone di peste. Fu allertato il Vicario generale dell'epoca, si sparse immediatamente la notizia, e una grande folla si recò ad ammirare coi propri occhi lo strano evento, che venne interpretato come volontà della Vergine di accollarsi la malattia per liberare la popolazione. La regressione della peste nella città, che avvenne nei mesi successivi, venne interpretata come un vero e proprio miracolo. A seguito dell'evento, la Madonna del Pilerio venne eletta a Patrona Protettrice di Cosenza. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi, e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.
I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603 l'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo, per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse l'icona dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore, e infine, nel 1607, nella cappella appositamente costruita e dedicata alla Vergine, dove ancora oggi si venera. Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'Arc. Mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio come Regina e Patrona della città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quell'occasione si constatò un altro segno sul viso dell'immagine della Madonna: furono infatti notate delle screpolature, che poi scomparvero ma non del tutto, una volta passato il pericolo. Il 6 luglio 1798 si stabilì la celebrazione della sua festa, il giorno 8 settembre di ogni anno, per la sua Natività. Il 12 giugno 1836 l'Arc. Mons. Lorenzo Puntillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con corone d'oro e gemme di grande valore. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l'11 gennaio 1855 ottennero, dall'autorità ecclesiastica l'istituzione di una seconda festa, detta "del patrocinio", in onore della Vergine da celebrarsi ogni anno, il 12 febbraio. Nel 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal capitolo Vaticano e celebrata dall'Arc. Mons. Trussoni (1912-1933). Durante la seconda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due spaventosi bombardamenti che decimarono quasi la città: il 12 aprile e il 28 agosto 1943. Per iniziativa dell'Arc. Aniello Calcara (1941-1961) il 6 settembre 1943 il quadro della Madonna fu temporaneamente trasferito nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta con l'intento di proteggerlo. L'anno 1948 fu caratterizzato dalla "Peregrinatio Mariae" voluta da Calcara come preparazione al Congresso Mariano programmato per il 1951. Il 20 febbraio nuovamente ci fu a Cosenza un violento terremoto. Anche in questa occasione i cosentini si affidarono alla protezione della Madonna del Pilerio, e chiesero e ottennero da Achille Lauro (amministratore apostolico dell'Arcidiocesi) una processione. Il 10 maggio 1981 l'Arc. Dino Trabalzini elevò a Santuario della Vergine SS. del Pilerio il monumentale Duomo di Cosenza. Il 6 ottobre 1984 avvenne la storica visita alla Madonna del Pilerio e al Duomo da parte di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, la cui devozione filiale alla Madonna contraddistinse il suo intero pontificato. Il 10 ottobre 1988 Mons. Dino Trabalzini, in chiusura dei festeggiamenti per l'anno Mariano, proclamò la Madonna del Pilerio Patrona Principale dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e ne confermò il titolo di "Patrona della Città di Cosenza".
L'icona della Madonna del Pilerio: descrizione
L’icona misura 95 x 65 cm ed è stata eseguita in ambito mediterraneo occidentale; grazie alle sue caratteristiche iconografiche è definita “bizantina”. La tavola su cui è rappresentata la Vergine che allatta il Bambino ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti, ma anche danneggiamenti, fino ad essere stata completamente ridipinta. Solo con i restauri voluti dall'arcivescovo Mons. Enea Selis nel 1976-77 ed eseguiti presso la Sovrintendenza per i Beni culturali è stata ripristinata la bellezza originale, che ha permesso una lettura approfondita della immagine dipinta sul legno. L’icona infatti fino ad allora era considerata di scarso valore artistico, e solo una mera riproduzione di una più antica icona medievale. Secondo la Di Dario Guida, l’icona sembra essere stata eseguita durante l’ultimo scorcio della dominazione Sveva. Risulta come uno dei prodotti artistici più rilevanti di un vasto movimento artistico e culturale che subì sia gli influssi del “bizantinismo aulico delle opere messinesi del XIII secolo, sia le affinità delle ricerche plastiche perseguite dai maestri toscani pre-cimabueschi” L’icona si inserisce, inoltre, in una linea che unisce, dal punto di vista artistico, Monreale, Messina e la Campania.
La figura della Vergine
Partendo dalla figura della Vergine rappresentata possiamo affermare, confortati da autorevoli studi, che l’immagine è la sintesi tra una Galaktotrophousa (Colei che dona il latte) e la Kikkotissa (Vergine dal rosso manto). I due particolari pittorici relativi all'allattamento del Divin Bambino e del Maforiuòn (manto rosso) emergono nella loro immediatezza appena ci si accosta all'icona.
Il titolo di Pilerio, chiaramente postumo alla sua realizzazione, offre diverse interpretazioni, alcune anche apparentemente contrastanti, ma tutte permettono di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di tipo teologico, devozionale e pastorale date all'icona. La più tradizionale interpretazione del titolo è quella di Pilastro. Essa fa letteralmente riferimento alla collocazione originaria dell'icona, che si trovava collocata su una colonna all'interno della chiesa Cattedrale. Questo titolo potrebbe risalire proprio al periodo di dominazione spagnola o comunque all'epoca del miracolo della peste nel 1576, epoca nella quale l’influenza della pietas spagnola potrebbe aver portato a Cosenza la devozione per la Vergine del Pilar, anch'essa collocata su di una colonna. Testimonianze di questa influenza sono ancora presenti, ad esempio, nell'America latina, dove forte fu la dominazione spagnola. Un altro dato di cui tener conto è la certa influenza bizantina dovuta all'appartenenza della Città all’Eparchia greca fin dal IV secolo e della vicinanza con Rossano. Nella tradizione e nella liturgia bizantina è uso collocare la Vergine proprio alla porta del Tempio e nei punti strategici delle Città come atto di affidamento alla “Custode” del popolo di Dio (dal greco puloròs = custode della porta).
L’icona è avvolta da una luce tutta particolare che emerge dallo sfondo oro che simboleggia la gloria di Dio che tutto abbraccia. La grazia trasfigura la creatura nella quale “abita l’Altissimo”. Tutte le icone, ma particolarmente quelle della Madre di Dio, sono accompagnate dall'oro che indica il progetto e l’iniziativa di Dio, la gloria scende e prende possesso della tenda. Anche il rosso del velo che scende dal capo e il porpora dell’abito di cui Maria è rivestita sono simboli della divinità che “avvolge” la giovane di Nazaret e ne coinvolge mente e cuore. Il colore porpora dell’abito richiama anche la dimensione sacerdotale e regale ma soprattutto la “potenza dell’Altissimo” di cui l’Angelo annunziante le parla quando le propone il grande progetto della salvezza e della maternità. Il velo rosso che scende sulla spalla vuole significare che la Vergine Maria è stata “avvolta” dall'alto e ricoperta dalla grazia. Il marrone della veste della vergine è richiamo della sua umanità, mentre l’altra parte di manto di colore blu che avvolge la donna, ed avvolge anche gli abiti, indica il privilegiato rapporto con Dio di questa creatura. Base di ogni colore è il bianco che in tutta la tavola esprime la purezza, l’immacolato concepimento della Vergine. Esso si intravede sulla fronte, nella manica del braccio sinistro ed è l’abito che ella indossa sotto tutti gli altri. Le tre stelle, secondo l’iconografia classica bizantina, sono collocate una sulla fronte e due ai lati sulle spalle. Esse indicano che Maria è inabitata dalla Trinità ma anche la sua Verginità prima, durante e dopo il parto. I medaglioni dorati intorno al capo della Vergine sono undici. Rappresentano la Chiesa Apostolica senza l’apostolo Giuda che aveva tradito il Signore. Questo particolare stellario indica Maria presente nel Cenacolo di Gerusalemme, accanto agli Apostoli, proprio nei giorni e nelle ore della Pasqua fino alla Pentecoste. Le scritte in latino (MR e DOMINI) collocate rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine come prescritto dal Concilio di Nicea (787d.C) indicano la maternità divina di Maria. L’aureola sul capo del Divino Bambino contrassegnato dalla croce è un chiaro richiamo alla Passione di Cristo e al suo regnare glorioso. Il mistero dell’Incarnazione infatti è strettamente collegato con quello della Redenzione. Un ultimo segno che appare sulla tavola è la macchia scura sul volto della Vergine. È il segno della peste di cui Maria si è caricata per liberare miracolosamente la città di Cosenza afflitta dal terribile morbo e di cui storia e devozione popolare sono ancora testimoni. La Vergine Maria regge il Bambino tra le braccia e Gesù è seduto delicatamente sulla mano destra; essa diventa per lui quasi un trono da cui regna. Un drappo rosso posto tra le mani della Madonna richiama la sua signoria, la sua potestà regale e sacerdotale, la sua divinità. Non è escluso anche il richiamo alla Passione. Gesù che prende il latte dalla mammella diventa un particolare iconografico molto evidente: c’è una stretta tensione tra Cristo che è capo della Chiesa e il suo corpo mistico, di cui Maria ne è icona perfetta. Alcuni studiosi vedono proprio nella posizione del collo piegata verso il Bambino questa strettissima dipendenza e questo stretto rapporto tra Gesù e Maria, tra Cristo e la Chiesa. L’iconografia del seno si chiarisce ancora di più se la Vergine è colta nella dimensione di nutrice dei figli (Colei che nutre, imbandisce il banchetto, la mensa) fino a diventare, come la invoca la Chiesa ortodossa, Trapeza, evidente richiamo alla mensa eucaristica. Il Bambino è rappresentato con due addomi, strettamente legati da una fascia rossa intrecciata, ad indicare che le due nature umana e divina che sono unite in Cristo. Nella piccola fascia rossa intrecciata alcuni hanno intravisto anche un prolungamento del cordone ombelicale che unisce il figlio (divino) alla Vergine (madre) per esprimere visivamente il titolo di Madre di Dio (Theotòkos) inciso sulla tavola. Copre il Bambino un trasparente velo bianco che ricorda la divina purezza di Cristo agnello senza macchia che toglie i peccati del mondo e riscatta con l’effusione del suo sangue l’intera umanità dalla schiavitù, dai peccati e dalla morte. La Vergine come in ogni antica icona indica con la mano sinistra il figlio, si fa Odigitria (indica la Via) per tutti coloro che guardano la sua immagine e che potrebbero cadere nella tentazione di fermare lo sguardo su di lei. Le dita delle mani indicano anche alcune verità di fede: le tre dita della mano destra richiamano il mistero trinitario e ancora il parto verginale di Maria toccata dal mistero dell’Incarnazione; le due dita della mano sinistra invece indicano la doppia natura umana e divina di Cristo.
Bibliografia
Di Dario Guida M. Pia, Itinerario dell’arte dai Bizantini agli Svevi, in “Itinerari per la Calabria”, ed. l’Espresso, Roma, 1983, p.157.
Di Dario Guida M. P., Cultura artistica della Calabria medievale, di Mauro Edizioni, 1978.
Frangipane A., Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II – Calabria, Roma 1933, p. 121.
Leone G., Icone della “Theotokos” in Calabria, Ed. Vivarium 1990
Leone G., Icone della “Teotokos” in Calabria, in “Concilio Niceno II e l’iconografia mariana in Calabria”, atti del convegno, Cz, 1987, a cura di Squillace M., Edizioni Vivarium, Catanzaro, 1990, pp.119 e ss.
Napolillo V., Storia e fede a Cosenza, la Madonna del Pilerio, Edizioni Santelli, Cosenza, 2002, p.13.
Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus, dogma dell’Immacolata, 8 dicembre 1854.
Tuoto G., La Madonna del Pilerio, Leggenda, Cosenza 2001, p. 32.
Vitari S., Il Duomo di Cosenza, in Bilotto L., Il Duomo di Cosenza, Effesette, Cosenza, 1989, p.101.
LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA
A cura di Luisa Generali
Introduzione: mitici antri
Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.
La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale
La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.
Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.
Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia
Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.
Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione
Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe
Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.
Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.
Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".
Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).
Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.
Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).
Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.
Bibliografia
Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.
Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/
Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.
Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.
Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.
Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.
Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.
Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.
Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.
Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.
Sitografia
Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363
Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi
CASTEL DEL MONTE: IL CASTELLO OTTAGONALE
A cura di Giovanni D'Introno
Castel del Monte è uno degli edifici più emblematici e suggestivi della Puglia e di tutto il Medioevo, ingegnosa opera di precisione geometrica ed eclettismo stilistico. La costruzione di questo misterioso castello, sorto su una catena delle Murge Occidentali nei pressi di Andria, fu ordinata dal celebre Federico II di Svevia, lo “Stupor mundi”. Incerto però rimane l'arco cronologico in cui inserire i lavori di costruzione, ai quali parteciparono indubbiamente i cistercensi, i cosiddetti “monaci dissodatori”: una data di riferimento è il 29 gennaio 1240, quando Federico ordinò a Riccardo di Montefuscolo, giustiziere di Capitanata, di disporre il materiale necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa di “Sancta Maria de Monte”, oggi non più mirabile, venendo così denominato per molti decenni “Castello di Santa Maria del Monte”. In realtà quei materiali richiesti servivano per completare la copertura dell'edificio, quindi questa data non va intesa come il momento d'avvio dei lavori, dal momento che, secondo alcuni studiosi, in quegli anni il castello era quasi terminato. Infatti, alcune fonti documentano alcuni eventi importanti svoltisi pochi anni dopo nel castello, come i festeggiamenti per il matrimonio di Violante, figlia naturale dell'imperatore e Bianca Lancia.
Con la caduta definitiva degli Svevi ,dopo la disfatta di Corradino a Tagliacozzo nel 1268, Carlo I d'Angiò vi imprigionò i figli di Manfredi. Il castello nei secoli successivi svolse principalmente la funzione di carcere.
Nel 1552 entrò a far parte del patrimonio dei conti Carafa di Ruvo, diventando per questi un luogo di villeggiatura. Negli anni della peste della metà del XVII secolo, ospitò numerose famiglie di nobili andrianesi. Dal XVIII secolo però il castello fu lasciato in totale stato d'abbandono e di conseguenza fu soggetto a razzie e funse da rifugio per pastori e briganti.
Nel 1876 l'edificio fu acquistato dallo Stato Italiano per 25.000 lire e furono avviati lavori di restauro, che ebbero ulteriori sviluppi dal 1928 fino agli anni Ottanta. Dal 1996 fa parte della lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e dal 2002 compare la sua effige nel centesimo di euro.
Il castello in pietra calcarea locale è a pianta ottagonale, riproponendo la forma della corona imperiale, e a ciascuno degli otto spigoli poggia una torre, anche questa ottagonale. La struttura si sviluppa su due piani, ognuno dei quali è composto da otto sale di forma trapezoidale, che configurano una corte ottagonale al centro del castello (fig. 1), all'interno della quale vi era una vasca anche questa di forma ottagonale.

Il portale principale in breccia corallina (fig. 2), al quale si accede attraverso due rampe di scale, è costituito da due lesene scanalate con capitelli corinzi che sorreggono un finto architrave, sul quale a sua volta si erge un timpano cuspidato, come citazione all'arte classica, all'interno del quale vi erano probabilmente delle statue, tra cui il busto di Federico II (fig. 3), oggi custodito nel Castello di Barletta, il “frammento Malajoli”, consistente in un frammento di testa laureata, e i resti di un busto imperiale, ritrovati durante il restauro degli anni '20 ai piedi di Castel del monte e oggi esposti nella Pinacoteca Provinciale di Bari. L'apertura esterna dell'arco del portale presenta due colonnine sormontate da due leoni dal taglio romanico. L'ingresso che si affaccia verso occidente è costituito da un semplice arco a sesto acuto.
Ogni lato di Castel del Monte presenta due finestre in asse tra di loro, una per ogni piano, in breccia corallina e sostenute da colonnine in marmo bianco. Le due finestre, inquadrate tra le due torri ai vertici, sono divise da una cornice marcapiano: le pareti del piano terra, eccetto quelle in cui sorgono i portali, presentano delle monofore, mentre le pareti del piano superiore presentano delle bifore (fig. 3), eccetto la parete che guarda verso nord, che presenta una trifora. Sulle torri si aprono numerose feritoie e davanti ad una torre si erge una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, necessaria per lo scarico dei servizi.

Il piano terra è costituito da otto sale trapezoidali: il soffitto di ogni sala è stato idealmente scomposto in un quadrato, sormontato da volte a crociera costolonata, i cui costoloni partono da colonne in porfido rosso (fig.4) e si inerpicano fino ad incrociarsi nella chiave di volta (fig.5), spesso scolpite con elementi vegetali o con particolari teste di fauno dalle grandi orecchie, e in due triangoli laterali, sorretti ciascuno da semibotte ogivali.
Si può accedere al cortile centrale attraverso tre porte con arco a sesto acuto (fig. 6). Per raggiungere il piano superiore, bisogna usufruire delle scale a chiocciola che si trovano nelle torri. Anche il piano superiore è diviso in otto sale trapezoidali, con bifore dotate di scale e sedili. In queste sale viene riproposta la volta a crociera costolonata del piano terra, con i costoloni che partono da colonne con capitelli a crochets. Nelle sale, inoltre, sono visibili i resti di altissimi camini. Alcune sale sono dotate di porte finestre, impreziosite da breccia corallina e marmo bianco, che si affacciano sul cortile interno.

Come già detto, il castello è privo di ogni tipo d'arredo, ma conserva numerose e raffinate decorazioni scultoree, come i telamoni che sorreggono la volta di una delle torri e le mensole della torre del Falconiere (chiamata così perché secondo la tradizione vi venivano allevati i giovani falchi) con teste antropomorfe (fig. 7), connotate da una certa plasticità, tipico della scultura gotica. Inoltre è importante segnalare la scoperta di resti di pavimento musivo in una delle sale del piano inferiore.

Per anni gli studiosi hanno cercato di cogliere l'originaria funzione del castello e svelare i segreti che si celano dietro queste possenti mura. Si presume che sia nata come residenza di caccia: infatti l'imperatore possedeva ottime abilità venatorie, soprattutto con l'ausilio dei falconi; quindi poteva far sfoggio di questa sua arte proprio nell'incolto circostante. Questa tesi è stata negata, dando la possibilità di emergere ad un'altra congettura più recente, secondo la quale l'edificio, dato il sistema di raccolta d'acqua d'origine islamica, sia stato adibito a centro benessere per la rigenerazione del corpo, ricalcato sull'hammam arabo.
Ciò che ha fatto dubitare molto gli studiosi è il fatto che la struttura si presenta priva di spazi adibiti a stalle, cucine e di una cinta muraria intorno al castello. Probabilmente quest'ultima vi era in precedenza, dal momento che il notaio cronista Domenico da Gravina ci riporta nelle sue cronache, risalenti alla prima metà del XIV secolo, la notizia della fuga di un prigioniero da Castel del Monte, che avrebbe scavalcato le mura. Di conseguenza, si ipotizzava la presenza di strutture mobili in legno tra la cinta muraria e il castello, che dovevano quindi svolgere il ruolo di cucine, depositi e stalle.
Bibliografia
S. Mola ,“Castel del Monte”, 2018, Mario Adda Editore.
Sitografia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_del_Monte
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/castel-del-monte-la-fortezza-dei-misteri.html
GLI EX LIBRIS DEL FONDO LEBORONI A MACERATA
A cura di Matilde Lanciani
Introduzione: gli ex libris nella storia
Se parliamo di ex libris facciamo riferimento ad una tipologia di arte contrassegnata storicamente come “minore” ma che presenta nel suo piccolo universo una varietà di elementi culturali ed artistici che ne fanno un piccolo scrigno culturale. Con questo termine (con le varianti ex biblioteca, ex catalogo, simbulum bibliothechae, ex libris musicis, ex libris medicinae, ex libris eroticis..) indichiamo infatti un’incisione, solitamente di piccolo formato, eseguita in pochi esemplari numerati, secondo la richiesta di un committente mediante una serie di tecniche incisorie come la stampa a rilievo o alta, la stampa in cavo e la stampa in piano. L’ex libris, posto sul piatto interno alla copertina di un libro, indica infatti, come suggerisce la locuzione latina “ex” ossia “da”, che quel libro appartiene alla determinata collezione di un qualsivoglia bibliofilo, collezionista o studioso.
Nell’ex libris compaiono solitamente motti o stemmi che fanno riferimento alle caratteristiche di chi li commissiona per affermare la propria dotazione libraria e ribadirne la proprietà. Andrea Galante ne “Gli ex libris tedeschi”, articolo del 1987 sulla rivista “Emporium”, riporta un simpatico motto di un gentiluomo inglese che fece incidere sui suoi ex libris queste parole:
“My book is a thing
my fist ist an other
if you steal one
you will feal the other”.
(“Il mio libro è una cosa, il mio pugno un’altra. Chi ruba il primo proverà l’altro”).
Questa attestazione di possesso porta con sé moltissimi significati artistici e storici che è possibile ravvisare in una tipologia artistica così rara e preziosa: in primo luogo dà notevoli indizi sul periodo al quale appartiene l’ex libris, sull'individualità e le peculiarità di chi lo commissiona e anche sui connotati degli artisti che lo realizzano e dei modelli ai quali si ispirano.
I primi ex libris sono da ricercare addirittura nell'Antico Egitto, sappiamo che i rotoli di papiro del Faraone Amenophis (XV sec. a.C) venivano contrassegnati da una piastrina che recava il nome della coppia regnante. Allo stesso modo, in Cina, dopo l’invenzione della carta, l’ex libris assumeva quello stesso significato allegorico che gli è attualmente attribuito.
“Con questi precedenti – scrive E. Bragaglia – l’invenzione della stampa trovava nell’ex libris l’elemento perfetto in tutte le sue componenti; veniva stampato con gli stessi torchi utilizzati per il libro, le figurazioni simboliche erano incise su legno, analogamente alle illustrazioni che ornavano i libri più fastosi”.
Il primo esemplare riferibile a quest’arte è stato rinvenuto in Germania nel 1470, appartenente al religioso bavarese Hans Knabensberg. Successivamente nella personalità di Albrecht Dürer troviamo un grande punto di riferimento con la prima attribuzione di un ex libris del 1516 destinato a Hieronymus Hebner, giudice di Norimberga.

Michael W., X bn.
In ambito italiano il Bertarelli indica come documento principale a testimonianza di questa pratica artistica un ex libris eseguito per Mons. Cesare dei Conti Gambara, consacrato Vescovo di Tortona nel 1548 e poi un altro ancora per il giureconsulto pistoiese Niccolò Pilli, entrambi incisi su legno. Jacopo Contarini commissionò un altro esemplare nel 1560, posto a circoscrivere la raccolta da lui donata alla biblioteca di San Marco a Venezia, ne troviamo altri esempi in quelli di Bernardo Clesio e Gerolamo Veratti fra Trento e Ferrara. Nell'Italia rinascimentale sicuramente la tecnica incisoria ebbe una particolare fioritura grazie anche al Pollaiolo e al Mantegna, figure di spicco per quanto riguarda la divulgazione di questa pratica da cui deriva anche la tematica exlibristica. Nel ‘600 il disegno diventa più ricco e adorno con nastri, tralci di vite, rami fioriti ecc., tendenza che andrà sostituita poi nel ‘700 con la semplice etichetta tipografica che reca il solo nome e cognome del titolare della biblioteca.
In Germania, dove senz'altro il genere nasce e trova terreno fertile, viene introdotta la tecnica dell’acquaforte, che trova in Rembrandt le sue radici con una serie di sperimentazioni dell’artista anche a bulino e puntasecca. Verso la fine dell’800 la xilografia è sostenuta da artisti del calibro di Gauguin, Münch, Kirchner e gli espressionisti della “Die Brüke” mentre agli inizi del ‘900 si fa risalire la linoleografia (in sostituzione del legno) per merito di Matisse e Picasso.
Nel 1902 in Italia viene pubblicato l’ancora ad oggi insuperato volume sugli exlibristi “Gli ex libris italiani” di Bertarelli e Prior e nel 1919, quando nasce la prima associazione di collezionisti a Torino, questo tema avrà ancora più ampio respiro supportato anche da iniziative artistiche come la rassegna “EROICA” fondata da Ettore Cozzani e Franco Oliva nel 1911 a La Spezia in cui Adolfo De Carolis emerge come figura rilevante del gruppo.
La prima fase dell’exlibrismo italiano parte quindi da Torino e precisamente nel 1910 ad opera del conte Rati Opizzoni che fondò l’”Associazione italiana tra amatori di ex libris”, prosegue poi con l’ “AIACE” a Bologna di Gino Sabbatini e la “B.N.E.L Bianco e Nero ex Libris” fondata e gestita dall'ingegnere Gianni Mantero di Como, il quale collezionò più di 2.000 esemplari individualmente.
Il fondo Leboroni della biblioteca statale di Macerata e l’opera di catalogazione di Goffredo Giachini
La collezione del fondo Leboroni di Macerata è stata donata da Maria Elisa Leboroni, xilografa di successo internazionale, che ha raccolto oltre 12.000 ex libris i quali costituiscono il nucleo di questo tema in ambito marchigiano. Nel 2002 infatti, Angiola Maria Napolioni, già direttrice della biblioteca statale di Macerata, mise le premesse per la costituzione del Fondo Leboroni appoggiando il progetto di Goffredo Giachini, noto curatore di esposizioni dedicate all'incisione e altro, mirante alla definizione della donazione a favore alla Biblioteca stessa.
Leboroni, allieva di Gerardo Dottori, Pietro Parigi e padre Diego Donati, realizza ex libris caratterizzati da un linguaggio personale, molto raffinato e fortemente coloristico. “La bellezza è la forma che l’amore dona alle cose” è infatti il credo di questa artista che trae le sue radici dal grande xilografo Mimmo Guelfi.
Il fondo è stato interamente catalogato da Giachini che con competenza, costanza e dedizione ha suddiviso tutti gli ex libris in ordine alfabetico, cronologico, a seconda della tecnica, delle dimensioni, del committente e della tematica trattata. L’importante collezione è stata interamente digitalizzata e resa fruibile a studiosi, letterati ed artisti. Ma cosa più singolare è che Giachini ha riportato una serie di riproduzioni nel libro “Gli ex libris del Fondo Lebroni della Biblioteca Statale di Macerata” del 2015 commentato dal critico Gian Carlo Torre, le quali presentano gli exlibristi con autografi originali e l’elenco dei loghi e delle firme di tutti gli autori facenti parte del fondo.
In ambito marchigiano, Giachini si era in precedenza dedicato, come ci racconta, ad una serie di studi legati a questo tema prendendo in considerazione molti artisti come Bruno da Osimo, Renato Bruscaglia, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Giuseppe Mainini, Luigi Bartolini, Vito Giovannelli, Maria Adriana Gai e molti altri. A proposito del Bartolini, è bene precisare che questo illustre atrista del bulino, ha inciso non più di 8 ex libris, uno dei quali, dedicato al Mantero, fa parte del fondo Leboroni.
Goffredo Giachini, componente per molti anni del direttivo dell’Accademia dei Catenati di Macerata e collezionista, spiega: “La prima mostra fu fatta nella Galleria Galeotti in Piazza Vittorio Veneto, gestita dalla Fondazione Carima, poco dopo la Leboroni pensò di donare la sua preziosa collezione a Macerata. Mi sono fatto carico di classificare tutto questo materiale per renderlo disponibile a chi volesse godere di questo patrimonio”.
A introduzione del volume curato da Giachini troviamo una citazione esemplificativa da Bruno Marsili da Osimo: “La gemma che incastona l’aurea bellezza del libro è il suo ex libris. Al pari del cammeo e del niello, esso concentra in minime proporzioni la potenza dei grandi quadri”.
Dal Fondo Leboroni
Sul frontespizio di un Codice Giudiziario delle cause civili del principato di Trento del 1788 si leggeva questo motto:
“Hic liber est meus quem mihi dedit Deus, nomen non pono, quia laudari nolo; si tamen vis scire, in ultima pagina experire”.
All’ultima pagina lo sberleffo: “Si curiosus fuisti, nasu longo eccepisti”.
(Le dimensioni delle immagini presenti all'interno dell'articolo non rispettano quelle dei reali ex libris ma sono state ampliate per permettere una migliore fruizione)
Bibliografia
Beccaletto C. (1999), Le tematiche grafiche dell’ex libris, Roccalbegna, Grosseto.
Bragaglia E. (1988), Bibliografia Italiana degli ex libris, ed. TEMI.
Conforti A. (2019), Quelle piu modeste imprese. Gli ex libris: storia, linguaggio, stili, fortuna.
Giachini G. (2015), Gli Ex libris del fondo Leboroni della Biblioteca Statale di Macerata, Biblohaus.
Palmirani, R. (1999), Manuale dell'amatore di ex libris: guida illustrata alla storia, alla cultura ed al collezionismo degli ex libris dal XVI secolo ai giorni nostri. Essegi.
Raimondo L. (1952), Ex libris e marchi editoriali di L.Servolini, ed. Fiammenghi, 1952.
Torre G.C. (2009), Da segno di possesso a stumento di conoscenza. L’Ex libris una storia in breve, La Berio, anno XLIX- n.1 gennaio/giugno, pag. 8-17.
LA CASINA CINESE: UNA DIMORA PER GLI SVAGHI
A cura di Antonina Quartararo
La storia della Casina cinese: un amore a prima vista
Ferdinando IV di Borbone e la moglie Maria Carolina arrivarono a Palermo nel 1798, in fuga dalla città di Napoli, dopo 40 anni di regno, per i tumulti provocati delle truppe francesi e per trovare protezione sotto il protettorato inglese in Sicilia. Esule e lontano dalla sua residenza napoletana, per il re le battute di caccia e le sperimentazioni agricole rimanevano sempre una grande passione. Per far fronte a questo suo interesse per l’arte venatoria, il re diede l’incarico al viceré Giuseppe Riggio, principe di Aci, di acquistare i terreni situati nella cosiddetta “Piana dei Colli” sotto le pendici di Monte Pellegrino (Fig.1). All'interno di questi terreni (che corrispondono all’attuale Parco della Favorita) sorgeva un edificio ligneo dallo stile “stravagante” di proprietà dell’avvocato Benedetto Lombardo, che piacque molto al re Ferdinando IV che decise di ristrutturarlo per adibirlo a seconda residenza dopo il Palazzo reale. Per comprendere l’aspetto della preesistente casina lignea, ci rimane un importante acquerello realizzato da Pietro Martorana nel 1797, oggi conservato presso il Palazzo Reale del capoluogo siciliano (Fig.2). Da questo disegno si denota come l’originaria costruzione lignea, dagli evidenti caratteri orientali, aveva una pianta quadrata con tre elevazioni sormontati da tetti a pagoda e da ringhiere che ne ornavano il perimetro.
L’edificio attuale
Gli interventi ottocenteschi di trasformazione in residenza regale furono affidati all'architetto palermitano Giuseppe Venanzio Marvuglia che si occupò anche di sistemare i giardini. L’architetto organizzò la casina a più livelli aggiungendo due terrazzi simmetrici cinti da colonnati e da un seminterrato (Fig.3). Dal 1802 la direzione dei lavori fu affidata al figlio di Marvuglia, Alessandro Emanuele, che concluderà i lavori. Partendo dall'ultimo livello dell’edificio si trova una grande terrazza coperta da un tetto a pagoda e una loggia ottagonale denominata “Sala della Specola” o “Stanza dei Venti” decorata all'interno dall'artista Rosario Silvestri. Al primo e al secondo piano vi sono delle balconate continue da cui si accede anche da due torri esterne con scale elicoidali realizzate da Giuseppe Patricolo nel 1806 (Fig.4).
Il seminterrato presenta dei portici ad archi acuti che ricordano lo stile gotico. I pronai dei prospetti nord e sud, a sei colonne di marmo, sono coronati da cornice a pagoda da cui si ricavano due piccoli terrazzi (Fig.5). Elementi tratti dallo stile Neoclassico sono le cornici di colore rosso, verde e ocra che delineano le porte e le finestre della facciata esterna. Le cancellate sono decorate con campanellini e i lampioni sono di gusto orientale (Fig.6).
Gli interni della Casina cinese
Per quanto concerne la decorazione degli interni, essa spazia tra lo stile cinese, quello turco e il gusto neoclassico (per lo stile pompeiano e le raffigurazioni di rovine). Il secondo piano adibito ad uso della regina Maria Carolina è composto da un “Salottino alla turca” (Fig.7 a-b) e dal “Salottino all’Ercolana”, di chiaro gusto neoclassico e ispirato alle scoperte archeologiche, decorato dal Silvestri (Fig.8). Un piccolo ambiente soprannominato “gabinetto delle pietre dure” aveva la funzione di studiolo ed è ornato da motivi ad intarsio (Fig.9 a-b). Sullo stesso piano è collocata la camera da letto con spogliatoio in stile neoclassico, decorata da piccoli medaglioni dove sono raffigurati i ritratti monocromi dei membri della famiglia reale ornati da didascalie dai toni amorevoli e affettuosi attribuiti al pittore napoletano Cotardi (Fig.10).


Nel piano intermedio troviamo le stanze della servitù, delle dame e dei cavalieri decorate in stile neoclassico e da figure mitologiche. Al primo piano, da cui si accede tramite le due scalinate esterne del prospetto sud, troviamo la zona di rappresentanza con il “Salone delle Udienze” (Fig.11 a, b, c, d, e) impreziosito da pannelli in seta decorati con motivi cinesi e delle scritte in varie lingue: arabo, cinese ed ebraico (le scritte non possiedono alcun significato) e il “Salottino da gioco” decorato da Velasco con scene tratte dal mondo cinese e uccelli intrecciati a motivi ornamentali. A destra dell’entrata si trova la sala da pranzo con la “tavola matematica” progettata dal Marvuglia, dotata di un dispositivo a corde con il quale faceva salire e scendere le portate dalla cucina per evitare l’intervento fisico della servitù (Fig.12 a,b,c,d). Un tavolo simile si trova nel Petit Trianon situato all'interno dei giardini della Reggia di Versailles fatto installare da Luigi XV. Le pareti della sala da pranzo sono decorate con scene di vita quotidiana cinese in un’ambientazione campestre. A sinistra dell’entrata, invece, è disposta la stanza da letto del re Ferdinando IV delimitata da un’alcova con otto colonne in marmo bianco. Il soffitto fu dipinto da Velasco e Cotardi con figure di pavoni simbolo della fertilità e con personaggi cinesi abbigliati con vesti multicolori in atto di rendere omaggio ai dignitari seduti sotto grandi pagode (Fig.13).

Nel seminterrato si trovano la camera da bagno in marmo con una grande vasca ovale incassata nel pavimento e la “Sala delle Rovine” con un tromp-l’oeil che raffigura nella volta una finta rovina avvolta dalla natura selvaggia e dall'umidità (Fig.14) attribuito a Raimondo Gioia, e la “Sala da Ballo” con due vani orchestra e ornata in stile Luigi XVI da Velasco (Fig.15). Dopo aver subito un accurato restauro la Casina cinese è stata riaperta al pubblico nel 2009.
Il gusto per le cineserie
La costruzione mostra con disinvoltura l’accostamento e la fusione di elementi esotici e orientali all'arte neoclassica, dando vita a quello stile che prende il nome di “eclettismo ottocentesco”. All'epoca la Cina non era una terra molto conosciuta, ma la sua cultura raggiunse l’Europa, in particolare la Francia e poi Napoli soprattutto attraverso l’Inghilterra, mediante l’importazione di testi, stampe, porcellane e tessuti. Di questa cultura “cinese” se ne fece un’interpretazione artistica propria ed in Sicilia questo stile ebbe molto slancio, soprattutto nella città di Palermo, dato l’avvicinamento con l’Inghilterra durante la guerra napoleonica. Ulteriori testimonianze sono: la “Sala Cinese” dipinta dai fratelli Giovanni e Salvatore Patricolo all'interno degli appartamenti del Palazzo Reale di Palermo che veniva utilizzata spesso dai regnanti come sala da tè e il “Salottino alla cinese” decorato dal pittore Giovanni Lentini con sete e dipinti con temi d’ispirazione orientale realizzato presso il Palazzo Filangeri di Mirto a metà del XIX secolo (Fig.16).

Bibliografia
Bajamonte C. et al., Palermo l’arte e la storia. Il patrimonio artistico in 611 schede, Palermo 2016.
LA CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE
A cura di Francesco Surfaro

Sublime parto dell'estro anticonvenzionale di Guarino Guarini, la Cappella della Sacra Sindone è un unicum all'interno del panorama architettonico europeo. Dopo il disastroso incendio che, nel 1997, ha rischiato di distruggerla per sempre, è rinata dalle proprie ceneri grazie ad una lunga e complessa opera di restauro.
La storia
Tra 1576 e 1577 una violenta epidemia di peste imperversava a Milano e in diversi altri centri dell'Italia settentrionale e della Sicilia. Al fine di impetrare la liberazione della città dal terribile morbo, il cardinale-arcivescovo metropolita del capoluogo lombardo, Carlo Borromeo, pronunziò solennemente il voto di compiere un pellegrinaggio penitenziale a piedi fino alla Sainte-Chapelle di Chambéry, per venerare la Sacra Sindone ivi custodita. Secondo la tradizione cattolica, tale reliquia - un lenzuolo di lino intriso del sangue di un uomo flagellato e crocifisso - sarebbe il sudario entro il quale, dopo la morte e la deposizione dalla croce, venne avvolto il corpo di Cristo prima di essere sepolto. Il sacro cimelio era di proprietà dei Savoia sin dal 1453, data in cui la nobile francese Marguerite de Charny lo cedette a Ludovico di Savoia. Venuto a conoscenza del voto di Borromeo, Emanuele Filiberto di Savoia detto il "Testa di Ferro", abile diplomatico e scaltro stratega, incaricò il canonico Neyton di traslare definitivamente il Santissimo Sudario dall'ex capitale transalpina del ducato sabaudo alla nuova capitale, Torino. In questo modo il duca intendeva ingraziarsi l'illustre porporato milanese (uno dei principali fautori della Controriforma), che così facendo si sarebbe risparmiato diversi chilometri, e portare più vicino a sé quello che era considerato come una sorta di palladio dinastico. Nel 1578, al termine della pestilenza, la Sindone venne trasferita ed accolta in pompa magna alle porte di Torino con un solenne corteo processionale, che la scortò fino al Palazzo Ducale. Il viaggio verso la capitale fu tutt'altro che facile: era infatti divenuto indispensabile percorrere sentieri meno diretti che fossero fuori dal raggio d'azione degli ugonotti, i quali, appresa la notizia della traslazione, avevano manifestato la volontà di impadronirsi della Sindone per distruggerla. L'undici ottobre dello stesso anno, nella cornice del coro della Cattedrale di San Giovanni Battista, si tenne l'evento epocale dell'ostensione della sacra reliquia alla presenza del cardinale Borromeo che, il giorno precedente, appena arrivato in città, aveva sciolto in forma privata il proprio voto presso la chiesa romanica di Sancta Maria ad Praesepe (la futura Real Chiesa di San Lorenzo).

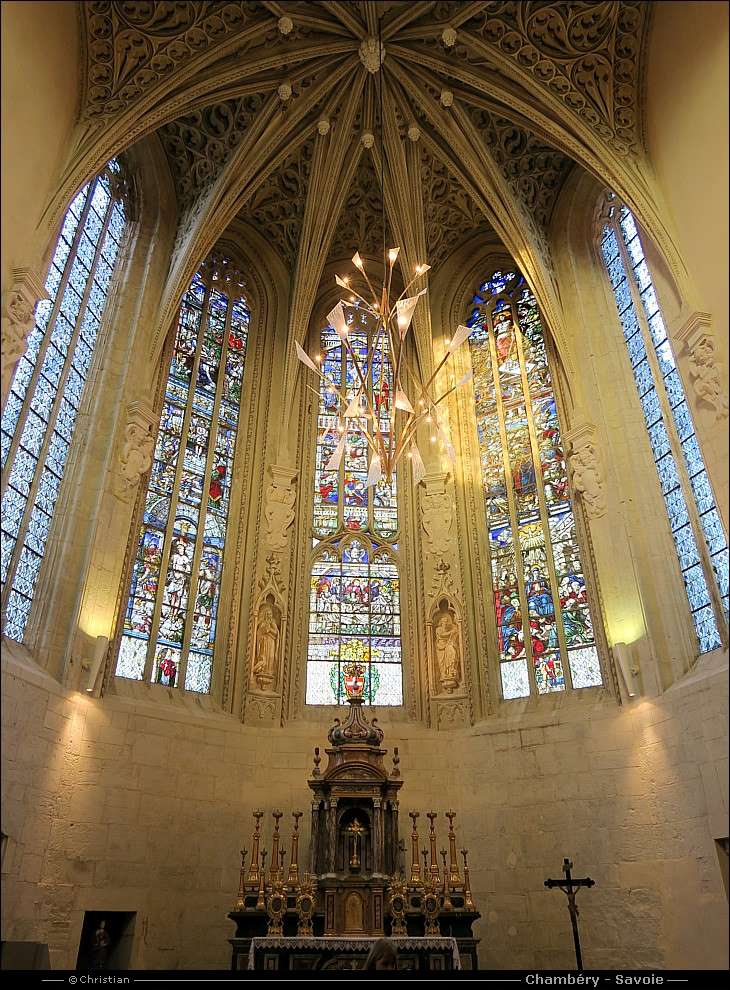
Morto nel 1580, Emanuele Filiberto ordinò per disposizione testamentaria che fosse edificato un luogo di culto in cui il sacro lino potesse "con degna pompa venerarsi" e lì voleva che fosse preparata la propria sepoltura. Lasciò inoltre scritto che la costruzione dell'edificio doveva essere finanziata interamente con le elemosine raccolte nel corso dei suoi funerali. In attesa dell'inizio dei lavori, la Sindone rimase all'interno del duomo presso la cappella dei santi Stefano e Caterina, nella navata sinistra. Due a questo punto erano le soluzioni possibili che si prospettavano per la custodia del sacro vestigio: innalzare un grande spazio liturgico indipendente dalla cattedrale e con un convento annesso per la cura dei sacri uffizi, che fosse collocato in una posizione eminente all'interno della città, oppure erigere un altare sotto la crociera della cattedrale, la cui imponenza doveva essere direttamente proporzionale all'importanza della reliquia. Per ovviare alla questione venne interpellato l'architetto e pittore Pellegrino Tibaldi detto Pellegrino de' Pellegrini, personaggio chiave per l'arte lombarda post-tridentina molto vicino a Carlo Borromeo. Tibaldi, incaricato dall'Eccellenza milanese di fare pressioni sul nuovo duca Carlo Emanuele I, affinché non custodisse il sacro telo all'interno di una cappella palatina accessibile a pochi, ma in un luogo dove potesse essere oggetto di venerazione da parte di tutti i fedeli, progettò un altare provvisorio da collocarsi nel presbiterio del duomo, in attesa dell'avvio del cantiere per la costruzione di una grande chiesa in Piazza Castello. Tuttavia, nel 1584, con la dipartita di Borromeo, il Pellegrini, sentendosi sollevato dai propri oneri nei confronti del duca, non diede più notizie di sé a Torino. Fu così che il Santissimo Sudario venne posto all'apice di un apparato effimero collocato un poco innanzi all'altare maestro della cattedrale, descritto dalle fonti come un'edicola sorretta da quattro colonne in legno tinte d'azzurro ed ornata con angeli dorati che sostenevano un baldacchino. Quella che doveva costituire una soluzione provvisoria, a ragione delle continue lotte intestine scatenate dal forte accentramento dei poteri voluto da Emanuele Filiberto prima, e proseguito dal figlio poi, divenne stabile per i successivi ottantatré anni. Si rese perciò necessario sostituire la scenografia lignea con un imponente altare aulico caratterizzato da un basamento lapideo, quattro mastodontiche colonne in marmo nero di Frabosa (poi riutilizzate per ornare uno dei due portali d'accesso all'attuale cappella) ed un'elaborata struttura lignea apicale.
La Cappella della Sacra Sindone: l'Ellissoide di Vitozzi e Castellamonte padre
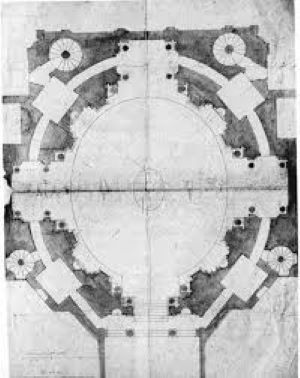
Risoluto a rispettare le ultime volontà paterne, Carlo Emanuele I si rivolse all'ingegnere ducale Ascanio Vitozzi (o Vittozzi) e al suo collaboratore, Carlo Cognengo di Castellamonte, i quali, accantonati i progetti del loro predecessore, tra il 1610 e il 1611 iniziarono a valutare la realizzazione di una cappella a pianta ellittica incastonata tra il Palazzo Ducale e il duomo, accessibile tramite un vano di collegamento ricavato nel coro. Con chiare implicazioni simboliche, l'ambiente fu pensato perfettamente in asse con la dimora di rappresentanza del reggente e rialzato rispetto a San Giovanni. Questo espediente architettonico rimarcava anzitutto la dicotomia tra le due sedi del potere spirituale e temporale, ribadiva il fatto che si era difronte ad una committenza squisitamente ducale e non religiosa e, non in ultimo, costituiva una forte dichiarazione propagandistica atta a dimostrare che la casata aveva la piena approvazione divina in quanto custode della (presunta) prova tangibile della risurrezione di Cristo. Il progetto doveva essere grandioso, non soltanto nell'apparato ornamentale interno, previsto in pregiatissimo marmo nero e bronzo dorato, ma anche nella struttura, che doveva sconfinare di molto nello spazio destinato al cortile palatino. La facciata dell'oratorio sarebbe stata ricavata nell'abside tramite l'abbattimento dell'esedra semicircolare. Nel 1624 erano state soltanto gettate le fondamenta quando i lavori subirono un arresto e non progredirono né nel corso della breve amministrazione di Vittorio Amedeo I, né durante i turbolenti anni di reggenza della sua vedova, la Madama Reale Maria Cristina di Borbone-Francia.
Un nuovo progetto: Quadri e Castellamonte figlio
Si dovette attendere la piena assunzione del potere da parte del loro erede, Carlo Emanuele II, per lo sblocco del cantiere, avvenuto nel 1657 dopo le varie pressioni dello zio, il cardinale Maurizio, il quale, memore del terribile incendio scoppiato il 4 dicembre del 1532 all'interno della Sainte-Chapelle di Chambéry, che causò danni irreparabili alla reliquia, aveva espresso il proprio legittimo timore di continuare a custodirla sopra un altare incessantemente illuminato da lanterne che, nella sua parte apicale - dove era collocato lo scrigno del sacro lino - era interamente in legno. La direzione della fabbrica venne affidata al ticinese Bernardino Quadri, più abile come scultore e stuccatore che come architetto, e perciò sottoposto alla supervisione dell'ingegnere ducale Amedeo Cognengo di Castellamonte, figlio del già citato Carlo di Castellamonte. Ritenendo ormai superata la pianta ellissoidale, i due optarono per un'aula liturgica a pianta circolare rialzata di parecchi metri (è bene ricordare che nel precedente progetto si parlava di una sopraelevazione di 1 o 2 metri, qui si trattava invece di ben 6-7 metri) rispetto al piano di calpestio di San Giovanni, che fosse contenuta all'interno di uno spazio quadrato nella manica ovest del Palazzo Ducale. Il notevole innalzamento della cappella rispetto al duomo avrebbe permesso una vista privilegiata sull'altare-reliquiario anche dall'interno della basilica al piano inferiore, grazie ad un monumentale finestrone ricavato nel coro con l'abbattimento dell'abside. I fedeli potevano avere accesso all'oratorio tramite due scaloni introdotti da enormi portali in marmo nero posti in fondo alle navate minori, uno per salire e l'altro per scendere, perfetti per evitare resse e assembramenti in caso di grandi afflussi di pellegrini; i Savoia, invece, potevano accedere all'ambiente sacro per mezzo di un portale posizionato al primo piano del loro palazzo. In ossequio alle richieste di Carlo Emanuele II, i progettisti pensarono ad una cupola che per altezza, imponenza e bellezza doveva superare quella più spartana della cattedrale rinascimentale. Dopo la demolizione delle fondamenta dell'ellissoide, i lavori di edificazione procedettero spediti nei nove anni successivi fin quando, arrivati alla trabeazione del primo livello, ci si rese conto che la struttura aveva delle forti criticità statiche. Non essendo in grado di porre rimedio a queste, Quadri fu sollevato dall'incarico nel 1666. Proprio in quest'anno le ricevute di pagamento documentano l'ultima retribuzione dovuta all'autore del progetto fallimentare. A lui subentrò, nel 1668, il padre teatino modenese Guarino Guarini, giunto a Torino due anni prima, su invito del suo ordine, per portare a termine la Real Chiesa di San Lorenzo.
All'improvviso, il genio

Visto lo stato estremamente avanzato in cui versavano i lavori, Guarini non poté fare altro che mantenere l'assetto planimetrico del fabbricato, di cui però stravolse completamente il linguaggio. Prima di tutto si occupò di rafforzare e reintegrare la fragile struttura ideata dal predecessore, e riplasmò radicalmente lo scalone di destra, che risultava già ultimato. Per le lesene di ispirazione corinzia, questi pensò ad una nuova interpretazione simbolico figurativa legata alla Passione di Cristo del tradizionale capitello ornato con foglie d'acanto e volute, inserendo al loro posto elementi dalla forte carica allusiva, quali i rami d'ulivo (che rimandano all'agonia di Cristo nell'Orto del Getsemani), una corona di spine e un fiore di passiflora da cui emergono tre chiodi e il Titulus Crucis (il cartiglio con la motivazione della condanna di Cristo, appeso all'altezza del suo capo durante la crocifissione). Riprendendo i pennacchi della croce greca prevista dal progetto di Quadri, li ridusse da quattro a tre, inscrivendo all'interno della pianta circolare un triangolo, nei vertici del quale collocò dei vestiboli circolari, uno in corrispondenza dell'ingresso da Palazzo Ducale e gli altri due a conclusione degli scaloni monumentali. In luogo dei piedritti che avrebbero dovuto sostenere la basica cupola emisferica voluta da Castellamonte, andò a posizionare dei grandi fastigi ornamentali, sui quali svettano delle valve di conchiglia. Oltre il primo ordine, l'architetto dimostrò immediatamente di volersi distaccare, nella maniera più netta possibile, dai progetti a lui antecedenti, impostando una vertiginosa struttura a torre che andasse ad evocare nell'osservatore l'idea di un'ascesa vorticosa verso l'Infinito. Nel bacino tronco, al fine di snellire il più possibile il peso del costruito, aggiunse tre poderosi arconi, mentre nei pennacchi e nelle lunette aprì sei finestroni circolari, dai quali i raggi solari filtrano attenuati da apposite camere di luce, create per assolvere al duplice compito di direzionare i fasci luminosi in modo indiretto e soffuso sulle superfici lapidee interne, e di celare alla vista i contrafforti e i tiranti di rinfianco. L'adozione di questa serie di accorgimenti gli permise di ridurre di 1/4 l'ampiezza del diametro di imposta del tamburo, e gli consentì di dare piena soddisfazione alla richiesta ducale dell'edificazione di una cupola che fosse maggiore in altezza di quella del duomo. Abbondanti sono gli elementi simbolici, frutto di una mente erudita e raffinata: nelle ghiere dei tre grandi archi, i chiodi alternati a foglie d'ulivo stilizzate alludono alle sofferenze fisiche e spirituali di Gesù Cristo; nei tre pennacchi le croci greche e ierosolimitane rimandano al mistero dell'Umana Redenzione e allo stemma di Casa Savoia; nei lunettoni, infine, gli esagoni e le stelle a sei punte simboleggiano la Creazione e l'Empireo, il più alto dei nove cieli. Salendo nel tamburo, al livello successivo, Guarini alleggerì ulteriormente la struttura introducendo un camminamento anulare interno e sei enormi finestroni ad arco, dai quali la luce penetra in quantità evocando suggestivi effetti teatrali. Lo spazio tra un finestrone e l'altro venne ricolmato dal posizionamento di sei nicchie a tabernacolo. Nei pennacchi della cupola, la presenza della figura geometrica del pentagono assume ancora una volta una valenza simbolica: rievoca infatti le cinque piaghe, ovvero le ferite delle mani, dei piedi e del costato inferte al Nazareno durante il supplizio della crocifissione.
Una cupola per la Cappella della Sacra Sindone

Perfetto connubio tra razionalismo e misticismo matematico, la cupola, o meglio, la pseudocupola della Cappella della Sacra Sindone si configura come una delle architetture più ardite e complesse dell'intera stagione barocca europea. Grazie allo studio sulle tecniche costruttive del gotico francese e delle strabilianti architetture stereotomiche del mondo islamico, Guarini pose in essere una struttura a scheletro, portante e ornamentale al tempo stesso, formata da una fitta rete di "cellule spaziali indipendenti" (Gianfranco Gritella - "Il Contributo italiano alla storia del Pensiero" - Tecnica, 2013) che si intersecano e ruotano attorno ad un unico fulcro che ha per base un poligono regolare, l'esagono, simbolo biblico della Creazione (svoltasi, secondo la Genesi, in sei giorni). In questo progetto trova la sua piena esemplificazione la concezione guariniana - mutuata in parte dal Borromini - di architettura, vista come un organismo vivo e pulsante, in perenne movimento, generato dall'incontro di spazi indipendenti e di forme pure che, concatenandosi, si influenzano reciprocamente dando vita alla struttura. Quella dimensione unificata ed armoniosa dei vari elementi architettonici autonomi che caratterizza le creazioni di Borromini è totalmente assente in Guarini, che anzi, provava gusto nel proporre soluzioni eterogenee e bruschi mutamenti di forma privi di qualsiasi elemento di transizione.

Per realizzare il cestello della pseudocupola diafana, l'architetto giustappose sei livelli di sei piccoli archi a sesto ribassato digradanti verso l'alto, che in pianta corrispondono ad altrettanti sei ordini di esagoni che via via si restringono posando gli angoli degli uni sui lati degli altri. Questo moto continuo trova il suo apice nella stella-sole a dodici punte minori e dodici raggi maggiori, posta a conclusione del climax ascendente dei multipli di tre che si snoda lungo tutto l'impianto della cappella. Al centro del cupolino-lanterna, che appare inondato di luce grazie a dodici finestrelle ovoidali molto ravvicinate fra loro, si libra in volo la colomba dello Spirito Santo pendente da una complessa raggiera a base cilindrica, costituita da 240 bacchette in legno d'abete dorato a foglia di diverse dimensioni, poste in gruppi da 7 o da 12 su tre piani sovrapposti e con inclinazioni differenti. Fa da sfondo a questa geniale macchina scenografica un cielo tempestoso, grigio, quasi monocromatico, popolato da sei coppie di cherubini, che fu affrescato nel 1680 da Carlo Giuseppe Cortella.

Benché dall'esterno la cupola non appaia particolarmente alta, dall'interno il visitatore avrà l'impressione che questa sia molto più estesa di quello che effettivamente è. Questo avviene perché Guarini studiò accuratamente un gioco prospettico al fine di donare un'altezza fallace alla propria creatura, e per fare ciò tenne conto di tre importanti fattori:
- la geometria: diminuendo l'ampiezza degli archetti depressi al crescere dell'altezza l'architetto mise a punto una struttura "a cannocchiale";
- la luce: più la fonte luminosa è intensa meno l'occhio umano avrà la capacità di distinguere i contorni dell'oggetto illuminato, il quale verrà percepito più lontano. Proprio per questo Guarini fece in modo che la luce filtrasse abbondantemente dalle svariate aperture del tamburo e della cupola e che divenisse sempre più rarefatta scendendo verso il basso. Con lo scopo di catturare più luce possibile, i marmi dell'intradosso non vennero rifiniti con la lucidatura ma soltanto levigati;
- il colore: in piena adesione ai canoni della prospettiva aerea di leonardesca memoria, secondo cui un colore appare più scuro quando è vicino mentre diviene più chiaro man mano che ci si allontana, nelle due scalinate e alla base dell'aula cultuale fu impiegato largamente il marmo nero di Frabosa, dal bacino tronco in poi si adoperò il marmo bigio.
In assenza della calotta emisferica, tradizionale simbolo della dimensione celeste dove la divinità ha la propria sede, sono gli stessi raggi del sole che trafiggono in ogni dove la cupola a simboleggiare la manifestazione del divino. Questo era molto più evidente in origine, quando il fedele veniva invitato a percorrere una delle due scalinate ripide e anguste, incupite dal marmo nero e formate da trentatré gradini ciascuna (uno per ogni anno della vita terrena di Gesù Cristo), al termine delle quali era ubicato un vestibolo circolare, aggiunto allo scopo di incutere un senso di inquietudine e vago mistero. Più avanti, la penombra, accentuata ulteriormente dal materiale lapideo scurissimo che riveste tutto il primo ordine della cappella, risultava gradualmente attenuata da una luce sempre meno fioca, fino a che lo sguardo non veniva inaspettatamente rapito dalla sbalorditiva visione estatica della cupola. Questo percorso ascensionale era densissimo di significato: tutti coloro che intendevano accostarsi a venerare la Sacra Sindone, difatti, dovevano prima ripercorrere il cammino tortuoso della Via Dolorosa per mezzo della gradinata scoscesa, attraversare le tenebre della morte e del peccato simboleggiate dal nero dei marmi, ed infine rigenerarsi nella teatralissima visione della luce filtrante dal cestello guariniano. In breve, entrare nella Cappella della Sacra Sindone significava rivivere spiritualmente i misteri pasquali della Passione, morte e resurrezione del Redentore attraverso un articolato sistema di simbologie.
Il bizzarro estradosso della cupola si palesa con una foggia piuttosto orientaleggiante, tanto da assomigliare più ad una pagoda che alla copertura di una chiesa. Le sei serliane del tamburo in laterizio donano alla struttura un caratteristico profilo sinusoidale. I candidi capitelli delle lesene di ispirazione corinzia presentano un motivo ornamentale formato da petali di iris. Nel livello successivo i dodici costoloni sono coronati da urne. In alto, il pinnacolo, ispirato alla lanterna del Sant'Ivo alla Sapienza borrominiano, è puntellato da numerose finestrelle ovoidali vere alla base e fittizie sopra, che si diradano in numero e in ampiezza man mano che si avvicinano all'apice. Sulla sommità svetta un globo dorato sovrastato da una croce, tre chiodi, una corona di spine e uno stendardo con lo stemma sabaudo, forgiato nel 1683 dal serragliere Pietro Tarino.
L'altare-reliquiario
Il 15 maggio del 1680 i lavori non erano del tutto terminati quando, con una Messa solenne officiata su un altare ligneo provvisorio, Guarini stesso (divenuto nel frattempo predicatore e teologo del Principe di Carignano) consacrava al culto divino la Cappella della Sacra Sindone, e da questo si evince che all'epoca fosse già agibile. Tre anni dopo, un 6 di marzo, il padre teatino si spegneva, lasciando incompiuti i pavimenti, una scalinata e, soprattutto, l'altare-reliquiario che avrebbe dovuto custodire il Santo Sudario. Come suo successore alla direzione dei cantieri fu nominato, nel 1685, il grande matematico livornese Donato Rossetti (che in passato si era platealmente scontrato con un fraterno amico di Guarini, Montanari, riservando critiche asperrime anche nei confronti dei progetti dell'architetto) giunto a Torino nel 1674 e prescelto, appena un anno dopo, come professore di Scienze Matematiche presso l'Accademia di Piemonte, nonché come precettore del futuro re di Sicilia Vittorio Amedeo II. L'esperienza di Rossetti all'interno del cantiere fu brevissima, passò infatti a miglior vita nel 1686. Lo sostituì un suo allievo degli anni piemontesi, il muzzanese Antonio Bertola (illustre predecessore di Filippo Juvarra e primo in assoluto ad essere fregiato con il titolo di "Primo Architetto di S. A. S."), che si occupò di portare a compimento le parti lacunose e di realizzare il disegno della scintillante custodia della Sindone.

Tenendo conto della forma circolare dell'aula, Bertola realizzò al centro geometrico della stessa un altare bifronte a due mense - una rivolta verso la Cattedrale di San Giovanni Battista l'altra verso Palazzo Ducale - che risultava rialzato dal piano di calpestio per mezzo di sei scalini. La sua centralità era sottolineata dal complesso disegno del pavimento realizzato ad intarsio, composto da cerchi concentrici tempestati da una miriade di stelle in ottone dorato posizionate a loro volta entro croci greche in marmo bigio, che convergendo verso il centro, si restringevano sempre di più. Il corpo dell'altare fu realizzato in marmo nero ed arricchito da inserti, ornamenti e sculture in legno o metallo dorato, affinché questo, illuminato dalle quattro lanterne pendenti dal fastigio, risplendesse nella penombra del primo livello della cappella. Nella parte centrale, in una teca di cristallo, oltre una grata in ferro dorato, era custodito il prezioso scrigno cinquecentesco in argento e pietre dure contenente la Sindone. Sopra la balaustra erano posizionati otto putti lignei in atteggiamento orante o con espressione affranta, alcuni dei quali recanti i chiodi della crocifissione; ai lati della teca, invece, si trovavano quattro angeli con i simboli della Passione, tutti scolpiti tra 1692 e 1694 dai mastri intagliatori Cesare Neurone e Francesco Borello, cui vanno ascritti anche i simmetrici puttini reggi- lanterna e la splendida raggiera con cherubini e angeli adoranti sul fastigio. Nel 1694, finalmente, si poté mettere la parola fine sull'ormai centenario cantiere della Cappella della Sacra Sindone con la collocazione della reliquia all'interno del suo fulgido altare.
Altri interventi
Nel 1825 il re Carlo Felice, ultimo esponente del ramo principale dei Savoia, diede l'incarico al Regio Primo Architetto Carlo Randoni di realizzare in corrispondenza della monumentale balconata ad arco sghembo di affaccio sul duomo il Grande Chiassilone, un finestrone vetrato in legno di noce e ferro d'Aosta alto circa 12 metri, avente la funzione di isolare la cappella dal freddo, dalle correnti d'aria e dai rumori provenienti dalla Cattedrale al piano inferiore. Il successore di Carlo Felice, Carlo Alberto, primo re appartenente al ramo collaterale dei Savoia-Carignano, volle trasformare la Cappella della sacra Sindone in una sorta di mausoleo della propria dinastia, commissionando quattro monumenti funebri marmorei in stile neoclassico dedicati ad alcuni dei più illustri esponenti della casata, i cui resti furono riesumati per essere tumulati all'interno delle nuove sepolture.
Il carrarese Benedetto Cacciatori eseguì il sepolcro di Amedeo VIII, primo duca di Savoia, promulgatore degli Statuta Sabaudiae (1430) e papa scismatico sotto il nome di Felice V; Innocenzo Fraccaroli scolpì invece il monumento a Carlo Emanuele II, colui che aveva riaperto i cantieri della cappella affidando l'incarico della direzione di questi prima a Bernardino Quadri e poi a Guarino Guarini; il genovese Giuseppe Gaggini si occupò del gruppo dedicato al Principe Tommaso, capostipite del ramo cadetto dei Savoia-Carignano; ed infine, il lombardo Pompeo Marchesi lavorò al monumento sepolcrale di Emanuele Filiberto il "Testa di Ferro", valoroso e caparbio condottiero che spostò la capitale del ducato sabaudo da Chambéry a Torino (1563), fece traslare la Sindone nella nuova capitale (1578) e fu il primo a volere l'edificazione di un luogo di culto adatto a custodire in maniera più che decorosa la sacra reliquia.
Sempre nel corso degli interventi ottocenteschi, alle estremità della balaustra dell'altare furono aggiunti a quelli barocchi altri due angeli oranti in marmo bianco.
L'incendio e il restauro

Il 4 maggio del 1990, proprio nel giorno che il calendario liturgico dedica alla festa del Santissimo Sudario, delle infiltrazioni d'acqua portarono al distacco di un frammento marmoreo dal cornicione della cupola, che cadde rovinosamente sulla pavimentazione danneggiandola. Fortunatamente non ci furono vittime o feriti. L'accesso ai fedeli venne interdetto tempestivamente e tre anni dopo partirono i lavori di restauro. Proprio quando quegli interventi di conservazione si stavano avviando verso la conclusione, nella notte fra l'11 e il 12 aprile del 1997, a causa di un cortocircuito presero fuoco le tavole di legno dei ponteggi in fase di smontaggio e, in poco tempo, all'interno della struttura divampò un terribile incendio che creò cedimenti strutturali e crolli. Gli ingenti danni generati dalla furia devastatrice delle fiamme furono paradossalmente corroborati dalle operazioni di spegnimento: i potenti getti d'acqua gelida, riversandosi sui marmi incandescenti, diedero origine ad uno shock termico che fu cagione di alcune gravi alterazioni dei materiali lapidei. Si registrarono difatti fratturazioni, rigonfiamenti, esfoliazioni e distacchi. Alla sola leggera pressione della mano i marmi si disgregavano. Per scongiurare il collasso, l'edificio venne immediatamente messo in sicurezza con il posizionamento di cerchiature e catene metalliche provvisorie. Si aprì un lungo e complesso "cantiere della conoscenza" per approfondire le tecniche costruttive impiegate da Guarini (mai indagate prima di allora), indispensabile vista l'assenza dei disegni originali dell'architetto e la lacunosità dei documenti d'archivio.
Al termine dei dovuti studi preliminari, nei primi anni 2000, dopo la rimozione dei detriti, la constatazione dei danni (l'80% delle superfici in pietra era da ripristinare) e il monitoraggio della stabilità, si entrava nel vivo del ripristino architettonico, atto a restituire al monumento la stabilità e la propria immagine. Si è scelto di perseguire una linea di approccio al restauro rigidamente conservatrice, pertanto, al fine di mantenere quanta più materia lapidea originaria possibile, gli elementi marmorei sono stati sostituiti solo se irreversibilmente compromessi. Per reperire il marmo funzionale alle reintegrazioni, nel 2007 sono state riaperte le cave - quasi del tutto esaurite già nel Seicento - di marmo nero e bigio di Frabosa Soprana, nel cuneese. Le quantità materiche (27 blocchi in tutto) ricavate da queste si sono rivelate insufficienti per coprire l'intero fabbisogno del cantiere, perciò è stato necessario optare per l'utilizzo anche di altre varietà esteticamente simili a quelle impiegate in antico: un marmo nero proveniente dalle Alpi Orobie e uno grigio dalle Alpi Apuane. Dove non è stato possibile ricomporre ed assemblare i frammenti originali, con l'ausilio della modellazione 3D sono state ricostruite le porzioni mancanti. Per consolidarla strutturalmente e ridonare alla pietra di cui è costituita valore portante, la cupola è stata sottoposta ad una delicata operazione di smontaggio e rimontaggio integrale, sospendendo la struttura temporaneamente al di sopra di impalcati per sostituire gli elementi danneggiati. Sono stati inoltre rifatti i tetti e le coperture in piombo, cambiate le catene e le cerchiature metalliche, posizionati nuovi serramenti. Si è poi provveduto al risanamento della lesione formatasi all'altezza del tamburo. Gli interventi di pulitura del cupolino hanno restituito nuova luce alle pitture del Cortella, la cui lettura risultava negata da una scialbatura postuma color ocra. Infine, il Chiassilone e la raggiera con la colomba dello Spirito Santo, andati distrutti durante l'incendio, sono stati ricostruiti in maniera filologica.
Dopo 28 anni di chiusura al pubblico e a 21 anni dall'incendio, la Cappella della Sacra Sindone è stata restituita alla città di Torino e alla collettività il 28 settembre 2018. Persa la propria originaria funzione di custodire il Santissimo Sudario (ora conservato in condizioni particolari all'interno di una teca collocata sotto la Tribuna Reale del duomo, presso il transetto sinistro) è stata inserita all'interno del percorso dei Musei Reali. Con la musealizzazione l'accesso dalla cattedrale è stato interdetto.
Il restauro, uno dei più complicati che siano mai stati realizzati, è risultato tra i vincitori degli European Heritage Awards 2019 per la categoria Conservazione. Il suo costo, ammontato a circa 30 milioni di euro, è stato finanziato grazie al contributo di diversi enti:
- Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo: 28 milioni;
- Compagnia di San Paolo: 2,7 milioni;
- Fondazione Specchio dei Tempi di "La Stampa": 645.000 euro;
- Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali: 150.000 euro;
- Iren – Performance in Lighiting: 125.000 euro.
Bibliografia
Maurizio Momo, Il Duomo di Torino, trasformazioni e restauri, Ed. Celid, Torino 1997;
Giuseppe Dardanello, Guarino Guarini, Allemandi, Torino 2006;
Carlotta Venegoni, Il Duomo di Torino: Fede, arte e storia. La Santa Sindone, Effatà Editrice, Torino 2015;
Luca Caneparo, Fabbricazione digitale dell'architettura. Il divenire della cultura tecnologica
del progettare e del costruire, Francoangeli s.r.l., Milano 2012;
Gian Maria Zacconi, La Sindone, una storia nella storia, Effatà Editrice, Torino 2015;
Sitografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-architettura-barocca-e-le-nuove-sfide-delcostruire_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/guarinoguarini_res-5b9c5379-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.britannica.com/biography/Guarino-Guarini
http://www.treccani.it/enciclopedia/ascanio-vittozzi_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-quadri_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pellegrino-tibaldi/
https://webthesis.biblio.polito.it/1932/
https://issuu.com/consultaditorino/docs/pdf_pubblicazione
https://online.ucpress.edu/jsah/article/54/4/418/58810
https://www.museireali.beniculturali.it/cantierireali-il-restauro-dellaltare-della-sindone/
https://www.studioarchitetturamomo.com/copia-di-pra-d-mill-monastero
https://www.coobec.it/casi-studio/torino-cappella-della-sindone-monumenti-funebri-ai-redanneggiati-da-incendio/
https://www.museireali.beniculturali.it/cappella-della-sindone-le-fasi-finali-del-restauro/
https://www.consultaditorino.it/realizzazioni/restauro-cupolino/
https://www.artwave.it/architettura/buildings/cappella-della-sindone-di-torino-28-annidopo/
https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/10/04/la-cappella-della-sindone-comenon-lavete-mai-vista/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_408994977.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1009566566.html
https://www.finestresullarte.info/flash-news/5095n_premiazione-parigi-restauro-cappellasindone.php
LE CAPPELLE LATERALI DEL DUOMO DI SAVONA
A cura di Fabio D'Ovidio
Introduzione
Dopo aver trattato diffusamente delle vicende relative alla costruzione del Duomo di Savona in un precedente articolo, passo ora ad approfondire il discorso legato alle cappelle laterali del Duomo, dense di storia e testimonianze artistiche.
La navata sinistra e le relative cappelle laterali

La prima cappella
Sopra l’altare troviamo una tela di ignoto autore del secolo XVII raffigurante San Francesco da Paola, Santo calabrese, fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416-1507), venerato in quasi tutte le località di mare per un episodio legato alla navigazione dello stretto di Messina.

Seconda cappella di sinistra (Cappella Doria)
Realizzata dal pittore genovese Bernardo Castello (1557-1629) che decorò la Cappella nei primissimi anni del XVII secolo. Sulla volta ha realizzato scene tratte dal Vangelo di Marco e Luca in cui viene narrata l’infanzia di Gesù: al centro si ha l’Adorazione dei Magi, a destra la Presentazione di Gesù al tempio e a sinistra la Circoncisione. Sull'altare è collocata la pala con l’Adorazione dei pastori.
Sulle pareti laterali della cappella il pittore ha raffigurato invece la Fuga in Egitto (in alto a destra) e il Sogno di San Giuseppe (in alto a sinistra). La volontà iconografica del ciclo è quella di introdurre il fedele/visitatore alla conoscenza di Gesù partendo proprio dai primi momenti della sua vita terrena: il suo primo incontro con la nostra Umanità.


Terza cappella di sinistra
Ospita una tela di Giovan Battista Paggi (1554-1627) raffigurante il Martirio di Sant'Orsola, realizzata tra il 1599-1600 per l’omonima compagnia. La tela ha una composizione di impianto tradizionalista, ovvero la giovane martire viene condotta al martirio insieme alle diecimila vergini.

Quarta cappella di sinistra
È dedicata alla “Madonna della colonna”. Questo ambiente svolge un ruolo e ricopre un’importanza molto particolare non solo per il duomo di Savona ma anche per tutta la cittadinanza savonese. La storia di questa Maria con il Bambino si lega, come sopra detto, al momento in cui l’attuale duomo fu costruito. Questa immagine, dipinta su una colonna della chiesa di San Francesco, scelta come cattedrale provvisoria, sarebbe dovuta scomparire all'inizio dei lavori di demolizione della chiesa francescana, ma si salvò miracolosamente, fu conservata e poi collocata nella nuova cattedrale.

Quinta cappella di sinistra
Qui si commemora l’apparizione di Maria, Madre di Misericordia, al beato Antonio Botta nella valle del Letimbro (attuale località Santuario) il 18 marzo 1536. Il tema è dunque la Misericordia. Di supporto alla statua marmorea sono i due affreschi dipinti lungo le pareti. Uno di essi raffigura l’incontro di Gesù con i bambini mentre i suoi discepoli vogliono allontanarli: è dolcissimo qui l’atteggiamento di Gesù, raffigurato mentre esprime un affetto tenerissimo per i bambini. L’altro, a sinistra, raffigura Gesù nell'atto di perdonare la donna adultera: qui invece emerge la rappresentazione della potenza, pacata e definitiva, della Misericordia divina.

Sesta cappella di sinistra
Dedicata a Santo Stefano. È la cappella del Santissimo Sacramento, il luogo privilegiato per la preghiera intima. La pala collocata sull'altare raffigura il martirio di questo santo ad opera del pittore locale di linguaggio neoclassico Paolo Gerolamo Brusco, mentre al di sotto è presente la grata in cui si conservano le spoglie del beato Ottaviano, vescovo della città tra il 1123-1133, la cui causa di canonizzazione viene portata aventi dal vescovo Spinola durante il concilio di Trento.

La navata di destra e le relative cappelle laterali

Prima cappella
È interamente dedicata alla Vergine, sull'altare troviamo una tela dipinta a tempera raffigurante Nostra Signora di Misericordia di Agostino Ratti (1699-1775): propone l’apparizione al contadino Antonio Botta, il 18 Marzo 1536. Sulle pareti laterali alcuni affreschi riproducono due miracoli mariani e sulla volta un terzo dedicato alla Gloria della Vergine. Nel contesto mariano di questa cappella merita particolare attenzione la statua marmorea raffigurante la Carità: attorno ad una giovane donna si stringono tre bambini, dei quali uno viene allattato al suo seno.

Seconda cappella
Presenta gli affreschi di Agostino Ratti eseguiti nella metà del XVIII secolo. Sulla pareti laterali sono raffigurate la Visitazione e il Riposo durante la fuga in Egitto: due momenti della storia sacra che vedono Maria protagonista. Un altro elemento artistico mariano da notare è il rilievo dorato su ardesia raffigurante la Madonna col Bambino: è una delle chiavi di volta dell’antica cattedrale che sorgeva sul Priamar. Di Paolo Gerolamo Brusco è il Sacro Cuore collocato sull'altare marmoreo decorato da tarsie. Fiancheggiano l’altare due statue: una raffigura il re e profeta Davide (riconoscibile per la corona e l’arpa), l’altra il profeta Isaia con un cartiglio la cui scritta recita: Ecce Virgo, le parole iniziali della sua profezia sulla nascita del Cristo.

Terza cappella (cappella Gavotti)
Nota anche con il nome di cappella Gavotti, presenta nuovamente una serie di temi mariani. Sull'altare, la Madonna degli Angeli, di Giovanni Baglione (1566-1643, pittore romano e biografo di artisti), in cui la Vergine è raffigurata attraverso i caratteri iconografici dell’Immacolata: la testa coronata di stelle, venerata dagli Angeli, Maria Regina Angelorum, una interpretazione pittorica, che ritrae la Madre di Cristo coi capelli scomposti e sciolti al vento. Sulla parete di destra, il Sogno di Giacobbe, dello stesso autore, mentre su quella di sinistra, Abramo visitato dagli Angeli, di Giovanni Lanfranco (1582-1647). Sulla volta, affreschi di Flaminio Allegrini al centro l’Arcangelo Michele che sconfigge Satana, dalla fisionomia draconiana.

Quarta cappella
Intitolata a Sant'Agostino, conserva altre opere di Paolo Gerolamo Brusco. Sulla volta, l’affresco raffigurante la Gloria di Sant’Agostino e le due tele sulle pareti laterali con i Santi Pietro e Paolo. Sopra l’altare, una pregevole pala, opera di Giovanni Baglione (1575-1664), raffigurante Sant'Agostino, al centro della tela, in alto, l’Incoronazione della Vergine ad opera della Trinità; in basso, in primo piano, Sant'Agostino che regge con la sinistra il libro, mentre con la destra indica il Mistero rappresentato al di sopra, a sinistra, le insegne che lo identificano come vescovo: il pastorale a terra, e la mitra, retta da un putto.

Quinta cappella
Nota comunemente con il nome di Cappella delle Anime, è dedicata al trionfo della vita sulla morte. Appare il crocifisso e un cartiglio con la seguente scritta: “Salus populi ego sum”. Sulle pareti laterali campeggiano due grandi affreschi di Quarenghi: la Risurrezione del figlio della vedova di Nain e la Sepoltura di Mosé raffigurato, come addormentato, mentre viene portato in Cielo da una ricca scorta di angeli. Il monumentale altare marmoreo, altare dei morti, realizzato nel corso del Seicento da A. Luciani, presenta alla base alcuni scheletri umani, realizzati con estrema cura e dettaglio anatomico: stupiscono le loro pose plastiche e molto dinamiche. A supporto di questa visione di vita post mortem corporale vi è la citazione biblica collocata al centro del paliotto, in un medaglione affiancato a due scheletri. Questo tema trova il suo sviluppo dottrinale nel Purgatorio: ricorrenti dopo la Controriforma le anime purganti sulle pale d’altare. Proprio questa iconografia viene recuperata nel rilievo marmoreo posto sul timpano curvilineo dell’ancona, che è spezzato da un’ampia raggiera con una corona di angeli intorno, al cui centro si trova il simbolo della SS. Trinità. Sugli estradossi del timpano si ergono due grandi statue: la Fede (con il calice) e la Speranza (con l’ancora) per sostenere il cammino del credente.

Sesta cappella
L’ultima cappella di destra, dedicata a San Sisto, conserva in un’urna cineraria quelle che – secondo la tradizione – sono le reliquie del Papa e martire, vissuto nel II secolo d.C. Sulla volta è raffigurato il suo martirio. L’altare (XVII-XVIII sec.) è dominato da una notevole tavola cinquecentesca raffigurante la Madonna in trono tra i Santi Pietro e Paolo (o Luca). Se Pietro è riconoscibile per la tradizionale fisionomia, l’altro non ha segni distintivi particolari, ad esempio non ha la spada, abitualmente l’attributo del martirio di San Paolo. Sulla parete di destra, un rilievo in marmo raffigurante la Presentazione di Maria al tempio.
NdA: le fonti per quest'articolo sono state desunte da appunti di liceo ed università, descrizioni in loco o fotografie.
LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA DI ANAGNI
A cura di Vanessa Viti
La Cattedrale di Santa Maria si trova ad Anagni, comune della regione Lazio denominato "Città dei Papi" poiché diede i natali a quattro pontefici: Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX, Bonifacio VIII, inoltre per lungo tempo è stata sede papale. La cittadina di Anagni è altresì famosa per il celebre "schiaffo di Anagni", episodio avvenuto l'8 settembre del 1303 ai danni del papa Bonifacio VIII, un oltraggio morale più che un vero e proprio schiaffo
La Cattedrale di Anagni: esterno
I lavori di costruzione iniziarono intorno al 1072 e terminarono nel 1104 circa, la chiese venne eretta per volere del Vescovo Pietro da Salerno. La mole dell'edificio domina con la sua presenza la cittadina dall'alto del colle su cui è stata costruita. Esternamente possiede le caratteristiche dello stile romanico emiliano-lombardo. La possente facciata in pietra tartara si erge maestosamente sul sagrato insieme al poderoso campanile con aperture a monofore, bifore e trifore che svetta arrivando 30 metri di altezza. A sud-ovest la cattedrale è di grande impatto visivo e troneggia piazza Innocenzo III con la Loggia delle Benedizioni, l’esterno della Cappella Caetani e la scenografica scalinata che curva dietro le absidi. Un numero molto limitato di aperture ed una serie di archetti in pietra bianca sono gli unici elementi architettonici che ne alleggeriscono la struttura. Più movimentati sono i cilindri absidali scanditi da lesene unite tra loro da coppie di archetti. L'abside maggiore è coronato da una loggetta la cui decorazione marmorea risalta sul colore ocra del paramento murario. Una serie di colonne eterogenee sorreggono gli archetti pensili che in maniera alternata si appoggiano su delle mensole figurate. Il cilindro dell'abside maggiore è aperto da un'unica monofora con archivolto a doppio rincasso e con colonnine laterali. Dal fianco destro della chiesa si intravede un'alta cappella laterale ed una terrazza sostenuta da una loggia su arcate, al di sopra della terrazza sporge un'edicola contenente la statua di Bonifacio VIII. Le volte inferiori della loggia si intersecano con una sequenza di archetti pensili risalenti a costruzioni precedenti, i cui peducci appaiono rozzamente scolpiti. Queste teste di lupo, leone, montone rappresentano uno dei pochi esempi di scultura figurata che si può trovare nell'edificio. La facciata ha una struttura tripartita con tre portali di tipo campano. Le navate laterali sono illuminate da due semplici monofore, altre finestre uguali sono allineate nella parte superiore. Le semi-colonne addossate sono la testimonianza dell'esistenza di un portico probabilmente mai costruito. Il portale ha un archivolto con la ghiera esterna sporgente, due stretti capitelli poggiano su un'architrave costituita da elementi di spoglio. Interessante è l'espressione volutamente caricaturale degli animali che costituiscono l'ornamentazione del portale. Di fronte alla facciata sorge isolato il bellissimo campanile, risalente al XII secolo, di stile lombardo la cui base è aperta sui quattro lati da alte arcate a tutto sesto.
La Cattedrale di Anagni: interno
All'interno i caratteri romanici, come l’alternanza di pilastri e colonne di separazione tra le navate, incontrano elementi architettonici tipicamente gotici frutto dei restauri commissionati dai vescovi Alberto e Pandolfo che si conclusero nel 1250: costoro fecero sostituire le capriate in legno della navata centrale con archi a sesto acuto a sostegno del nuovo tetto e fecero realizzare la nuova copertura a volte ogivali costolonate su pilastri a fascio nel transetto. Gli archi della navata centrale furono decorati con immagini di pavoni e draghi. Le navate conservano il pavimento eseguito da Cosma tra il 1224 ed il 1227. Nella navata il percorso verso l'altare è definito da una serie continua di figure circolari unite da nastri. La zona presbiteriale, rialzata su un basso gradino, è decorata da due serie di tre dischi allineati separati da una composizione in cui il cerchio centrale è racchiuso da un quadrato. Ai lati del percorso centrale si allineano elementi di forma rettangolare, i "tappeti di preghiera", che nelle navate laterali sono intercalati dagli elementi circolari. Nel presbiterio si conservano gli arredi che furono eseguiti intorno al 1250. Lo spazio sacro è isolato da transenne marmoree con intarsi cosmateschi. All'interno di una struttura marmorea trovano spazio riquadri in marmi pregiati bordati con tarsie eseguite con paste vitree, pietre e lamine d'oro. Sull'altare si trova il ciborio, di tipo romano con multiple loggette su colonnine sovrapposte, alla bottega del Vassalletto possono essere attribuite il candelabro pasquale e la sede vescovile. Il candelabro consta di una colonna tortile ricoperta con tarsie, che poggia su una base sorretta da sfingi e da un telamone che sorregge il basamento del cero. Sulla sinistra della navata si apre la cappella Cajetani, costruita alla fine del XIII secolo per ospitare i resti di autorevoli membri della famiglia cui apparteneva Bonifacio VIII. Si tratta di una struttura cuspidata su colonnine e pinnacoli che ricopre due sarcofaghi decorati con lo stemma dei Cajetani e con altri disegni cosmateschi.
Pochi sono i resti di pittura medievale superstiti nella basilica: una Vergine con il Bambino affiancata da san Magno e santa Secondina nella lunetta sopra il portale maggiore appartenente al XIV secolo, una Vergine con il Bambino e la testa di san Pietro sul pilastro sinistro vicino al presbiterio risalente a circa metà del XIII secolo e una Madonna in trono col Bambino tra santa Caterina d’Alessandria e sant'Antonio abate all'esterno, dietro una grata sul muro sinistro dei primi anni del XV secolo. Di epoca moderna sono invece le pitture presenti nelle tre absidi: nelle due laterali, a sinistra troviamo la Cena in Emmaus, a destra la Morte di San Giuseppe. Nel XIX secolo i pittori Pietro e Giovanni Gagliardi realizzarono le opere pittoriche presenti all'interno della chiesa, sempre a loro sono attribuiti i lavori pittorici che si trovano nella calotta dell’abside maggiore: l’Annunciazione e i Santi venerati dalla Chiesa anagnina. I Santi Apostoli con san Giovanni Battista su fondo scuro nell’emiciclo absidale è stato invece realizzato nel 1837 (tecnica dell’olio su muro).
Sitografia
https://www.cattedraledianagni.it/cattedrale
Bibliografia
La Cattedrale di Anagni-I Edizione-Orvieto.
LA CRIPTA DELLA BASILICA DI SAN NICOLA A BARI
A cura di Rossana Vitale
Una seconda chiesa: la cripta di san Nicola
Nella grande fabbrica basilicale di San Nicola a Bari, sotto l’intero transetto e in corrispondenza del largo presbiterio, si estende la cripta, una vera e propria seconda chiesa sotterranea, che vide i lavori per la sua edificazione concentrarsi tra il 1087 e il 1089. Tutto il progetto della basilica fu attuato per volontà dell’abate Elia, che aveva preso in consegna le reliquie del Santo all’arrivo, nel pomeriggio del 9 Maggio 1087, della spedizione di marinai che le trafugò in una chiesa a Myra.
Due anni dopo, nel 1089, lo stesso abate Elia accolse il papa Urbano II che durante il Concilio consacrò la cripta e le reliquie, che furono riposte sotto l’altare appena costruito.
Nella cripta si accede tramite due scalinate collocate nelle navate laterali della Basilica, protette da antichi plutei traforati che un tempo chiudevano l’iconostasi. Queste scalinate rappresentano un vero e proprio rito di passaggio per il visitatore: dal grande spazio austero e maestoso dell’impianto superiore si passa infatti ad una ricchezza fatta di ex voto in argento e oro, dipinti e una selva di colonne, tutta racchiusa in uno spazio alquanto serrato.

La pianta a base rettangolare - 30 mt per 14,81 mt - racchiude il ritmo di nove navate scandito da ventisei tozze e pesanti colonne che sostengono trentasei campate coperte da altrettante volte a crociera, delimitate da robusti sottarchi: due di marmo numidico, due di breccia corallina, una di marmo caristio e ventuno di marmo greco. Sulle colonne è presente una svariata serie di capitelli - di riporto, bizantini o tardo medievali, ma comunque per la maggior parte eseguiti appositamente per la cripta - che rappresentano al meglio quello che era il primo cantiere nicolaiano: un’unione di esperienze dove maestranze bizantine si fondevano con esperienze nuove, provenienti dal nord, che portavano con sé modelli nuovi o la presenza occasionale di scultori forestieri di passaggio da Bari.

I modelli e le forme tutte diverse per ogni capitello danno l’idea che vi fossero presenti due gruppi di scultori: gli uni “educati” dai bizantini e quindi abituati a lavorare secondo modelli orientali e a trattare temi paleocristiani come pavoni e cornucopie, gli altri erano anonimi portatori di esperienze diverse, meno raffinati, ma sapienti nel dare alle forme scultoree un’impronta espressiva per quel tempo senza eguali.
Si riconoscono leoni con un’unica testa in comune che occupano lo spigolo, le maschere di leonessa inquadrate tra sottili sagome di uccelli, antichi pavoni, tra pigne e grappoli, alternati a volpi che azzannano lepri, e grifi che artigliano pantere.
Alcuni dei temi, come il tralcio con fogliame a forma di ventaglio che nasce da un piccolo vaso rotondo, accomunano questi capitelli a quelli degli stipiti del portale Sud della Basilica - il famoso Portale dei Leoni -, confermando la tesi di una esecuzione contemporanea nello stesso cantiere.
Meritano attenzione i quattro capitelli nella zona centrale della cripta di fronte alla tomba del Santo, poiché presentano caratteristiche romaniche con forme riscontrabili anche in altre sculture ed elementi presenti nella Basilica, come ad esempio nella famosa Cattedra dell’abate Elia. Questi tre capitelli li potremmo descrivere e denominare:
- Capitello dei Leoni e degli Arieti: due leoni con una testa - che fa da angolo al capitello - e tra i due corpi, su tutte le facce, spunta la testa di un ariete. Trasmettono un sentimento di aggressività. Il chiaroscuro viene utilizzato in maniera sapiente, riuscendo a conferire una maggiore forza agli animali rappresentati.

- Capitello dei Leoni e dei Pavoni: è in linea con il precedente. Anche qui i pavoni vengono rappresentati ad ogni angolo con i due becchi che convergono. Fra i loro corpi ci sono le teste di leoni: contrariamente al precedente, trasmettono un senso di serenità.

- Capitello dei Pavoni e del Grifo: si trova in diagonale rispetto agli altri due e quindi un po' più lontano dalla tomba del Santo. E’ il più vario della cripta poiché le scene degli animali variano su ciascuna delle quattro facce: due pavoni che bevono alla medesima coppa - simbolo dell’universale mezzo di salvezza che è l’acqua battesimale e Dio -, due pavoni non più in armonia - uno becca l’altro e l’altro reagisce beccandolo a sua volta -, un grifo alato che azzanna un leprotto dall'espressione dolorante e infine un levriero che azzanna un coniglio.

Prevalgono strutture piene e plastiche, modelli che diverranno dominanti a partire dalla metà del XII secolo. A chiudere il quadrilatero non c’è un capitello figurato, ma uno raffigurante tutt'intorno delle pigne, con quattro rettangoli sovrastanti che incorniciano dei disegni ornamentali.
Il problema dei pavimenti
In questa chiesa sotterranea il problema delle maree ha avuto un ruolo dominante nella scelta del pavimento e delle colonne: trovandosi quasi 50 centimetri sotto il livello del mare, il pavimento venne, dopo molti anni, sollevato con l’ovvia conseguenza di nascondere la base delle colonne. Gli allagamenti del 1599 fecero scomparire il mosaico e tutto fu sostituito da lastre di pietra. Un altro intervento pose un nuovo pavimento per volere di Nicola II di Russia, che visitò la cripta nel 1892.
Solo i recenti restauri di Schettini (1953-1957) hanno riportato la cripta al primitivo splendore: l’ultimo pavimento aggiunto è stato rimosso, le basi sono tornate nuovamente visibili, il tutto protetto da iniezioni di cemento. L’antico pavimento era, molto probabilmente, a mosaico con caratteri geometrici, come dimostra l’area che circonda la tomba di San Nicola e i frammenti alla base della “colonna miracolosa” in marmo rossiccio - secondo la leggenda sarebbe stata collocata alla vigilia della consacrazione della cripta da San Nicola stesso, per supplire alla mancanza di una colonna (e quindi di un sostegno) -.

Caratteristiche uguali anche a quelle del mosaico presente nel presbiterio delle chiesa superiore, sotto l’altare e il ciborio voluti da Eustazio, successore di Elia.
Dietro la cancellata che chiude il presbiterio campeggia la grande icona donata da Uroš di Serbia, in cui su un fondo totalmente dorato spicca San Nicola a figura intera che risalta da questo fondo grazie alla sua carnagione e ai lati della sua testa, in piccolo, ci sono rappresentati Gesù e la Madonna.

Il Santo con tre dita della mano sinistra regge il Vangelo mentre la destra è in segno benedicente (unico elemento “movimentato” della rappresentazione che esce dalla staticità complessiva della figura). I paramenti episcopali - dorati anch'essi - presentano delle croci verdi che danno punti di fuga dal dorato predominante, e ai piedi del Santo le figure del re Uros III e della regina Maria sono ben visibili, ma sono la seconda e la terza versione dell’icona: infatti questa opera è stata più volte trasformata, rimaneggiata, per rispondere alle esigenze dei sovrani slavi che di generazione in generazione si avvicendavano.
La cornice che corre lungo tutto il perimetro è in argento.
Sotto questa ricchissima icona, l’altare in pietra che custodisce le reliquie del Santo stride di contro per la sua semplicità. La tomba, sobria e austera, fu rivestita d’argento e nel 1319 assunse la sua conformazione definitiva con la copertura donata, per l’appunto, dallo zar di Serbia Uroš II Milutin.
Durante l’epoca barocca questo altare fu considerato “antiquato” e quindi venne fuso con altri argenti, rinascendo dalle mani di due artisti napoletani: Marinelli e Avitabile. La porticina antistante, vegliata da due angeli con due bottiglie di manna, era concepita per potersi introdurre, venerare le reliquie ed estrarre la manna. Per fortuna, con l’epoca dei Grandi Restauri di metà Novecento, il nuovo altare argenteo fu spostato nel transetto destro della Basilica superiore, ridando all’“antiquato” altare e alla tomba l’originale aspetto severo in pietra: rialzato su due scalini, dove ci si inginocchia per pregare e, attraverso una piccola grata nera, si può ammirare una raffigurazione del Santo giacente che riceve l’ultima benedizione alla presenza delle tre fanciulle salvate con la sua donazione e dei bambini risorti per mano sua - di cui si parlerà in seguito - e un tappeto preziosissimo di raso rosso con decorazioni dorate che copre e protegge le ossa del Santo.
E’ attraverso questa grata che ogni anno si apre e si raccoglie la manna dalle ossa.
Le reliquie del Santo
Ossa conservate che rappresentano il 65% dell’intero scheletro e si trovano all'altezza del piano di calpestio, racchiuse in blocchi di cemento: le ossa mancanti sono sparse nel mondo (tra cui anche a Venezia) e quindi, al loro arrivo a Myra, nella famosa domenica di maggio, i marinai trafugatori baresi si accontentarono delle ossa più grandi e del liquido sacro in cui erano immerse. La famosa manna di San Nicola è appunto un liquido che veniva e viene tuttora raccolto e distribuito ai fedeli in fiale, bottiglie, ampolle o medagliette.
Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1953 fu eseguita, con la presenza della Commissione Pontificia, la ricognizione Canonica di questi resti scheletrici, avvenimento eccezionale, visto che per 866 anni nessuno aveva potuto né vedere né toccare le ossa del Santo Taumaturgo: di queste analisi ne rimane menzione nella relazione del Prof. Martino, docente di Anatomia Umana dell’Università di Bari e del suo collega Dott. Ruggeri, facenti parte della commissione scientifica e medica.
Molto interessante è leggere qualche passaggio di quello che è stato il risultato dell’analisi:
“Il loculo mostrò nel suo fondo rettangolare ossa sparse senza alcun particolare ordine sistematico (il che dimostrava che non era stato di certo un conoscitore di anatomia ad averle precedentemente deposte), con il cranio situato al centro di una estremità del loculo, e con i pezzi, in parte frammentari, di ossa lunghe e di ossa brevi accumulate irregolarmente di torno; il cranio era ben collocato con la base poggiata in basso. Insieme ai minuti frammenti ossei, presenti in gran numero, abbiamo trovato anche del piccolo pietrisco, che presumibilmente dovette essere stato trasportato nel momento del frettoloso trafugamento delle ossa effettuato dai coraggiosi marinai baresi.
Tutti i pezzi ossei si trovavano immersi in un liquido limpido, simile ad acqua di roccia, occupante il fondo del loculo per l’altezza di circa 2 cm; le parti delle ossa che sovrastavano al pelo dell’acqua risultavano tutte umide.
[…] Lo scheletro è risultato appartenente ad un solo e ad uno stesso individuo ed è costituito da ossa molto fragili e molto frammentate. Il cranio é di esso la parte meglio conservata, il che fa credere che sia stata anche oggetto di maggiore attenzione e pertanto la parte maggiormente protetta durante le operazioni di trafugamento. Il cranio è completo nei suoi segmenti e manca soltanto della metà posteriore della emimandibola sinistra; i denti sono presenti in gran numero ed alcuni si trovano ancora infissi nei loro alveoli[1]”.
Tutto lo spazio chiuso dell’altare e della tomba è pavimentato da un sontuoso tappeto in sectile di chiara impronta bizantina, dove fasce marmoree annodate seguono un complesso disegno geometrico e gli spazi sono stati realizzati con preziosi marmi antichi molto colorati; molto simile il sectile che pavimenta la piccola cappella che corrisponde alla torre di sud-est.
Questa cappella orientale rappresenta a livello visivo la vocazione ecumenica esistente tra la città di Bari e San Nicola e la conciliazione tra le due chiese cattolica e ortodossa. La Basilica di San Nicola a Bari diviene la prima chiesa latina con una cappella al suo interno in cui celebrare anche il rito ortodosso: ogni giorno, anche contemporaneamente, si svolgono le liturgie cattolico-cristiane nella chiesa superiore e la liturgia ortodossa nella cripta. Una coesistenza che rende la Basilica incantevole anche sotto questo aspetto: i canti e le preghiere, continue litanie in slavo ecclesiastico, riempiono l’intero spazio della cripta e affascinano il visitatore.
L’iconostasi della cappella è stata eseguita da un artista croato, Zlatko Latkovic, e attira l’attenzione e la curiosità dei fedeli per la scritta INBI, anziché INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum): una scritta che trae in inganno ad una prima visione, ma che in realtà è assolutamente corretta visto che in greco la parola “re” -Rex - è Basileus.
Sulla parete di fronte, opposta all'altare, è posizionata un’altra grande icona del Santo, anche questa dono dello zar, che, protetta da una griglia e da una parete in plexiglass, accoglie le offerte dei devoti che ogni giorno ne fanno visita.
Le pareti laterali tutt'intorno sono occupate da sei lunette dipinte con scene della vita del Santo, realizzate durante la stagione delle trasformazioni barocche; le figure rappresentate hanno tratti in comune con quelle rappresentate sul soffitto della Basilica superiore.
A partire dalla parete di destra in corrispondenza della colonna miracolosa troviamo:
- la “Nascita di San Nicola”: il bambino è rappresentato in preghiera mentre la sua nutrice tenta di lavarlo in una bacinella e la madre, dal suo letto, spazialmente racchiuso nella lunetta, lo osserva assorta nei pensieri;
- “San Nicola e la dote alle tre fanciulle”: la scena più caratteristica e tipica dell’iconografia nicolaiana poichè corrispondente alle tre palle d’oro e al numero tre ricorrente. La scena rappresenta il momento della carità del Santo verso tre fanciulle molto povere, destinate alla prostituzione per volere del diavolo;
- “Resurrezione dei tre bambini”: il Santo è colto nell'atto di resuscitare tre bambini uccisi da un oste. Le creature gli rendono grazie mentre l’oste guarda sbalordito la scena; una figura dietro di lui, immersa nell’ombra e del quale non si scorge fisionomia, rimanda il giudizio dell’uomo a Dio (la mano, chiara e perfettamente visibile, punta verso l’alto);
- “I tre innocenti condannati a morte”: anche loro immersi nella penombra, piegati su loro stessi e con il torace nudo, tre uomini attendono il colpo che li decapiterà. Al centro della scena, con il corpo incurvato a seguire l’andamento curvo della lunetta, San Nicola ferma la mano del carnefice;
- “La colonna miracolosa”: la scena descrive la leggenda raccontata prima circa la posa della colonna miracolosa da parte del Santo, per sopperirne la mancanza, facendosi aiutare da quattro angeli. Il gesto di spingerla con il piede rimanderebbe alla scena della colonna gettata nel Tevere durante un suo viaggio a Roma;
- “La morte del Santo”: l’ultima lunetta rappresenta San Nicola spogliato e morente nel suo letto, sorretto alle spalle da un angelo, sul quale il Santo abbandona la testa. Tre uomini a sinistra assistono pregando alla scena, mentre i paramenti episcopali giacciono ordinati ai piedi del letto.
Infine, a vegliare sul Santissimo Sacramento, c’è la lampada uniflamma, bellissima a forma di caravella, segno inconfutabile dell’arrivo del Santo a Bari e segno dell’unica fede, cattolica e ortodossa, alimentata dalle due tradizioni occidentale ed orientale - i cui simboli sono riportati ai lati del Santo.
Unite nel nome e nella figura di San Nicola, intercessore Taumaturgo, patrono e simbolo della città di Bari.

Note
[1] Il passo riportato dalla relazione del prof. Martino è stato pubblicato nel Bollettino di San Nicola, numero speciale, aprile-dicembre 1957.
Sitografia:
www.basilicasannicola.it
www.caminvattin.it
Bibliografia:
G. Cioffari, La cripta di San Nicola, Bari, 1989.
P. Belli D'Elia, La Basilica di San Nicola a Bari, Galatina, 1985.
G. Dotoli-F. Fiorino, Storia e leggenda della Basilica di San Nicola a Bari, Bari, 1987.