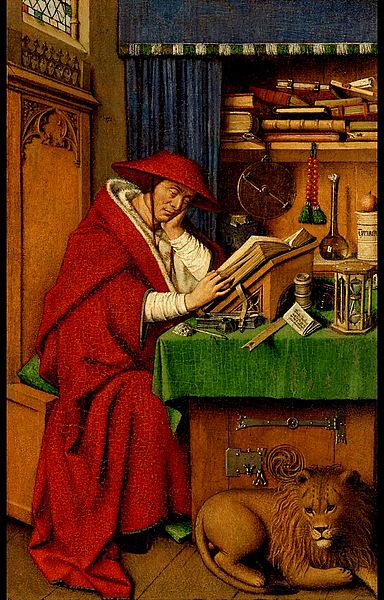LA SCUOLA DI ATENE PT I
A cura di Andrea Bardi
Il dibattito interpretativo sulla Scuola di Atene
Sulla parete opposta rispetto alla Disputa, argomento approfondito in precedenza, Raffaello dispiega quello che con ogni probabilità e il suo affresco più noto. La Scuola di Atene (Fig.1), la cui datazione viene fatta risalire attorno al 1510, occupa, in ordine cronologico, la seconda delle pareti (quella ad ovest) della Stanza della Segnatura. Il titolo con cui l’affresco è universalmente conosciuto, La Scuola di Atene, non corrisponde, tuttavia, alle intenzioni di Giulio II, il quale affidò a Raffaello il compito di tradurre in figura la Filosofia, come si evince, del resto, dal piccolo tondo affrescato sulla volta (Fig. 2), all’interno del quale la rappresentazione allegorica della disciplina è affiancata da due putti recanti cartigli con l’iscrizione “CAUSARUM COGNITIO” (“conoscenza delle cause”, ovvero lo scopo ultimo della speculazione filosofica).
Una prima interpretazione – errata – del soggetto dell’affresco venne tentata da Giorgio Vasari, il quale, nella Vita di Raffaello da Urbino, parla di come il pittore
“havendo ricevute molte carezze da Papa Iulio cominciò nella camera della segnatura una storia quando i teologi accordano la Filosofia & l’Astrologia; con la Teologia; dove sono ritratti tutti i savi del mondo che disputano in vari modi”[i]
Più di un secolo dopo fu Giovan Pietro Bellori (Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino,1695) a riportare la discussione su un binario più corretto. Nel brano relativo all’affresco, lo storico romano contesta l’ipotesi vasariana già a partire dal titolo, che fa riferimento proprio all’ “antico Ginnasio di Atene”. Oltre ad offrire all’opera un titolo pressoché definitivo – la storiografia protestante nordeuropea sistematizzò in seguito tale riferimento – Bellori parte con lo sconfessare l’intera costruzione teorica dell’aretino:
“improprio ancora è il nome impostole dal Vasari: la concordia della Filosofia, ed Astrologia con la Teologia, non vi essendo ne Teologi, ne Vangelisti, com’egli lungamente descrive”[ii]
per poi mettere a fuoco quello che è il reale soggetto dell’opera, ribadendo come l’intenzione di Raffaello fosse quella di
“raccorre insieme gli studi, e le scuole de’ più illustri filosofanti, non di una età sola, ma de’ più celebri del Mondo per formare l’Immagine della Filosofia”[iii].
La Scuola di Atene e l’evoluzione iconografica della Filosofia
Dopo aver chiarito ogni dubbio relativamente alla terminologica adottata – e, di conseguenza, alla tematica affrontata dal pittore nell’affresco – si rende ora necessario un approfondimento descrittivo dell’opera e il suo inquadramento all’interno della tradizione pittorica europea.
Incorniciata dall’arco acuto della parete di fondo, La Scuola di Atene altro non è che un consesso di filosofi – in prevalenza greci, ma non solo – che occupano la scalinata di dislivello di due ambienti. Inquadrati dall’infilata di due botti a lacunari geometrici, i principi della tradizione filosofica greca – Platone e Aristotele (rispettivamente a destra e a sinistra) – costituiscono il baricentro della composizione, il polo magnetico di riferimento attorno al quale gravitano, su entrambi i lati, cinquantotto figure, molte delle quali sono state individuate con un buon margine di certezza.
Prima di affrontare la questione – delicata – dell’identificazione dei personaggi, occorre tuttavia provare a dare all’opera un posto nella storia, per chiarirne tanto i legami con la tradizione precedente quanto i motivi di distacco e di originalità nei confronti della stessa. Lo studioso che si è occupato di tracciare, sia pur per sommi capi, una storia dell’iconografia della Filosofia è stato Glenn W. Most, in un articolo dedicato all’affresco vaticano, originariamente pubblicato nel 1996 e tradotto nel 2001 da Einaudi (Leggere Raffaello: “La Scuola di Atene” e i suoi pre-testi). Oltre a porsi sulla scia di Springer (1883) e alla sua critica all’eccesso di zelo dimostrato da certa storiografia positivistica, “colpevole” di aver provato – senza successo – di fornire un identikit preciso ad ognuno dei quasi sessanta personaggi ritratti, il contributo di Most agli studi raffaelleschi risulta essere estremamente utile per due motivi: se da un lato lo studioso fornisce ipotesi affascinanti – sebbene non provate – relativamente alle fonti e agli uomini chiave dietro l’elaborazione concettuale dell’opera (argomento che verrà discusso successivamente), dall’altro il suo merito è indubbiamente quello di aver dato una collocazione precisa, all’interno di un filone iconografico ben preciso, alla Scuola di Atene.
L’iconografia della Filosofia, spiega Most, nasce nella letteratura tardoantica, con il De consolatione Philosophiae di Severino Boezio (524 d.C. ca.), testo in cui la Filosofia appare come una donna caratterizzata, già a queste altezze cronologiche, dalla presenza di due attributi canonici, il libro e lo scettro. Anche il De nuptiis Mercurii et Philologiae di Marziano Capella (V secolo) e la Psychomachia di Prudenzio (390-405 d.C.) sembrano aver partecipato alla creazione di un’iconografia comune, in cui al tema della Filosofia si accompagnava quello delle arti liberali e quello dei vizi e delle virtù[iv].
Nelle arti visive, il periodo della tardoantichità e successivamente il Medioevo videro la diffusione di due grandi modelli iconografici: la Filosofia, infatti – le cui fattezze erano ancora femminili – poteva venire sia isolata sia circondata da un numero ristretto di personaggi maschili, che a loro volta potevano essere identificati come filosofi. Altre volte ancora, la Filosofia veniva attorniata anche dalle personificazioni delle arti liberali (Coppa Horst, XII secolo; Manoscritto miniato dell’Hortus deliciarum di Herrad di Landsberg, anch’esso del XII secolo). Un modello simile era ancora vivo nella tradizione europea ai tempi di Raffaello, testimoniato dal frontespizio della Margarita Philosophica di Gregorius Reisch (1504)[v].
Julius von Schlosser e Ernst Gombrich – continua lo studioso – arrivarono a proporre un confronto della Scuola con testi cronologicamente più vicini agli affreschi Vaticani – e sicuramente conosciuti dall’urbinate – ovvero le Virtù di Pinturicchio nel Collegio del Cambio di Perugia (fig. 3) e le arti liberali di Pinturicchio nell’Appartamento Borgia (fig. 4)[vi]. Sia in Pinturicchio che in Perugino, tuttavia, si era in presenza di una narrazione unificata, di una struttura unica e comprensiva tanto dell’allegoria filosofica quanto dei “praticanti”. In questa prospettiva l’innovazione apportata da Raffaello consiste, sostanzialmente, nell’aver separato i due elementi, scomponendo l’impaginazione tradizionale e riservando al primo elemento il tondo della volta e al secondo un’intera parete.
Note
[i] G. Vasari, Le vite, p. 69.
[ii] G. P. Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, p. 30.
[iii] Ivi, p. 31.
[iv] G. W. Most, Leggere Raffaello: “La Scuola di Atene” e il suo pre-testo, p. 21.
[v] Ivi, p. 22.
[vi] Ivi, p. 24.
Bibliografia
Daniel Orth Bell, New identifications in Raphael’s School of Athens, in “The Art Bulletin”, vol. 77, no. 4, New York, College Art Association, 1995, pp. 638-646.
Glenn W. Most, Leggere Raffaello. La Scuola di Atene e il suo pre-testo (1999), trad. it. di Daniela La Rosa, Torino, Einaudi, 2001.
Giovan Pietro Bellori, Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle da Urbino, Roma, Stamperia di Giovanni Giacomo Komarek, 1695.
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze, Giunti, 1568.
CHIOSTRO DEGLI ARANCI PT. I
A cura di Federica Gatti
Il Chiostro degli Aranci
Progettato, costruito e decorato tra il 1419 e il 1441, il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina è parte del progetto di rinnovamento della stessa portato avanti dall’abate Gomezio[1]. Seguendo i costumi benedettini, il chiostro è situato a Sud della chiesa di Santa Maria Assunta: questa collocazione non solo seguiva la tradizione centenaria, ma separava anche i monaci il più possibile dal lato pubblico della Badia. Lo spazio di costruzione era predeterminato: a Nord dal nartece e la navata della chiesa; a Est dalla sala capitolare quattrocentesca e da un gruppo di botteghe lungo via del Proconsolo; a Sud da un altro gruppo di botteghe lungo via del Garbo; ad Ovest da alcune case e torri appartenute alla famiglia dei Sacchetti.
L’architetto o il progettista risolse, quindi, il problema della mancanza di sufficiente spazio aperto tramite lo sviluppo verticale della costruzione del chiostro.
Il Chiostro degli Aranci è un ambiente trapezoidale, formato da cinque campate nel lato Nord e in quello Sud e sette nel lato Est e Ovest, che si sviluppa per tre piani, due loggiati e il terzo terrazzato.
I due piani bassi del chiostro hanno coperture voltate a crociera rette da colonne ioniche collegate da archi a sesto ribassato poco profondi, tipici delle logge del tardo Medioevo e primo Rinascimento. A differenza dei cortili non monastici dove le colonne continuano fino al pavimento, quelle delle arcate del Chiostro degli Aranci sono supportate da un muro basso che serve anche come panca dove i monaci possono sostare.
La colonna d’angolo, di grossezza maggiore di quelle dei vari lati, sia nel piano terreno che nel piano superiore, rappresenta un elemento arcaicizzante e per contrapposto negli spigoli delle pareti si ha la scomparsa delle lesenette intermedie, ridotte ad un esilissimo elemento, a pianta pressoché quadrata, inserito fra le due parti ad angolo retto: si ha quindi uno spicchio di peduccio nei quattro angoli della muratura della loggia.
Sembra che il supporto finanziario per il progetto del Chiostro venga non solo dall’abate Gomezio, ma anche da fuori del monastero, e Ser Filippo di Ser Ugolino Pieruzzi è spesso accreditato come il patrono del Chiostro degli Aranci, in conformità alla biografia del notaio e studioso scritta da Vespasiano da Bisticci[2]. Egli afferma che Ser Filippo faceva molti regali anonimi, includendo fondi per il Chiostro degli Aranci. Questa dichiarazione trova conferma in alcune prove documentarie: Eduardo Nunes, storico portoghese interessato alla vita e ai lavori dell’abate Gomezio, interpretava i pagamenti del 1434 e del 1436 per indicare la responsabilità di Ser Filippo per il materiale da costruzione dei dormitori e del Chiostro di Badia. Apparentemente conferma ciò che sostiene da Bisticci, anche se i pagamenti sono relativamente ridotti e sembra che si sia comportato come intermediario per le transazioni finanziarie per conto del monastero. Non si è quindi certi del patronato di Ser Filippo anche perché altre fonti menzionano l’abate Gomezio e non Ser Filippo come responsabile del progetto.Le colonne grigie di pietra serena, i capitelli e le modanature si contrappongono ai muri in stucco dei parapetti, eco di un classicismo brunelleschiano reso popolare solo pochi anni prima nella loggia dell’Ospedale degli Innocenti.
Molti degli studi sulla storia architettonica del Chiostro degli Aranci si sono incentrati sull’identità del suo architetto, indagine resa difficoltosa dalla frammentarietà dei documenti e dalla loro forma di brevi annotazioni.
Anche se Vasari non include il Chiostro degli Aranci nella biografia di Bernardo Rossellino, molti storici hanno attribuito il Chiostro allo scultore e architetto perché il suo nome appare in un libro contabile della Badia pertinente al complesso del Chiostro. Si sa che tra il febbraio 1436 e il febbraio 1438 Rossellino venne pagato più di 56 fiorini, presumibilmente per i lavori nel nuovo complesso del Chiostro. Le ipotesi attributive avanzate sono molte, tra le quali quella di Pietro Sanpaolesi, ad esempio, il quale sostiene che il “maestro di murare” Antonio di Domenico progettò e realizzò l’intero complesso, poiché in molti pagamenti, anche se non tutti, viene chiamato “capomaestro alla parte” o semplicemente “capomaestro”, titolo che veniva dato al direttore dei lavori.
I libri contabili della Badia riportano una lista di nomi di molti lavoratori specializzati che si adoperarono per il progetto del Chiostro, per cui, da quanto si è iniziato a vedere il Chiostro degli Aranci come uno sforzo collettivo, il problema di identificarne l’autore è passato in secondo piano. Durante il XV secolo dei progetti costruttivi erano, infatti, spesso incaricati due “capomaestri”, uno per controllare gli intagliatori e un altro per controllare i muratori: per il Chiostro degli Aranci, grazie all’analisi dei pagamenti effettuati, sono stati fatti i nomi di Giovanni d’Antonio da Maiano e Antonio di Domenico dalla Parte.
Primo piano del Chiostro degli Aranci
Il primo piano del Chiostro degli Aranci permette l’accesso alla chiesa, alla sala capitolare, alla cappella, al refettorio, alle scale che conducono al secondo piano del chiostro e ai dormitori. Seguendo le regole stabilite nei monasteri cistercensi, il chiostro doveva avere due entrate per la chiesa: mentre il portale arcuato del capitolo nuovo venne rimodernato durante il XVII secolo, la porta monumentale probabilmente sostituisce una precedente entrata all’antico nartece della chiesa. Una seconda porta si apre nella navata della chiesa dalla campata angolare di Nord-Est: quest’entrata è rialzata di quattro scalini e permette l’accesso al coro dei monaci. L’entrata originale del coro venne demolita per creare una delle due cappelle che fiancheggiano l’altare maggiore della Badia Fiorentina. Attualmente i visitatori entrano nel chiostro da una porta situata nel lato destro del presbiterio, la quale conduce a una scalinata costruita nel XVII secolo rimpiazzando una piccola cappella che era sotto il patronato della famiglia dei Del Caccia e dedicata nel 1523 ai Santi Giacomo e Filippo.
La quattrocentesca sala del capitolo era situata adiacente alla cappella Del Caccia, sul lato Sud, e i costruttori del Chiostro incorporarono la facciata nella terza e quarta campata nella loggia Est del Chiostro, incastonando i suoi tre archi a mensola nel cornicione della facciata medievale.
Il muro della campata della loggia meridionale è coperto da un affresco di Vincenzo Meucci del 1736 che raffigura San Benedetto che presenta il marchese Ugo alla Vergine.
L’affresco è situato all’interno di una cornice in bugnato che include il peduccio corrispondente alla colonna angolare e che riprende le incorniciature delle porte e delle finestre. Sulla sinistra dell’opera si vede la Madonna seduta, avvolta da un velo sul quale sono adagiati degli amorini, che guarda il marchese Ugo presentatole da Benedetto, il quale è posizionato sul lato destro dell’affresco. L’opera venne staccata per il restauro e attualmente versa, soprattutto nella parte bassa, in cattivo stato.
Sulla parete Ovest è fissata in verticale una lastra tombale, precedentemente collocata in chiesa, dell’uomo di legge Tommaso Salvetti, morto nel 1472.
Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;
a Est quelle di modestissime dimensioni, con un semplice stemma, di personaggi legati alla vita artigiana fiorentina, come ad esempio Guglielmo Spadalunghi, notaio dell’Arte della Lana morto nel 1300, oppure Piero di Pacino pianellaio, le quali erano già situate in altri ambienti del monastero.Altre lapidi tombali si susseguono sul resto della parete settentrionale e su quella orientale: tra le molte del XIV-XV secolo si ha a Nord quella dei Cerchi, con l’arme parlante della potente famiglia;
Le prime tre campate della parte meridionale della loggia Ovest contengono finestre che si aprono sul refettorio, la cui entrata era dalla campata dell’angolo Nord-Ovest, dove una porta collegava la loggia Ovest con un largo vestibolo voltato a crociera. Un affresco che raffigura San Benedetto che addita silenzio, progettato e forse anche realizzato da Beato Angelico, sormonta questa porta e ricorda ai visitatori di rimanere in silenzio nel refettorio come richiesto dalla regola benedettina.
La lunetta rappresenta un mezzo busto della figura del santo, vestito con l’abito nero dei monaci benedettini, circondato da un arco a sesto acuto in finto marmo. Il santo addita silenzio con il dito indice della mano sinistra che poggia sulle labbra serrate e nella mano destra tiene una fascina di bastoni, ovvero il flagello che è uno dei suoi attributi più comuni. Vasari attribuisce la lunetta a Beato Angelico in entrambe le versioni delle sue Vite: l’attribuzione sembra piuttosto certa sulla base dello stile della sinopia a confronto con altre simili lunette dipinte nei primi anni 40 del Quattrocento nel convento di San Marco, soprattutto confrontandola con la lunetta che rappresenta San Pietro Martire che addita silenzio.
Un’attribuzione del completamento in pittura è più complicata: nel 10 e 17 dicembre 1443, la Badia si accordò con un distributore di pigmento blu per l’acquisto di due once di azzurrite per questo affresco. Non si sa se questa quantità di pigmento fosse per completare, risistemare o riparare l’affresco. Ad ogni modo si può dire con certezza che la quantità di affresco eseguita fino al momento era minima, data la piccola quantità di pigmento acquistato, il quale venne lavorato a secco perché l’azzurrite non può essere applicata sull’intonaco fresco.
Note
[1] Il nome del chiostro della Badia Fiorentina suggerisce la presenza di alberi di aranci, anche se non ci sono prove che il nome venisse usato prima del XIX secolo. Si veda: A. Leader, The Florentine Badia… p. 159.
[2] V. Da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Firenze, 1859, pp. 382-391.
Bibliografia
Magno, Dialoghi, manoscritto n. 215 S.78, Abbazia di San Gallo
Neumeyer, Die Fresken im “Chiostro degli Aranci” der Badia Fiorentina, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, 48. BD., Staarliche Museen zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, 1927, pp. 25-42
Tyszkiewick, Il Chiostro degli Aranci della Badia Fiorentina, Rivista d’Arte, gennaio 1, 1951, pp. 203-209
Procacci, Sinopie e affreschi, Milano, Electa per Cassa di Risparmio di Firenze, 1960, p. 66
R. Henderson, Reflection on the Chiostro degli Aranci, Art Quarterly 32, n. 4, inverno 1969, p. 395, p. 399
Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982
Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform, 2000
Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentina Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233
Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139
Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017
“RITRATTE – DIRETTRICI DI MUSEI ITALIANI”
A cura di Silvia Piffaretti
“Ritratte – Direttrici di musei italiani”
Nelle Sale degli Arazzi di Palazzo Reale ha aperto al pubblico, dal 3 marzo al 3 aprile 2022, la mostra fotografica “Ritratte – Direttrici di musei italiani” promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano Cultura e Fondazione Bracco. L’esposizione, attraverso gli scatti del fotografo francese Gerald Bruneau, si pone in continuità con l’impegno della Fondazione che da tempo si confronta con la valorizzazione delle competenze femminili nei vari campi del sapere e l’abbattimento dei pregiudizi. Come sostiene Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, “alla guida di importanti istituzioni culturali del nostro Paese ci sono professioniste straordinarie che hanno raggiunto posizioni apicali grazie a competenze multidisciplinari, che uniscono una profonda conoscenza della storia dell’arte con capacità gestionali e creative”, pertanto è risultato doveroso valorizzarne le storie ai fini di incoraggiare le nuove generazioni di donne.
L’impegno per il femminile e la costruzione di una società paritetica però non è nuovo a Fondazione Bracco, infatti già nel 2016 aveva concepito il progetto “100 donne contro gli stereotipi” (100esperte.it), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall’Associazione Gi.U.Li.A. e sviluppato grazie alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Quest’ultimo progetto prevedeva la costituzione di una banca dati online ai fini di radunare profili eccellenti di esperte in vari settori del sapere, selezionate con criteri scientifici, allo scopo di aumentarne la visibilità sui media. Nel 2019 invece, sempre in collaborazione con Bruneau, aveva ideato la mostra fotografica “Una vita da scienziata” di cui i soggetti principali erano alcune delle più grandi scienziate italiane.
Ritratte. La donna oltre il ruolo della “Musa”
La scelta del titolo “Ritratte” per la mostra è dovuta a molteplici motivi. In primo luogo permette di ricollegarsi alla storia dell’arte, un tempo ad essere raffigurati erano soprattutto i membri di famiglie nobili, aristocratici e regnanti che, quando ancora non esisteva la fotografia, fissavano la propria immagine attraverso la pittura. Ad essere ritratte tuttavia erano unicamente le dame di buona nascita, la cui famiglia poteva permettersi il pagamento di un pittore. Il termine gioca inoltre sul fatto che le direttrici di tali istituzioni, che di norma abitano spazi di lavoro appartati, in questa sede sono state trasformate in quelle stesse opere d’arte di cui si occupano, divenendo così oggetto dell’attenzione collettiva che ne riconosce il ruolo apicale.
Il fotografo, in merito alla genesi del progetto, ha affermato che da tempo sognava di intraprendere un piccolo Grand Tour alla ricerca dei luoghi che custodiscono l’Arte nel nostro paese. Egli però, a differenza dei viaggiatori del passato che amavano farsi ritrarre innanzi ai capolavori dei pittori, ha voluto ritrarre chi di questo patrimonio si fa oggi custode. “La storia”, argomenta Bruneau, “è sempre stata piena di figure femminili, prevalentemente nel ruolo di muse o modelle di grandi artisti. Ma se le donne hanno sempre ispirato l’arte o ne sono diventate, grazie ai loro talenti, autrici prestigiose, io ho preferito andare alla scoperta di quelle donne che hanno scelto di custodirne i tesori, sempre più consapevoli del ruolo vitale dell’arte nella cultura del proprio paese, e si cimentano oggi in un compito estremamente difficile: la direzione e la cura dei Musei, i luoghi sacri alle Muse”.
L’intento del fotografo è quello di valorizzare la bellezza di tali figure, stimolando la riflessione e il pensiero critico. A partire da questo desiderio ha lavorato per circa due mesi, durante il difficile periodo della pandemia scandito da continui lockdown, poiché vivere senza l’arte non era uno scenario per lui attuabile. In questo suo Tour negli spazi museali, pressoché disabitati, ha avuto la possibilità di ammirare grandi capolavori in una cornice sospesa nel tempo. Il fotografo si è mosso tra le statue della Magna Grecia e dell’Antica Roma, fino alle realizzazioni contemporanee, attraversando disparate epoche ed i loro costumi, simboli, capolavori e architetture. Di fronte a cotanta bellezza, che gli ha provocato una forte sindrome di Stendhal, Bruneau ha faticato nell’effettuare una scelta dei luoghi in cui realizzare gli scatti.
Tra le protagoniste della mostra figurano i ritratti di Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma; Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma; Anna Maria Montaldo, già Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano e Alfonsina Russo, Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, per citarne alcune. Una delle fotografie più suggestive è quella di Emanuela Daffra, Direttrice Regionale Musei della Lombardia, immortalata di fronte all’iconico Cenacolo vinciano; a cui fa seguito quella di Virginia Villa, Direttrice Generale Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari di Cremona, ritratta nell’atto di abbracciare con amore un violino, simbolo cremonese.
In questo modo Gerald Bruneau ha dato vita ad un viaggio nella bellezza di tali “splendide vestali”, come da lui definite, dedite a tenere in vita il fuoco sacro dell’arte per mezzo della loro sensibilità e intraprendenza. Le direttrici, trasformate nelle sue muse e guide, gli hanno regalato una ventata di energia e di ottimismo in un periodo travagliato, a loro pertanto rivolge la sua gratitudine e ammirazione.
Informazioni di visita
MOSTRA FOTOGRAFICA “RITRATTE – DIRETTRICI DI MUSEI ITALIANI “
Palazzo Reale di Milano | Sale degli Arazzi |Milano, piazza del Duomo 12
3 marzo – 3 aprile 2022
INGRESSO GRATUITO
ORARI
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 – 19.30 | Giovedì 10.00 – 22.30 | Lunedì chiuso Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura
Ufficio stampa mostra
Lucia Crespi | [email protected]
Ufficio Stampa Comune di Milano
Elena Conenna | [email protected]
LA CHIESA DI SAN DOMENICO A NARDÒ: UN RACCONTO DI PIETRA IMMORTALE
A cura di Letizia Cerrati
Fulgido esempio di Barocco salentino, nella sua declinazione di Barocco neretino, la Chiesa di Santa Maria de Raccomandatis a Nardò è meglio conosciuta come San Domenico.
La data di costruzione è incerta, il complesso architettonico sorge su una delle più antiche aree di fondazione domenicana sul territorio (1300 circa).
Il convento originario andò distrutto a seguito dell’assedio e dell’incendio della città nel 1384 e della ricostruzione si occuparono i vescovi Giovanni Barella (1423-34) e Ambrogio Salvio (1569-77), coadiuvati dal popolo.
L’edificio attuale è frutto della ricostruzione promossa dai frati Domenicani che lo intitolarono a Sancta Maria de Raccomandatis nel decennio successivo alla Battaglia di Lepanto.
Il contratto, risalente al 14 dicembre 1580, stipulato alla presenza del notaio Francesco Fontò, testimonia che l’incarico fu affidato dai frati Domenicani all’architetto neretino Giovanni Maria Tarantino[1].
I lavori furono ultimati nel 1586, ma il terremoto che si abbatté sulla città il 20 febbraio 1743 causò ingenti danni alla struttura, soprattutto alla parte interna, risparmiando la facciata, la parete laterale sinistra ed una parte della sagrestia.
La chiesa ha pianta a croce latina, a navata unica, e presenta quattro cappelle in ciascun lato e il suo architetto è il massimo esponente di quella maniera neretina che fra Cinque e Seicento si contese il primato nel panorama artistico locale con quella leccese.
Questa sottile ma significativa differenziazione tra le due maniere contemporanee è rafforzata dall’impiego di un materiale di costruzione caratteristico nell’ambiente neretino, che induce alcuni studiosi a parlare di pietra barocca neretina riferendosi al carparo, diverso dalla pietra leccese ed anche da quella di Cursi o Maglie.
La chiesa domina oggi sullo spazio della piazza principale della città, catturando l’attenzione dei passanti, stregati dalle voci degli omuncoli di pietra, osservati dall’alto dai capitelli antropo-fitomorfi, dalle maschere e dai telamoni che affollano la facciata.
La facciata in carparo è un imponente monumento barocco, incrostato di reminiscenze di simbologia medievale e riecheggiante gli avori bizantini, soprattutto nella resa puntigliosa delle figure protagoniste. Dal 1580 vi lavorarono Giovanni Maria Tarantino, Giovanni Tommaso Riccio, Scipione de l’Abate e Scipione Bifaro.
Circa l’iconografia della facciata sono state avanzate numerose ipotesi, tra cui quella di un possibile coinvolgimento di Ambrogio Salvio, il teologo domenicano che soggiornò per un periodo a Nardò; tuttavia, questa fu costruita durante il vescovato di Cesare Bovio, che si avvaleva della collaborazione di Carlo Borromeo.
Gli altari barocchi sono spesso assimilabili a facciate chiesastiche in miniatura, viceversa l’impaginazione architettonica della facciata del San Domenico potrebbe evocare la struttura e la decorazione fitta e complessa di un altare barocco.
Il prospetto strutturato in due ordini sovrapposti si divide in mondo terreno e mondo celeste.
Il portale è di fattura più tarda, inquadrato da una struttura ad arco di trionfo, e si rivela immediatamente nella sua natura di inserimento posteriore rispetto al resto della facciata.
L’ordine inferiore inizia con un basamento alto, con i piedistalli delle colonne aggettanti e decorati con roselle e teste di profilo.
Sei colonne binate e scanalate, terminanti con capitelli con testine umane – con scanalature che si infittiscono ad un terzo dell’altezza, evidente grazie alla presenza di un collarino – dividono in tre parti la facciata.
Gli intercolunni ospitano teste barbute, piccoli festoni vegetali, putti nudi, seduti, capovolti o recanti vari attributi; una piccola schiera di personaggi grotteschi, foriera di uno spirito pagano, popola il prospetto, variando nell’aspetto a seconda di come cadono luci e ombre, nel fregio, invece, si scorgono altri occhi attenti: quelli dei mascheroni vegetali scolpiti.
La parte centrale, ai lati del portale è caratterizzata da motivi barocchi: volute, erme fogliate e barbute, grandi putti nudi che sostengono sulla testa canestri di frutta come fossero telamoni.
La zona inferiore si pone in un atteggiamento di subordinazione rispetto a quella superiore: il mondo mortale, pagano ed effimero, si inchina al mondo della Fede, della contemplazione e dell’eternità.
Nell’ordine superiore, trionfo del Regno di Dio e quindi della Redenzione, l’eccesso decorativo è abbandonato a favore di un’essenzialità dal tono sacro; le forme si alleggeriscono, perdono la pesantezza delle cose terrene ed acquisiscono la levità di quelle divine, su cui le ombre non paiono più posarsi.
L’impalpabilità che caratterizza ciò che è celeste si riflette su questa parte dell’edificio: svaniscono i significati misteriosi e si dissolve l’aura ancestrale che riveste la parte inferiore, si fanno spazio la trascendenza e la luce.
Le lesene binate e rigonfie internamente tenute insieme da un unico grande capitello sono una delle costanti grammaticali nel linguaggio architettonico di Tarantino che si ritrova in quest’opera.
Analoghe a quelle inferiori, le nicchie laterali superiori ospitano santi domenicani affiancate da lesene decorate a squamette e poggianti su una finta balaustra posta al di sotto.
Quest’ultima, di dimensione maggiore, è presente anche al di sotto del finestrone centrale, inquadrato da lesene decorate con motivi floreali.
La nicchia centrale strombata è caratterizzata da una finestrella centinata[2] ed interrompe la trabeazione di coronamento.
Sullo spigolo che unisce la facciata e la parete laterale campeggia, sostenuto dall’erma fogliato, lo stemma della città di Nardò, ora quasi completamente consunto.
L’alto basamento prosegue sulla parete laterale, imbiancata e scandita da coppie di colonne scanalate, che intrappolano tra loro un pilastro ruotato di 45°, motivo ricorrente nelle architetture di Tarantino.
Questo rapporto tra colonne e pilastro rimanda alla dialettica tra volumi nelle architetture barocche ampiamente indagata dagli studiosi e storici dell’arte Marcello Fagiolo e Vincenzo Cazzato ed alle sue possibili letture e interpretazioni come relazione neoplatonica tra corpo e anima, materia e forma, perfezione celeste e incompiutezza terrestre.
La cornice superiore è interrotta da sei piccole finestre centinate e strombate che anticamente si affacciavano sulla piccola navata.
Il campanile che svetta sull’edificio, di grande interesse artistico, è il punto da cui ebbe inizio il rinnovo della chiesa nel Cinquecento, ultimato nel 1572, in cui è possibile distinguere attualmente una porzione risalente al Quattrocento, una seconda al Cinquecento ed una terza successiva alla ricostruzione seguita al terremoto del 1743.
Lo schema dell’intero prospetto segue le leggi geometriche del quadrato, come si può facilmente notare osservandolo.
La magnifica decorazione della facciata assorbe l’attenzione dei visitatori che si perdono, frastornati e ammaliati dai racconti di pietra che si dispiegano su di essa, per poi essere catapultati nell’atmosfera solenne dell’interno dell’edificio.
Lo spazio interno fu ricostruito dopo il 1743 e allestito con un nuovo apparato di stucchi.
Sono nove gli altari presenti nella chiesa. L’altare maggiore originario era, però, più maestoso rispetto a quello attuale in marmi policromi risalente al 1944.
Il transetto occidentale ospita un altare in marmo dedicato alla Vergine del Rosario, con una pala, opera del pittore locale Donato Antonio d’Orlando che raffigura la Madonna con in braccio il Bambino. La Vergine, col capo leggermente chinato, pone con la mano destra il Rosario a Santa Caterina, mentre con la sinistra regge il Bambino, che porge invece il Rosario a San Domenico; dietro di loro gruppi di Santi, pontefici, martiri e sovrani.
Due angeli in alto recano fiori e i putti mantengono aperto un pesante tendone rosso.
Il convento adiacente alla chiesa fu in seguito arricchito da una scala alla napoletana a cui lavorò Adriano Preite seguendo i disegni del domenicano Alberto Manieri.
Le foto dalla 2 alla 7 sono state realizzate dall'autrice dell'articolo.
Note
[1] Lo stesso architetto conferma i suoi natali qualificandosi “Nardoniensis” (neretino).
[2] Murata probabilmente in seguito al terremoto, per garantire maggiore stabilità all’edificio.
Bibliografia
Vincenzo Cazzato, Il barocco leccese, in Itinerari d’arte, a cura di M. Rossi e A. Rovetta, Roma-Bari, Laterza, 2003
Regione Puglia, Assessorato alla Cultura E.P.I., C.S.P.C.R., Nardò, Itinerari turistico culturali, Sulla via delle capitali del barocco, Nardò, S.Maria de Recomandatis (S. Domenico)
Benedetto Vetere, Città e monastero, i segni urbani di Nardò (secc. XI – XV), Galatina, Congedo Editore, 1986
Emilio Mazzarella, Nardò Sacra, a cura di Marcello Gaballo, Galatina, Congedo Editore, 1999
LE 3 ECOLOGIE
A cura di Marco Bussoli
Dal 5 febbraio al 15 maggio al Museo di Arte Contemporanea di Termoli MACTE sarà possibile vedere la mostra Le 3 ecologie, prima mostra curata dalla direttrice del museo Caterina Riva.
“[…] soltanto un’articolazione etico-politica – che io chiamo ecosofia – fra i tre registri ecologici (quello dell’ambiente, quello dei rapporti sociali e quello della soggettività umana) sarebbe capace di far adeguata luce su questi problemi”[1]
Con queste parole nel 1984 il filosofo francese Felix Guattari introduce il concetto di molteplicità dell’ecologia, di pluralità delle ecologie, aggiungendo ulteriore profondità ai temi di sviluppo indiscriminato che tanti studiosi, a partire dagli anni ’70, stavano portando avanti. Sono proprio le tre ecologie del filosofo il punto di partenza per la riflessione che la mostra del MACTE vuol far scaturire.
Il percorso espositivo ha inizio con l’opera Ipogea di Piero Gilardi, che la concepisce a partire da molteplici suggestioni, come il rumore di un fiume sotterraneo e la molteplicità di miti sulle caverne su cui si fonda la cultura europea; l’opera è pensata come un luogo di immersione per l’avventore, che illuminandola dall’interno fa nascere rumori e punti luminosi della caverna. Il percorso passa poi per i 19 pannelli in gesso di Micha Zweifel, Calendar, artista svizzero, che detta una sorta di ritmo evolutivo, un tempo in cui l’umanità si sviluppa e cresce. Il concetto di evoluzione è poi richiamato dall’opera Tuslava di Len Lye, un’animazione del 1929, in bianco e nero, che però procede in modo diverso: l’evoluzione è totale e da un organismo unicellulare si sviluppa un organismo più complesso, con le sue tradizioni e i suoi modi, slegandosi dalla figura umana.
Nella grande sala circolare del museo, oltre a queste opere è presente anche la doppia proiezione di Francesco Simenti, chiamata Corpi, del 2021, definendo così un luogo in cui i cambiamenti non abbiano in alcun modo un’accezione negativa, ma piuttosto costituiscano un’origine, un punto di partenza neutrale.
Spostandosi nelle sale il panorama è già cambiato, ci si trova catapultati nell’oggi, in un mondo di cambiamenti repentini: sullo sfondo della carta da parati disegnata da Francesco Simenti, Hawkweed (2016), i disegni a penna di Nicola Toffolini ci mostrano degli scorci, suggestivi e inquietanti, si tratta di Pòst #2 e di Palma e tetrapodi e Banano e tetrapodi, due disegni in cui i vegetali sono ormai protetti dall’aggressione del mare solo da dei frangiflutti.
I documentari Wutharr: Saltwater Dreams (2016), del Karrabing Film Collective, e Wild Relatives di Jumana Manna, del 2018, fanno spostare l’osservatore in tutto il mondo: il primo è infatti ambientato nei Territori del nord-ovest, in Australia, mettendo in relazione cambiamenti ambientali, sociali e mistici, mentre il secondo segue le semenze, dalla Siria alla Norvegia, tra problemi climatici e socio-economici.
Le opere della serie Boutade di Silvia Mariotti costruiscono luoghi naturali inediti, frutto di un lavoro di montaggio di elementi fotografici, per creare nuovi immaginari, fatti di vegetazione mutevole e affollata.
Nell’ultima sala, infine, si confrontano due artisti: Francis Offman usa materiali di riuso, estremamente variegati, per comporre delle opere che parlano di migrazioni e che presentano ad un’attenta riflessione una serie di significati inediti; Jonatah Manno invece con le sue sculture e le sue cianotipie porta in mostra il mare ed il suo paesaggio.
Come di consuetudine sono poi esposte opere di proprietà della Fondazione MACTE appartenenti al Premio Termoli, che ponendosi a metà del percorso di visita cercano di dialogare con le opere temporanee in mostra.
Abbiamo fatto alcune domande alla Direttrice del museo e curatrice della mostra, Caterina Riva, per meglio comprendere ed approfondire il significato della mostra, che si presenta denso ed aperto a molteplici interpretazioni.
Il tema dell'ecologia è, fortunatamente, sempre più presente nelle vite di tutti, in modi molto diversi tra loro e con intensità molto variabile. L'idea di portare in mostra questo tema dove e quando nasce o, più esattamente, come si è concretizzata?
CR: Da una necessità di pensare ad ogni aspetto della vita come un continuum e una mostra d’arte come qualcosa di più che una semplice evasione. In realtà l’idea di questa mostra aveva già fatto capolino nel programma che avevo presentato nel concorso che mi ha portato alla direzione del MACTE nel 2020. Nel frattempo la pandemia non solo ha posticipato la mostra a più riprese e ne ha reso l’organizzazione difficoltosa, ma l’ha fatta cambiare e crescere, come fosse essa stessa un organismo che si muta.
La struttura della mostra all'interno degli spazi del MACTE si integra alla perfezione, definendo due grandi spazi principali: quello della sala principale e quello delle salette, in cui sono esposte opere che ci dicono cose molto diverse. Le opere nell'emiciclo ci parlano di origine e di evoluzione, di ideali incontaminati che man a mano diventano più complessi, definendo una sorta di punto di partenza. In qualche modo dopo aver percorso tutta l'esposizione ed aver conosciuto diversi panorami in cui le ecologie possono operare, ci si auspica un ritorno ad un'origine o comunque ad un equilibrio?
CR: La ringrazio molto di questa lettura de Le 3 ecologie, non avevo pensato tanto in termini dialettici di evoluzione nella costruzione curatoriale della mostra, ma più, come faccio sempre, facendomi guidare dalle opere e cercando un dialogo tra di esse e gli spazi del museo.
Un punto di partenza della mostra è stato per me l’animazione di Len Lye del 1929 Tusalava, che ho ottenuto in prestito dalla Nuova Zelanda e che è presentata in Italia per la prima volta e che letteralmente ci porta agli antipodi. Nelle sale del MACTE si alternano opere che richiedono di essere guardate lentamente e con attenzione ed altre più immersive, che colpiscono subito la retina, ma che devono comunque essere scoperte e interrogate. Non so se si ritorna a un equilibrio a fine mostra, temo questo sia solo l’inizio di un cammino e non sarebbe del tutto corretto immaginare di trovare le risposte che cerchiamo in una mostra d’arte, quello che m’importa piuttosto è offrire al pubblico diversi punti di vista, delle sensibilità o strategie che i visitatori possono portare con sé fuori dal museo. Anche i laboratori didattici e il public program che offriremo in parallelo alla mostra, alimenteranno dei filoni di approfondimento e riflessione sulle ecologie al plurale.
Questa mostra si occupa di temi estremamente sensibili per il mondo contemporaneo, potrebbe anche essere la prima di una serie che si avvicinano sempre più ai temi stringenti per la società?
CR: Più che una serie di mostre preferisco immaginarmi un modo organico di pensare al museo MACTE come ad un’entità nel mondo dove si portano esperienze e ricerche che guardano alla nostra complessa contemporaneità. Gli artisti rivolgono a volte domande scomode, più che fornire risposte pacificanti, e portano con sé una molteplicità di esperienze; il compito di un museo di arte contemporanea è, secondo me, di portare alcune di queste domande davanti al pubblico (che intenderei però come non omogeneo per definizione).
Al momento al MACTE stiamo ospitando dei laboratori pratico-teorici con l’artista Nico Angiuli, con il quale abbiamo vinto un bando del Ministero della Cultura per un progetto di performance collettiva che verrà presentata a Termoli a giugno 2022, quest’ opera sociale che si sta costruendo insieme uscirà dalle mura del museo, rendendolo, spero, poroso.
Note
[1] F. Guattari, F. La Cecla, Le tre ecologie, Milano, Sonda, 2019, p. 14
Bibliografia
Guattari, F. La Cecla, Le tre ecologie, Milano, Sonda, 2019
Sitografia
https://www.fondazionemacte.com/it/programma/le-3-ecologie
IPPOLITO SCARSELLA, DETTO SCARSELLINO
A cura di Valentina Fantoni
Chiamato comunemente lo Scarsellino, Ippolito Scarsella nacque a Ferrara intorno al 1550 dal pittore e architetto ferrarese Sigismondo, detto il Mondino, e dalla madre Francesca Galvani. Non si hanno documenti che attestino con esattezza l’anno di nascita, ma in seguito agli studi condotti sul pittore, alla data della sua sepoltura, conosciuta con precisione, e alle notizie sulla sua età al momento della morte si è ipotizzato l’anno 1551[1]. Da uno studio più recente è stato ipotizzato l’anno 1560, ma la difficoltà nella ricostruzione cronologica del corpus dell’artista ancora non permette di identificare con precisione l’anno della nascita[2].
Scarsellino ricevette una prima formazione da parte del padre, ma risulta difficile stabilire la portata del suo insegnamento dal momento che le opere superstiti e note di Sigismondo Scarsella sono poche ed appartenenti a quel periodo in cui Ippolito, già attivo, tendeva ad emulare lo stile paterno[3]. Dopo il breve apprendistato presso il padre, all’età di diciassette anni, intorno al 1568-70, Scarsellino si recò a Bologna dove entrò in contatto con i rappresentanti del tardo manierismo, quali Orazio Samacchini, Lorenzo Sabatini e Prospero Fontana. Dopo questo periodo bolognese, si recò verso il 1570 a Venezia: in laguna studiò alcuni pittori veneti come Tiziano, Tintoretto e Jacopo Bassano e si trattenne quattro anni presso la scuola di Paolo Veronese, e da tale esperienza assimilò così tanto da guadagnarsi il nome di “Paolo de’ Ferraresi” [4]. Dopo questa prima fase di formazione, prima ferrarese e poi bolognese e veneta, Scarsellino fece rientro a Ferrara, dove avviò un lungo percorso di rielaborazione di tutte quelle esperienze artistiche che aveva vissuto, approdando ad uno stile personale e ben riconoscibile.
Le prime notizie certe sulla produzione dello Scarsellino risalgono solamente al 1586, anno in cui eseguì per la chiesa ferrarese di Santa Maria Maddalena, detta delle Convertite, un’opera raffigurante la Madonna e il Bambino con i Santi Maria Maddalena, Pietro, Francesco, Chiara e una monaca francescana. Le notizie successive all’attività dell’artista si riferiscono al suo contributo per la decorazione della chiesa di San Paolo a Ferrara, intorno al 1592[5]. Scarsellino si occupò della decorazione del catino absidale raffigurandovi Elia rapito al cielo, tema diffuso e trattato dai carmelitani, la cui complessa narrazione venne suggerita al pittore da un teologo dell’ordine. La straordinaria invenzione naturalistica e corale dell’episodio non ebbe precedenti eguali in tutta Ferrara, e forse in Emilia, anticipando le note lunette Aldobrandini dipinte da Annibale Carracci a Roma a inizio del Seicento[6]. L’opera purtroppo non godette del plauso dei contemporanei, forse perché non ancora pronti ad accogliere una tale innovazione. Scarsellino contribuì comunque anche in altro modo alla decorazione dell’edificio sacro con il dipinto La Madonna e sei santi carmelitani nell’arco del presbiterio, purtroppo andato perduto in seguito al crollo di una parte del tetto nel settembre del 1964. Altre decorazioni erano presenti nel lanternino e nella cupola, ma a causa di rifacimenti ottocenteschi sono andati perduti. Molte le pale d’altare presenti all’interno delle singole cappelle laterali della chiesa, tra cui alcune eseguite da Sigismondo ed Ippolito. La Discesa dello Spirito Santo, nella terza cappella di sinistra, di cui non si conosce la committenza o il patronato, fu eseguita da Scarsellino in collaborazione con il padre, la Natività di San Giovanni Battista, sull’altare della terza cappella a destra, e le storie con la Decollazione del Battista e Salomè con la testa del Battista, furono eseguite da Scarsellino intorno al 1599, la pala di Sant’Alberto che calpesta il demonio sotto forma di donna nella seconda cappella a destra, eseguita da Sigismondo e attorniata dalle Storie del Santo di Ippolito[7].
Contemporaneamente al cantiere di San Paolo, Scarsellino venne contattato dalla famiglia ducale Este per soddisfare una serie di committenze. Nel 1592-93 viene chiamato a Palazzo dei Diamanti per occuparsi della decorazione dell’appartamento di Virginia de’ Medici, moglie di Cesare d’Este, con due opere, La Fama e Apollo[8]. Per lo stesso palazzo lavorarono anche i Carracci, ma non vi sono notizie certe di un avvenuto incontro tra gli artisti. Scarsellino venne coinvolto anche per i lavori al Castello, per il quale, insieme ad altri artisti, si occupò delle più svariate necessità della corte: ad esempio, per la Camera Ducale fu coinvolto per lavori d’occasione, come apparati effimeri per cerimonie funebri o decorazioni per le finestre, mentre per la cappella ducale dipinse, a chiaroscuro, figure di angeli ed elementi architettonici classici[9]. In questi anni Scarsellino riuscì a dare grande prova di sé grazie alla qualità delle sue opere, dimostrando una grande versatilità nell’affrontare i vari incarichi che gli venivano affidati. In qualità di restauratore fu probabilmente introdotto al celebre camerino di Alfonso d’Este, dove poté osservare, in loco, il Baccanale degli Andrii di Tiziano, di cui eseguì una copia di bellissima fattura. Nella copia del Baccanale (Collezione privata, Ferrara) mostra una certa libertà interpretativa rispetto all’originale, ma può considerarsi in ogni caso un omaggio dell’artista a Tiziano, che forse aveva conosciuto durante il soggiorno a Venezia[10]. La composizione appare la medesima dell’originale, ma ciò in cui si distingue il personale tocco dello Scarsellino sono le fronde a rapidi tocchi stagliate in controluce, sull’azzurro smaltato del cielo, ed essendo meno interessato alla resa puntuale del discorso narrativo elimina alcuni particolari e ne accentua altri: ad esempio ringiovanisce la divinità fluviale, impreziosisce le acconciature femminili e accentua, maliziosamente, la scollatura della giovane in rosso, rinforza la luce in contrasto chiaroscurale mettendo così in risalto i corpi in primo piano[11].
Nel corso della sua produzione artistica lo Scarsellino si dedicò al genere delle opere di soggetto profano, in molte occasioni legate all’ambito mitologico, come alle Favole di Ovidio, che a Ferrara trovarono fortuna già ai tempi dei “camerini d’alabastro” di Alfonso I. Nonostante l’insediamento dello Stato della Chiesa in seguito alla Devoluzione del 1598 e della sua stretta ed intransigente azione moralizzatrice, i dipinti a soggetto profano di destinazione privata non conobbero arresto nella loro richiesta. Infatti, essendo destinate a dimore private di nobili, cardinali, prelati, quindi conservate in circuiti circoscritti e socialmente elevati, il controllo della Chiesa non poteva impedire l’arricchimento delle collezioni private di questi personaggi, che spesso si rivolgevano in prima persona ai pittori per la loro esecuzione. Scarsellino si dedicò soprattutto alla realizzazione di alcuni particolari episodi delle Metamorfosi ovidiane, come ad esempio il Ratto di Proserpina, Venere e Adone e Apollo e Dafne. Osservando queste opere è possibile cogliere un aspetto peculiare e caratteristico dello Scarsellino, ovvero la sua abilità nel riprodurre molteplici volte il medesimo soggetto, a distanza anche di diversi anni, apportando sempre qualcosa di nuovo in ogni singola redazione. Ad esempio, nei due esemplari del Ratto di Proserpina, tra cui intercorre un certo lasso di tempo, la resa materica e l’attento accostamento tonale che si osservano nel primo, nel secondo si trasformano in una esaltazione dei volumi plastici, resi grazie a una luce indagatrice anche dei particolari, esaltazione della plasticità che fu l’apoteosi tecnica raggiunta dallo Scarsellino negli anni[12].
Il cambio dell’assetto politico di Ferrara fece sprofondare la città in una condizione di declino e questa ebbe qualche ripercussione anche sullo Scarsellino, che in quel periodo lasciava travisare dalle sue opere un senso di perdita di quella che una volta era una condizione edenica. Lo stato di declino in cui versava Ferrara a seguito della Devoluzione era dovuto soprattutto alle distruzioni operate dal nuovo governo, di edifici, spesso contenitori di opere d’arte di grande valore, appartenuti soprattutto alla famiglia Este. Scarsellino nonostante i cambiamenti seppe adattarsi alle particolari esigenze della nuova committenza[13]. Con il diffuso fervore della Controriforma le richieste provenivano soprattutto da oratori di confraternite secolari di nuova costituzione, da chiese e conventi appena insediati e anche da parte di laici per soggetti di tema sacro, a volte destinati a chiese. A inizio secolo, proprio nel 1600 Scarsellino eseguì l’imponente e drammatica Crocifissione per il monastero del Corpus Domini, unica opera in cui venne rinvenuta la data apposta dall’artista. Negli anni seguenti seguirono un gran numero di commissioni ecclesiastiche per Scarsellino, poiché molto apprezzato per la modernità della sua pittura e per la sua rapidità esecutiva. Ad esempio, nell’arco di soli due anni eseguì due opere aventi per soggetto la Natività: nel 1605 la Natività della Vergine (fig. 1) per Pieve di Cento, e nel 1607 la Natività di Maria (fig. 2) per la cappella privata di Cesare d’Este presso il Palazzo Ducale di Modena (Galleria Estense, Modena).
Nel 1609 eseguì la pala con la Madonna e il Bambino in gloria fra i Santi Francesco e Chiara e le cappuccine adoranti l’Eucarestia per il gruppo di terziarie minori osservanti di San Francesco, trasferitesi a Ferrara da Venezia. Opera dal sapore tridentino per la sua bipartizione verticale fra cielo e terra, a simboleggiare la funzione mediatrice tra umano e divino operata dai santi e dalle preghiere, vede come centro dell’intera composizione l’ostensorio, simbolo della Chiesa. Altra opera importante è quella del 1611 raffigurante il Martirio di Santa Margherita, eseguita per l’omonimo oratorio. La dedicazione dell’opera perpetuava la memoria di Margherita Gonzaga, ultima moglie di Alfonso II, che nel 1593 aveva raccolto, presso una sede provvisoria, alcune giovani fanciulle di famiglie in difficoltà in conseguenza ad una grave carestia, eseguendo un intervento assistenziale consueto nella corte estense. Le fanciulle assistite potevano quindi riconoscersi nelle giovani raffigurate ai piedi del palco e il martirio, rappresentato in modo pacato e semplice, si prestava a riflessione religiosa.
L’abilità narrativa e interpretativa dello Scarsellino si esprime al massimo nell’opera di committenza privata per mano della famiglia ferrarese Nigrisoli: l’intento della committenza era quello di nobilitare il proprio nome giocando sull’assonanza con la parola Nigersol, nome di un bambino nero di cui si raccontava essere il principe del Tombut. La serie dei dipinti eseguiti da Scarsellino (divisa tra Napoli, Museo di Capodimonte; Ferrara, Collezione della Fondazione Carife, esposte alla Pinacoteca nazionale; Ro Ferrarese, Fondazione Cavallini Sgarbi), che risentono del mondo favoloso e cavalleresco di Dosso Dossi, rappresenta un caso di singolare iconografia: la storia avventurosa della madre con il piccolo Nigersol venne concepita come una serie ininterrotta da leggersi in orizzontale. Inoltre, il paesaggio, colto nei suoi valori naturali e nelle diverse ore del giorno, diviene protagonista della narrazione stessa, anticipando così quel ruolo preminente che avrebbero avuto le vedute paesaggistiche di lì a poco[14] (fig. 3).
La stessa abilità di narrazione viene dispiegata nei dipinti sacri, come l’Andata al Calvario (Quadreria dell’Arcivescovado, Milano) e il Martiro di san Venanzio (Sarah Campbell Blaffer Foundation, Houston), in cui Scarsellino raggiunse uno dei più alti livelli di narrazione pittorica grazie all’abilità di saper giocare su più piani compositivi.
Del 1615 è la pala con San Michele Arcangelo e San Giacomo con il committente (fig. 4), eseguita per volontà testamentaria di Alessandro Mastellari per Pieve di Cento, lo stesso committente che quindici anni prima gli aveva affidato la realizzazione della Natività della Vergine[15]. In quest’opera la presenza dell’astante dimostra la straordinaria capacità dello Scarsellino di cogliere la naturalezza e l’espressività proprie del personaggio, capacità che si riscontrano purtroppo in poche altre opere note rimaste, oltre ai numerosi committenti inseriti nelle opere votive, come La Vergine dona lo scapolare a san Simone Stock (Museum of Art, Olomouc).
Sempre nel 1615 eseguì la pala con la Sacra Famiglia e i santi Carlo Borromeo e Barbara (Gemäldegalerie, Dresda), per la cappella privata di Cesare d’Este, nella sua residenza a Modena. Il rapporto che intercorreva tra il Duca d’Este e l’artista è molto interessante: trovò nello Scarsellino un fidato ed efficiente artista, in grado di interpretare la sua fervida religiosità e al quale affidare le più importanti committenze, soprattutto dopo la fuga da Ferrara. Infatti, ritiratosi nel feudo d’investitura imperiale di Modena, Cesare provvide a creare un’immagine prestigiosa della sua corte, sebbene ridotta e indebolita. Per farlo intraprese alcuni lavori indispensabili per sistemare il vecchio castello, divenuto stabile dimora della famiglia ducale, nella speranza di potersi riappropriare in un tempo futuro della vecchia capitale. I buoni rapporti con il Duca Cesare vennero confermati nel 1606 quando questi cedette all’artista l’uso gratuito di un ambiente presso il castello di Ferrara, per lo studio del pittore, ambiente che precedentemente risultava essere «una camera con un ripostiglio, dove già la duchessa di Urbino haveva la sua cucina»[16]. Nello stesso anno il Duca lo incaricò di eseguire le copie di quattro dipinti che si trovavano nei camerini privati di Palazzo dei Diamanti, per poterli sostituire con gli originali che si era fatto spedire a Modena[17]. Il rapporto era talmente consolidato che l’anno seguente Scarsellino portò personalmente a Modena, in data 4 settembre 1607, l’opera a cui stava lavorando: la Natività della Madonna, destinata all’altare della piccola cappella dell’appartamento privato di Cesare. L’iconografia del dipinto si distaccava da quella consueta utilizzata solamente due anni prima per l’opera di Pieve di Cento e pare che il dettato iconografico sia stato ideato dallo stesso Duca, buon disegnatore, profondamente religioso e particolarmente devoto alla Vergine[18]. Sempre nello stesso anno il Duca chiese nuovamente allo Scarsellino di eseguire le copie di quattro dipinti del Dosso presenti nei Camerini alfonsini, anche in questo caso per poter sostituire gli originali che sarebbero giunti a Modena[19]. Un altro importante incarico giunse nel 1610, quando il duca Cesare decise di portare a compimento nella chiesa ferrarese di San Benedetto la cappella in memoria del padre Alfonso di Montecchio, seguendo le sue volontà testamentarie. Per questa cappella, l’agente del duca aveva contattato il «Pitore Scarselino il miglior di Ferrara», il quale licenziò un’opera raffigurante l’Assunzione, dipinto purtroppo perduto e oggi sostituito da una copia di fattura contemporanea.
Sempre in qualità di copista, venne incaricato di eseguire alcune copie di quelle opere che venivano indebitamente depredate dai palazzi e dalle chiese di Ferrara, dai cardinali e dai prelati romani[20]. Proprio per mascherare queste spoliazioni, e per placare il malcontento generale, venivano commissionate fedelissime copie degli originali spediti a Roma, da poter riporre sugli altari. Scarsellino eseguì le copie per il Sant’Antonio Abate fra sant’Antonio da Padova e Cecilia del Garofalo, presente in Santa Maria Nuova, e del dipinto coi Santi Giovanni Evangelista e Bartolomeo con due ritratti di Dosso, presente nella Cattedrale, opere di cui si era appropriato Paolo Savelli, al seguito di Clemente VIII e nominato poi da Sisto V governatore dell’esercito pontificio per le città di Bologna e Ferrara e per la zona della Romagna.[21]
Anche il fratello di Cesare, il cardinale Alessandro d’Este, si era servito dello Scarsellino a fine del 1619 per realizzare un’opera raffigurante il «Christo che lava i piedi a San Pietro in rame con cornice d’hebbano» (Lavanda dei piedi, Collezione privata, Inghilterra). La consegna promessa entro un mese dagli accordi, nell’ottobre del 1619, non venne rispettata per la difficoltà di realizzare l’opera attenendosi alle dimensioni richieste dal cardinale, che avrebbe voluto il dipinto quattro volte più grande di quelle che riuscì a realizzare il pittore. Probabilmente il cardinale ne fu deluso e pagò allo Scarsellino solamente 30 dei 50 ducati richiesti dall’artista[22].
Come per la data di nascita, anche per quella di morte non si hanno informazioni esatte circa la data precisa. Si ha notizia in data 26 marzo 1620 dell’avvenuto testamento presso il notaio Giulio Cesare Cattanei, tra le cui disposizioni spicca il lascito di un gran numero di disegni, circa cento, al nipote[23]. Del 28 ottobre è la notizia invece della sepoltura dello Scarsellino nella chiesa ferrarese di Santa Maria di Bocche[24].
Scarsellino fu l’ultimo rappresentante della cultura estense a Ferrara e l’ultimo a raggiungere una posizione importante nel panorama culturale emiliano nel periodo di un passaggio cruciale, quello tra Cinquecento e Seicento. La sua profonda assimilazione del cromatismo veneto gli consentì di superare il Manierismo, adattando il colore ad atmosfere più libere e tipiche del nuovo secolo che si stava affacciando. La sua pittura fu ricercata ed amata dai contemporanei per le sue capacità di immediatezza nella resa degli ambienti, delle atmosfere e dei sentimenti. A testimoniare la stima di cui godeva e la diffusione della sua fama, anche al di fuori del territorio ferrarese, è il commento che fece Giulio Cesare Mancini nel suo Trattato della pittura (1619-1621), che nei primi anni del Seicento, ricordava come a Roma «Si fa sentire […] in Roma lo Scarsellin da Ferrara con alcune cose che si son viste di suo dove è spirito e movenza e assai buon colorito. Ha operato et opera continuamente nella sua Patria con buona soddisfazione, e uomo di provetta età poiché più di 25 anni vidi alcune [cose] di suo»[25]. Ulteriore prova della sua solida fama è la citazione dedicata a Scarsellino, quando era ancora vivente, e al padre Sigismondo, del bresciano Giulio Cesare Gigli nel suo testo Pittura trionfante, pubblicata a Venezia ne 1615, in cui i due artisti venivano citati come rappresentanti della scuola ferrarese, «moderni Dossi»[26], mentre degli altri artisti locali non veniva fatta menzione. Agostino Superbi nel suo Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara (1620) nella breve nota dedicata allo Scarsellino ne descriveva i caratteri pittorici, «oggidì singolare et eccellente nella pittura, et abbondante d’invenzioni […] nell’opre sue grandi, e piccole», elogiando la sua «maniera di colorire gustevole, vaga e delicata, et una mano velocissima», e cita anche la presenza di sue opere a Roma[27]. Il primo biografo dello Scarsellino fu Girolamo Baruffaldi, che ne illustrò il catalogo e la personalità artistica, circa un secolo dopo la sua scomparsa, nel suo volume Vite de’ pittori e scultori ferraresi (1697-1730, edito postumo nel 1844-46), dove non mancò di muovergli qualche critica, soprattutto per quelle opere mitologiche e sensuali che eseguì per la committenza privata.
Note
[1] Maria Angela Novelli, Lo Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Cassa di Risparmio di Ferrara 1964, p. 7
[2] Voce Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, in Pittura a Ferrara nel primo Seicento, a cura di Barbara Ghelfi, Edizioni Cartografica, Ferrara 2011, p. 228-232
[3] Maria Angela Novelli, Un pittore estense tra sacro e profano, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Fondazione Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara 2008, p.9
[4] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 7-8; Ghelfi, Pittura a Ferrara …, cit., p. 229; Baruffaldi, il primo biografo dello Scarsellino, diceva riferendosi alla sua arte che si vedeva «trasparire […] un non so che del Parmigianino, ma piucchè altro, di Paolo [Veronese] detto da lui il suo muro maestro: onde continuando poi sempre in questa maniera ottenne […] il nome di Paolo de’ ferraresi», cit. Girolamo Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, II, Ferrara 1844-46, pp. 68-69
[5] Vi sono alcune difficoltà nello stabilire con esattezza il periodo in cui venne svolto questo lavoro, Novelli propone 1595-96 o prima del 1592, quest’ultima data è quella a cui è più incline la studiosa. Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 15
[6] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 15
[7] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.11
[8] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 11
[9] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 11-12
[10] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14; Valentina Lapierre, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli 2008, cit., p. 316 cat. 164
[11] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14
[12] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 14. Per i riferimenti alle due redazioni del Ratto di Proserpina si veda: Lapierre, in Scarsellino, cit., pp. 324-325 cat. 230 – 231.
[13] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 16
[14] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 16. A metà del Novecento si sollevò un dibattito nel quale ci si interrogava sul primato dello Scarsellino all’interno della sperimentazione del paesaggio moderno: ne emerse che l’artista ferrarese perseguì una propria riforma, meno innovatrice e parallela a quella carraccesca, nutrendosi l'ideale classico ferrarese e degli esempi della grande tradizione veneta del Cinquecento, cfr. Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 229. Per una lettura sul confronto tra i Carracci e lo Scarsellino si veda Novelli, Lo Scarsellino, cit., pp. 9-10
[15] Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230
[16] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 18
[17] Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230
[18] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 18
Ghelfi. Ippolito Scarsella …, cit., p. 230
[20] Per un approfondimento sull’attività dello Scarsellino copista si consiglia: https://www.museoinvita.it/author/lapierre/ (25/01/2021)
[21] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.19
[22] Novelli, Un pittore estense …, cit., p.19
[23] Novelli, Un pittore estense …, cit., p. 361
[24] Novelli, Lo Scarsellino, cit., p. 7, 361
[25] Giulio Cesare Mancini, Trattato della pittura, 1619-21
[26] Giulio Cesare Gigli, La Pittura Trionfante, Venezia 1615, p. 24
[27] Agostino Superbi, Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620, p. 128
Bibliografia
Maria Angela Novelli, Lo Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Cassa di Risparmio di Ferrara 1964
Voce Ippolito Scarsella dello lo Scarsellino, in Pittura a Ferrara nel primo Seicento, a cura di Barbara Ghelfi, Edizioni Cartografica, Ferrara 2011
Maria Angela Novelli, Un pittore estense tra sacro e profano, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli, Fondazione Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara 2008
Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi, II, Ferrara 1844-46
Valentina Lapierre, in Scarsellino, a cura di Maria Angela Novelli 2008
Giulio Cesare Mancini, Trattato della pittura, 1619-21
Giulio Cesare Gigli, La Pittura Trionfante, Venezia 1615, p. 24
Agostino Superbi, Apparato de gli homini illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620, p. 128
Sitografia
https://www.museoinvita.it/author/lapierre/
Dizionario biografico degli italiani Treccani – Ippolito Scarsella
https://www.treccani.it/enciclopedia/scarsella-ippolito-detto-lo-scarsellino_(Dizionario-Biografico)
BADIA FIORENTINA
A cura di Federica Gatti
Badia fiorentina: la prima chiesa (978-1284)
Il primo edificio denominato Badia Fiorentina venne costruito per volere della marchesa Willa di Toscana intorno al 975. Il complesso monastico nacque entro una porzione ristretta dell’isolato oggi chiuso tra via del Proconsolo, piazza San Firenze, via Condotta, via dei Magazzini e via Dante Alighieri e fu condizionato dalla presenza delle mura cittadine e dell’antica chiesa di Santo Stefano.
A causa di incendi, grandi ristrutturazioni e soppressioni, gli archivi più antichi della Badia sono stati quasi totalmente persi, per cui non si sa con certezza come potesse essere conformato questo primo complesso monastico benedettino. La Badia Fiorentina ha, però, la peculiarità di nascere e svilupparsi all’interno di un tessuto urbano in cui ogni volume viene incuneato negli spazi disponibili. Proprio per questo motivo si può supporre che la chiesa si configurasse come un’aula quadrangolare con facciata ad ovest ed absidi ad est, contenuta forse, in lunghezza, tra l’antica cinta muraria e l’estremità occidentale della crociera ed in larghezza tra le parallele tangenti il campanile e l’altare maggiore. Essa doveva essere dotata di coro, di transetto e di tribuna con due cappelle volte ad est.
Se si può solamente ipotizzare un disegno della prima chiesa, si è certi della forma a torre cilindrica del primo campanile, la cui base è tuttora riconoscibile: si ritiene che la torre appartenesse già alle strutture acquisite da Willa e fosse subito perno e vincolo per la costruzione della prima chiesa.
Di questa prima fase edilizia rimangono nel complesso solo piccoli frammenti architettonici: al X-XI secolo, ad esempio, è databile un uccello, scolpito entro un fregio a treccia e sormontato da una girandola, che regge col becco un grappolo d’uva, attualmente murato nella parete sud del Chiostro degli Aranci, mentre al XII-XIII secolo è databile la coppia di bifore in marmo bianco e verde, provenienti forse dalla prima facciata.
La chiesa arnolfiana (1284-1310)
La trasformazione del complesso, portata avanti molto probabilmente da Arnolfo di Cambio, fu imposta dal repentino espandersi dell’intera città di Firenze e dal particolare sviluppo che ebbe la zona in cui la Badia si trova al centro.
“E nel detto anno 1284 si cominciò a rinnovare la Badia di Firenze, e fecesi il coro e le cappelle che vengono in su la via del Palagio e il tetto, che prima era la Badia più addietro piccola e disorrevole in siffatto luogo della cittade”[1].
Non vi sono prove documentarie della paternità dell’opera di Arnolfo di Cambio, ma la critica l’ha riproposta anche di recente, avvalorandola sulla base di un’attenta analisi dei principali resti di quella fabbrica, in base ai contenuti stilistici e alla presenza di un paramento murario completamente spinato a martellina dentata[2].
La prima superficie utilizzata per la ristrutturazione del monastero fu quella ottenuta dall’abbattimento delle mura matildine, sulla quale i frati avevano fatto realizzare delle botteghe, loro fonte di guadagno. Per utilizzare questa area Arnolfo trovò una soluzione geniale dal punto di vista statico, estetico e funzionale: decise di collocare le tre cappelle sopra le stesse botteghe. L’architetto mantenne l’orientamento della chiesa di Willa con la facciata ad ovest, ma realizzò una nuova facciata che fu innalzata fino alla linea delle coperture e addrizzò la parete perimetrale delle absidi. In questo modo creò un presbiterio rialzato di vari gradini e lo divise in tre cappelle, di profondità degradante da nord a sud, con volte a crociera e archi di accesso ogivali. Alle tre cappelle corrispondevano altrettante navate, le laterali per l’ampiezza di due campate, mentre la centrale proseguiva da sola fino a raggiungere il limite segnato dalla facciata della chiesa alto-medievale. L’edificio arnolfiano era coperto da un tetto a capanna sostenuto da capriate, coro transennato al centro ed un ingresso secondario sul fianco settentrionale.
Sette erano le arcate che scandivano gli spazi centrali della basilica: le prime due determinavano le cappelle laterali del presbiterio, la terza richiudeva la grande cappella centrale dell’altare maggiore, la quarta e la quinta definivano in parte le due braccia del transetto, al centro del quale erano collocate le sepolture degli abati, mentre la sesta e la settima concludevano l’allineamento, definivano le due navatelle e la parte centrale del transetto.
La parte absidale esterna è ancora visibile su via del Proconsolo, scandita da cinque lesene che separano quattro strette finestre archiacute, così come è visibile anche la parte superiore della facciata in cui è presente la grande finestra ad occhio posta in asse con il nuovo portale.
La chiesa attuale
Dal 1590 fu presente nella Badia Fiorentina, come monaco, il senese Serafino Casolani, il quale, una volta divenuto abate nel 1624, decise di trasformare completamente la chiesa con il contributo dell’architetto Matteo di Marco Segaloni.
Questo riassetto portò allo stato attuale della chiesa e del monastero: si realizzò un ambiente che vide l’accesso principale divenire quello sul fianco nord, che assunse la funzione di facciata al posto di quella originaria ad ovest, la quale venne chiusa e mimetizzata.
Il transetto della chiesa arnolfiana divenne quindi la navata principale del nuovo edificio, trasformando l’impianto da croce latina irregolare a croce greca perfettamente geometrica, attuando anche un raddrizzamento della parete su via del Proconsolo tramite pilastri in pietra serena. L’altare maggiore venne posto a sud quale divisorio tra l’estremità del braccio della croce ed un nuovo e profondo coro absidato.
Questo capovolgimento di spazi e funzioni rispettò solamente il campanile e il Chiostro degli Aranci.
Tra il 1808 e il 1811 il convento venne soppresso, quasi integralmente abbandonato dai monaci benedettini, e fu, in parte, occupato da scuole, abitazioni, uffici privati e pubblici. La vita monastica all’interno della Badia Fiorentina riprese però nel 1988 grazie a giovani comunità di monaci e di monache provenienti da altri paesi: vi si instaurarono, infatti, le Fraternità apostoliche di Gerusalemme con la loro prima casa in Italia.
Note
[1] G. Villani, M. Villani, F. Villani, Croniche, libro VII, con note di Francesco Dragomanni, Firenze, Sansone Coen, 1845-1847.
[2] M. Frati, De bonis lapidibus cinciis: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo, Firenze, Firenze University Press, 2006, p. 162
Bibliografia
Carrara, F. Facchinetti, La Badia Fiorentina dalla fondazione alla fine del Trecento, a cura di Fulvia Zeuli, Firenze, Edizione Polistampa, 2018
Cocchi, Le chiese di Firenze dal secolo IV al secolo XX, Firenze, 1903
Di Gaetano, Della Badia Fiorentina, Firenze, Tipografia Fratelli Bonechi, 1951
Guidotti, La Badia Fiorentina, Firenze, Becocci Editore, 1982
Leader, Architectural Collaboration in the Early Renaissance. Reforming the Florentine Badia, Journal of the Society of Architectural Historian, Boston, University of Massachussets Boston, 2005, pp. 204-233.
Leader, The Badia of Florence: Arte and Observance in a Renaissance monastery, Indiana University Press, 2011, pp. 138-139
Leader, The Florentine Badia: Monastic Reform in Mural and Cloister, Ann Arbor, Umi Microform 2000
Middeldorf, W. Paatz, Die gotische Badia zu Florenz und ihr Erbauer Arnolfo di Cambio, Mitteilungen des Kunsthistoriches Institutes in Florenz, 1932, pp. 492-517
W., E. Paatz, Die Kirchen von Florenz: ein kunstgeschichtliches Handbuch, Francoforte, Vittorio Kostermann, 1940
Puccinelli, Istoria delle eroiche attioni di Ugo il Grande duca della Toscana, di Spoleto, di Camerino di nuovo ristampata con curiose aggiunte e ricorretta. Con la Cronica dell’Abbadia di Fiorenza, i suoi privilegi pontifii e cesari. Il trattato di circa mille iscrittioni sepolcrali. La Galleria sepolcrale, con l’introduzione con la festa di S. Mauro. Et le momorie di Pescia terra cospicua…del PP. D. Puccinelli, monaco cassinese, Milano, 1664
Salvestrini, P. D. Giovannoni, G. C. Romby, Firenze e i suoi luoghi di culto dalle origini a oggi, Pisa, Pacini Editore, 2017
Uetz, Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fiorentina und ihr Glockenturm: ein Beitrag zur Klarung der alteren Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benedektinerabtei von Florenz 969-1310, Ph. D. University of Bamberg, 2003
SANT’ANNA DEI LOMBARDI PT I
A cura di Ornella Amato
Il complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi
Doveroso un Ringraziamento Speciale all’intero staff operante all’interno del Complesso, anzitutto per la gentilezza e la disponibilità, per aver inoltre fornito materiale storico e per l’autorizzazione alla realizzazione delle immagini fotografiche contenute in questo elaborato.
Raccontare la Chiesa ed il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, vuol dire fare un viaggio nella storia di due città, Napoli e Firenze, nei rapporti economici e culturali che le hanno legate e nelle conseguenze artistiche che ne sono derivate.
La chiesa di Sant’Anna dei Lombardi fu fondata nel 1411 da Gurello Origlia, già protonotario di Ladislao di Durazzo, e inizialmente consegnata agli olivetani, ramo dei benedettini, e per questo dedicata a Santa Maria di Monte Oliveto. L’ampliamento del complesso fu realizzato per volere di Alfonso II d’Aragona, ma il pantheon privato della famiglia era la chiesa di San Domenico Maggiore, che tutt’oggi ne conserva le arche.
Nota ai napoletani semplicemente come “la Chiesa di Monte Oliveto”, da cui deriva anche il nome della piazza su cui si affaccia, il complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi è uno scrigno d’arte e storia, testimonianza del rapporto tra la Napoli aragonese e la Firenze rinascimentale.
Gli artisti che vi lavorarono, quali Antonio Rossellino, Giorgio Vasari, Michelangelo, Benedetto da Maiano, vi giunsero proprio a seguito dei floridi rapporti di natura politica ed economica che si crearono tra le due città. Ne è testimonianza storica anche la scelta del banchiere fiorentino Filippo Strozzi di avere a Napoli alcune delle filiali della sua banca. A tal proposito, è interessante ricordare che proprio a Palazzo Strozzi nel 1901 è stata rinvenuta una tavola raffigurante la Napoli del ‘400 e denominata Tavola Strozzi - attualmente conservata a Napoli al Museo di San Martino – realizzata come dono del banchiere al re Ferrante d’Aragona.
Tornado al complesso di Sant’Anna, la particolarità della doppia denominazione è legata ad un evento estremamente significativo. Nel 1582 la chiesa venne edificata su un terreno adiacente di proprietà degli stessi olivetani ma, gravemente danneggiata nel 1789 a seguito di un crollo, la chiesa passò allo Stato borbonico dopo la soppressione nel 1799 dell’ordine degli olivetani. Nel 1801 Ferdinando IV di Borbone la concedeva ai lombardi, riprendendo quindi la denominazione precedente della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, la cui primitiva costruzione fu completamente demolita dopo il terremoto del 1805.
L’esterno
Già sulla facciata esterna della chiesa si riscontrano elementi di rimando al rinascimento fiorentino e al tardogotico napoletano, ma è da segnalare che gran parte di essa è stata ricostruita ex-novo a seguito dei danni subiti durante i bombardamenti del marzo 1944.
Lo spazio su cui fu innalzata la struttura apparteneva ai monaci benedettini – ordine a cui gli olivetani appartengono – e si trattava di uno spazio estremamente vasto, tanto da comprendere ben quattro chiostri. Attualmente si trova al centro della città, ma in principio era distante dall’area centrale e attorno alla struttura oggi sorgono il Palazzo delle Poste e la Caserma dei Carabinieri ‘Pastrengo’.
L’interno della chiesa di Sant'Anna dei Lombardi
L’interno è enorme se si considera l’intera struttura del complesso, ma l’area esclusivamente dedicata alle celebrazioni non è particolarmente grande, sebbene già in primis racconti tutta la complessità della storia della struttura stessa.
Entrando in chiesa, infatti, basta voltarsi verso la controfacciata per scoprire l’organo contornato con gli affreschi raffiguranti Angeli realizzati da Battistello Caracciolo, di stampo seicentesco. Ai lati del portone d’ingresso, in maniera simmetrica e speculare, sono collocati due altari marmorei rinascimentale: uno ad opera di Giovanni da Nola, per la Famiglia Ligorio, l’altro di Girolamo Santacroce per la Famiglia Del Pezzo.
Il loro schema compositivo è estremamente semplice: basamento e struttura superiore con pala d’altare tripartita. Sono realizzati completamente in marmo e nella parte superiore presentano la Vergine con il Bambino e nicchie laterali coi santi.
Voltandosi verso l’altare, lo sguardo del visitatore corre verso la navata unica, su cui si affacciano le cappelle, e sulla pavimentazione che custodisce diverse lapidi terragne[1] .
Alzando lo sguardo in maniera lenta ma a velocità costante, come se con una macchina da presa il migliore dei registi volesse dare profondità e stupore allo spettatore creando una scena con un taglio unico e volto a sorprendere chi osserva, lo sguardo resta sorpreso dal soffitto cassettonato. Questo tuttavia non è l’originale, ma una ricostruzione a seguito della distruzione del primo durante i bombardamenti subiti dalla struttura nella Seconda guerra mondiale. L’attuale soffitto è realizzato con uno stile considerato più contemporaneo, presentando degli ottagoni e ricordando solo lontanamente il soffitto a cassettoni lignei originale; cattura e monopolizza lo sguardo del visitatore, sebbene sembri contrastare con la struttura che presenta diversi stili – dal gotico al barocco – a testimonianza della storia e dei rimaneggiamenti subiti.
Purtroppo, a seguito dei bombardamenti patiti tra il 13 ed il 14 marzo del 1944, molto è andato perduto o modificato: il bombardamento interessò la facciata, il campanile (completamente perduto, ma del quale resta la campana) ed il vestibolo. Stessa sorte subirono i monumenti funebri laterali alla porta: quello di Domenico Fontana è stato ricomposto e ricollocato; dell’altro, eseguito da Giuseppe Trivulzio, si sono perse completamente le tracce anche se si avevano notizie di suoi frammenti fino al dopoguerra.
L’altare attuale è tardo seicentesco, voluto dall’abate Chiocca che è stato colui che ha operato maggiormente nell’ambito di una vera e propria ristrutturazione all’interno della chiesa e che volle sostituire quello precedente. In particolare, è a lui che si devono i rimaneggiamenti barocchi nell’opera realizzata dai fratelli Ghetti, su disegno di Gian Domenico Vinaccia. Nella parte frontale presenta inserti di marmo policromo, tipici del barocco; interessante è il rilievo marmoreo raffigurante la Lavanda dei piedi, probabilmente recuperato dalla struttura d’altare precedente, come sostiene una parte della critica attribuendola a Giovanni da Nola.
La parte posteriore, invece, è organizzata in tre ordini verticali separati da lesene sormontate da un fregio e teste di cherubini.
La pala che lo adorna raffigura L’educazione della Vergine ed è stata eseguita da Angelo Mozzillo nel XIX secolo. Ai suoi lati due lastre di marmo tramandano i nomi dei fondatori della chiesa: Gorello Origlia e Alfonso d’Aragona.
Nella zona presbiterale, alle spalle dell’altare, è presente anche un coro ligneo in due ordini di stalli e databile entro il 1525.
Le cappelle e la Sagrestia di Sant'Anna dei Lombardi
La chiesa è caratterizzata dalla presenza di dieci cappelle laterali, cinque per lato, a pianta centrale e che si affacciano sulla navata.
Tra le cappelle più interessanti ricordiamo il Cappellone del Santo Sepolcro e la Cappella Lannoy con il Compianto sul Cristo Morto, il cui realismo delle statue è davvero impressionante: i volti disperati e piegati dal dolore, le bocche aperte a mostrare la dentatura, quasi come se stessero gridando il loro dolore, fanno da contorno al Cristo morto.
Anche la Cappella Piccolomini, voluta dal Duca di Amalfi Antonio Piccolomini e realizzata da Antonio Rossellino, in cui riprende temi già utilizzati a San Miniato al Monte a Firenze ma adattandoli ai gusti dei committenti e della corte d’Aragona.
Infine si ricorda la Cappella Correale a cui lavora Benedetto da Maiano, uno degli scultori maggiormente apprezzati a Firenze, che qui si dedica in particolare alla realizzazione dell’altare marmoreo dell’Annunciazione. Sulla cima si trovano due Spiritelli reggi festone e quello di destra è stato attribuito alla mano del quattordicenne Michelangelo Buonarroti.
Nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, architettori italiani da Cimabue a’ tempi nostri scritte da Giorgio Vasari, pubblicate per la prima volta nel 1550, Michelangelo Buonarroti è descritto come il primo artista in assoluto e Vasari lo racconta utilizzando parole estremamente lusinghiere, probabilmente dettate dall’ammirazione che l’autore nutriva per il grande artista. Proprio per la medesima chiesa dove probabilmente da ragazzino Michelangelo realizzava lo spiritello della cappella Correale, il Vasari stesso si ritrovò a lavorare nella Sagrestia, come dimostrano gli affreschi dell’ex Refettorio noto oggi come la sagrestia vasariana.
Un aneddoto racconta che il Vasari, giunto a Napoli, dopo aver visto la sala da affrescare si sarebbe rifiutato data la scarsità dell’illuminazione e per la presenza di una struttura gotica – che lo stesso Vasari rifiutava - ma avrebbe accettato realizzando quindi gli affreschi, poiché convito dal suo protettore Miniato Pitti.
La Cripta
La Cripta detta “degli abati” è uno degli ambienti “nascosti” dell’intero complesso. Un luogo di sepoltura all’interno del quale si segnalano scolatoi senza seggiolino[2] e teschi inseriti in piccole teche. Di essa si segnalano gli affreschi con la scena della Crocefissione perfettamente conservati.
Arte e scultura contemporanea: Jago
Il complesso ospita spesso mostre e soprattutto artisti contemporanei, in particolare qui sono esposte due opere marmoree di Jago (Jacopo Cardillo), noto per la Pietà esposta alla Chiesa degli Artisti a Roma, per il bambino di Look Down in piazza del Plebiscito a Napoli. In Sant’Anna dei Lombardi troviamo il Muscolo Minerale, esposto al centro della Cappella Piccolomini su di un espositore che ne consente la visione completa, e Reliquia, posta invece sull’altare della sagrestia del Vasari.
Monteoliveto, come semplicemente la chiamano i napoletani, è un percorso storico, artistico e culturale, presente nel circuito di “campaniartecard”. È testimonianza d’eccellenza delle conseguenze dei rapporti che si instaurarono tra coloro che scrissero la storia a partire dai secoli del Rinascimento, fino ai giorni nostri, ma guardando al futuro, aprendosi ad esso non solo attraverso le mostre di arte contemporanea che ospita, ma soprattutto tramite le sculture di Jago che creano un connubio unico, un legame che diventa inscindibile.
Crediti e riferimenti fotografici
Le immagini inserite in questo elaborato sono state realizzate dall’autrice su autorizzazione dello Staff del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli; per quelle di cui si riportano i crediti nelle rispettive didascalie, sono tratte da wikimedia commons.
Note
[1] sepolture avvenute tra il ‘400 ed il’500 di tipo araldico – epigrafico, appartenenti a personaggi che si distinguono dalla popolazione comune, ma non appartengono a ranghi particolarmente elevati.
[2] La scolatura era una pratica utilizzata spesso a Napoli nel Seicento.
Sitografia
PAOLO GAMBA PITTORE NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO AD AGNONE
A cura di Marco Bussoli
Pensando al Molise è difficile, per i più, riuscire a pensare ad un monumento di interesse culturale, ma ancor più complesso, anche per gli addetti ai lavori, individuare degli artisti che, nel passato, abbiano fatto centro della loro produzione artistica questa regione. Uno dei pochi artisti del passato di cui si può trovare una traccia è Paolo Gamba, pittore del XVII secolo, la cui produzione artistica è quasi tutta locata tra il Molise e le zone limitrofe di Abruzzo e Puglia.
Paolo Gamba: notizie, lacunose, sulla vita
Della vita del pittore Paolo Gamba si sa ben poco dalle fonti documentarie. Tuttavia, è possibile ricostruire il suo percorso grazie al censimento delle sue opere. Nato a Ripabottoni, oggi in provincia di Campobasso, nel 1712, il pittore è figlio di Giovan Battista Gamba, un decoratore di modeste capacità le cui opere sono visibili a Sulmona e Pescocostanzo (AQ).
A soli 20 anni, il pittore sposa Domenica Ciarla e, secondo una notizia che in molti riportano, si trasferisce a Napoli per studiare nella bottega del pittore Francesco Solimena. Il soggiorno, che non trova riscontro nelle fonti archivistiche, è ipotizzato solo sulla base dell’analisi stilistica delle sue opere, che aderiscono a forme scenografiche e luministiche ricorrenti nel barocco napoletano; è però vero che queste forme erano già diffuse nelle zone periferiche del regno, tant’è che lo stesso Solimena aveva lavorato per la parrocchiale di Ripabottoni, dove una sua tela è conservata.
La prima opera di Gamba è datata al 1740, e consiste in una serie di affreschi, oggi distrutti, in Sant’Elia a Pianisi (CB). Da questo momento, il pittore inizia un’intensa attività, soprattutto grazie al rinnovamento voluto dai Vescovi di Larino, che non solo commissionano gli affreschi nella cupola della chiesa di San Francesco a Larino, ma gli affidano anche lavori in numerose chiese della provincia, tra cui le pitture nella parrocchiale di S. M. Assunta a Ripabottoni, riedificata sul progetto di Ferdinando Sanfelice tra il 1731 ed il 1744.
A partire dagli anni Sessanta, iniziando a diradarsi le commissioni molisane, l’attività del pittore si sposta verso l’Abruzzo e la Capitanata. Quando, alla fine del decennio, Gamba torna a lavorare in Molise, è attivo dal 1771 nella chiesa di San Francesco di Agnone e da lì, negli anni successivi, fino alla morte sopraggiunta nel 1782, nelle chiese di Fossalto e Campodipietra.
Agnone
Tra i comuni molisani quello di Agnone gode, non solo oggi, di un certo rilievo; se, infatti, continua ad essere meta turistica è per il suo borgo, per la Pontificia Fonderia Marinelli, una delle poche fonderie al mondo che produce campane con il bollo papale, e per i tipici prodotti enogastronomici. Se la fondazione del borgo è dibattuta, ma sicuramente sannitica, resta molto evidente il passaggio, nel XIV secolo, dei veneziani, che fondano il cosiddetto borgo veneziano, in cui la persistenza dei simboli della serenissima è forte (basti pensare alla chiesa intitolata a San Marco, nel cui portale è raffigurato un leone).
Attraversando le strade del borgo, la struttura medievale dell’abitato che si pone sulla cresta del colle e che lì si sviluppa, almeno in una prima fase, risulta ben leggibile. I segni di questo sviluppo sono tangibili nell’orditura dei camminamenti e nel presidio cittadino che rappresentano gli edifici religiosi, numerosi e uniformemente distribuiti già dall’antichità, come segnala, tra gli altri, Mortari.
La chiesa di San Francesco
La chiesa ed il convento di San Francesco sono, tra gli edifici di Agnone, quelli che, forse, presentano in modo evidente i maggiori segni di un passato che in Molise, a seguito dei numerosi eventi sismici, non è sempre così leggibile. Nella facciata della chiesa è, infatti, ben evidente il fronte della chiesa trecentesca, con l’apertura ad ogiva, decorata, ed un rosone in sommità. Caratteristica del rosone è la cornice decorata, scolpita con un motivo di foglie in rilievo tra due fasce lisce, cui si aggiunge una decorazione semicircolare nella parte superiore, più sporgente e rilevata, ma pur sempre estremamente semplificata, che termina su due colonnine dal capitello decorato con volute semplificate che nascono dal basso. Queste, poi, poggiano su ognuna rispettivamente su un leone, segno del passaggio veneziano in questi territori. Anche il portale è decorato con elementi molto semplificati: la strombatura del portale è sottolineata da tre semicolonne ed una sorta di pilastro, con un unico abaco che lega tutti i capitelli tra loro.
Come nelle colonnine del rosone, anche qui i capitelli hanno pochi elementi decorativi, un singolo giro di foglie d’acanto, che in alcuni casi si avviluppano nella parte alta, formando delle volute, mentre nella prima semicolonna sono ben aperte. La decorazione dell’ogiva, in linea con quella della parte bassa, è molto lineare, con una serie di modanature geometriche di diversa forma; tra queste fa eccezione una fascia che si articola con due spirali lisce e, tra queste, una fascia piana con una larga spirale che accoglie un motivo di foglie lobate.
Da quanto attestano i documenti presenti in archivio, la fondazione dell’edificio risale al 1343, anno in cui probabilmente ebbe inizio la costruzione del primo edificio religioso e del monastero. Tra XVII e XVIII secolo il complesso fu completamente trasformato, e la chiesa adattata alle prescrizioni controriformistiche. Non è ben chiaro, dalle fonti disponibili, se fu in questa fase che la chiesa venne ingrandita. Tuttavia, resta il fatto che, a partire dal ‘600, vennero eseguiti dei lavori per ottenere una chiesa a navata unica con cappelle ed altari laterali. Nello stesso periodo, il Padre Maestro Antonio Fiorito commissionò il rifacimento del campanile in muratura, mentre la cupola fu innalzata alcuni decenni dopo, per volere di Padre Maestro Nicolò Palombo.
Gli affreschi di cupola e transetto
Quando nel ‘700 il complesso di San Francesco venne rinnovato, furono chiamati i più prestigiosi artisti sulla piazza per decorarne gli interni: oltre che configurarsi come un esempio di architettura controriformistica, la chiesa è anche d’esempio per le decorazioni stuccate, in stile roccocò, che arricchiscono l’aula, riempiendo lo spazio senza eccedere nell’horror vacui, ma diventando cornice, anche effettiva, per gli altri elementi decorativi. In questo ambiente così ricco opera Paolo Gamba, che con i suoi affreschi porta del colore nella candida chiesa.
Pescando dai temi maggiormente praticati durante la sua attività, Gamba programmò, per le decorazioni della cupola, delle pitture di carattere puntuale, mentre in quelle della navata due grandi scene incorniciate dagli stucchi. Il tamburo della cupola è diviso in otto porzioni da un partito architettonico di lesene binate, che portano una trabeazione semplificata che, in corrispondenza delle finestre, si deforma curvandosi. A fasce alternate sono, quindi, presenti nel tamburo delle aperture o degli affreschi, in particolare degli ovoli in stucco bianco e dorato che racchiudono i ritratti di quattro profeti. Le figure di Amos, Giona, Daniele e Geremia, scelte tra i profeti della Bibbia, occupano quasi interamente lo spazio dell’ovulo in cui sono poste. Nonostante ciò, il pittore si è dimostrato perfettamente in grado di caratterizzare lo sfondo, lasciando dei segni caratteristici per ognuno di essi; Giona, ad esempio, è rappresentato incappucciato, quasi pensoso, e lascia sullo sfondo un mare calmo con il mostro marino in lontananza.
Nei pennacchi che sorreggono la cupola sono invece racchiuse le rappresentazioni dei quattro Evangelisti, uno dei temi cari del pittore, che li ripropone in più occasioni con l’accuratezza e la finezza di approfondirne i caratteri sia pittorici che espressivi; queste figure, infatti, sono assolutamente paragonabili a quelle analoghe affrescate a Larino (CB), nella chiesa di S. Francesco, ma ad un’analisi più attenta spiccano per un chiaroscuro più accentuato, anche grazie all’uso di una luce più vibrante che manca al disegno dei profeti. Curioso è un dettaglio contenuto nel San Marco, che ha ai piedi due putti: uno di questi, che regge penna e calamaio per l’evangelista, sembra ammonire l’altro, che è invece impaurito dal leone su cui il santo poggia i piedi. Oltre agli Evangelisti, nel transetto sono anche presenti figure minori di virtù, anche queste affrescate entro sottili cornici che decorano le ghiere sotto gli archi.
Gli affreschi della navata
La navata di San Francesco è dominata dalla presenza di un grande affresco che, entro una cornice mistilinea, tipicamente settecentesca, ne costituisce il fuoco, l’elemento su cui l’occhio si poggia inevitabilmente, soprattutto poiché è l’unico elemento colorato all’interno dello spazio bianco.
La scena che Gamba dipinge è quella della Cacciata agli inferi degli angeli ribelli. Il pittore, con una caratterizzazione differenziata, dispone la scena su due registri differenti: in alto, ovvero verso l’ingresso, Dio è tra gli angeli e la croce gli è vicina, mentre poco più in basso l’arcangelo Michele e gli altri angeli stanno scacciando Lucifero ed i ribelli, che sono già caduti; Lucifero si è schiantato a terra e giace con la schiena sulla roccia. L’artista ambisce qui, secondo Carano, a raggiungere gli esiti luministici e drammatici del suo maestro, Francesco Solimena, che lavorava però con toni e colori più scuri, riuscendo in un luminismo più spiccato. Questa scena risulta, però, molto equilibrata nella sua transizione progressiva tra la luce del paradiso e il buio della terra. Nell’affresco Gamba ambienta le scene più concitate nelle zone centrali: ai piedi della divinità è posto un altare, ancora sulle nuvole, ed un angelo, nei suoi pressi, sventola l’incenso, immediatamente più in basso, invece, sta avvenendo il combattimento, con la figura alata di Michele che brandisce la croce.
Sull’ingresso si trova un affresco, più piccolo e anch’esso inserito in una cornice mistilinea, che raffigura quattro angeli seduti sulle nubi in una situazione di pace: tre di essi stanno infatti suonando, mentre l’ultimo sta leggendo e cantando. Anche in questo caso la luce è poco vibrante, motivo per cui risulta estremamente evidente la rigidezza delle nubi sui cui si poggiano le figure. Questo affresco è inoltre gravemente danneggiato, con una lacuna che ne sfigura la parte centrale.
La chiesa di San Francesco ad Agnone è un edificio particolarmente apprezzabile sotto numerosi punti di vista, tra i quali spicca il ruolo centrale per la comunità (l’edificio conventuale è infatti sede di due biblioteche e comprende anche un piccolo spazio per l’esposizione di materiali). A ciò si aggiunge il pregio di una decorazione che, se non unica, rappresenta il punto di arrivo e di maturazione della poetica di un pittore unico, per prolificità ed esiti, nel territorio molisano. Quello che manca è, però, oltre ad una valorizzazione adeguata della chiesa, uno sguardo approfondito sulla figura di Paolo Gamba, artista su cui non si compiono più studi ormai da decenni.
Bibliografia
Carano, Paolo Gamba, pittore molisano del XVIII sec., Campobasso, 1984
Basile, Interventi di conservazione e di restauro sui beni artistico-storici, in Conoscenze, III (1986)
Mortari, Molise, appunti per una storia dell’arte, Roma, 1984
Sitografia
https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-gamba_(Dizionario-Biografico) (10-12-2021)
https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/museo-civico-di-palazzo-san-francesco-ad-agnone (17-12-2021)
ANTONELLO DA MESSINA E I RAPPORTI CON LA PITTURA FIAMMINGA
A cura di Beatrice Cordaro
Introduzione. Antonello da Messina, i fiamminghi e la pittura ad olio
L’artista: brevi cenni biografici
Nato a Messina nel 1430, poco si sa delle vicende biografiche di Antonello, ma sappiamo quanto basta per confermare la grandezza del suo operato in epoca rinascimentale. Antonello, menzionato in un contratto del 1438 nel quale si impegnava a lavorare per un conciatore di pelli, si formò come pittore a Roma (dove per Vasari aveva “atteso molti anni al disegno”) e poi a Napoli (inizio degli anni ’40) presso la Bottega di Colantonio, e successivamente ebbe modo di entrare in contatto con l’arte nordica (fiamminga e provenzale), dalla quale trasse un atteggiamento attento alla natura e alla rappresentazione meticolosa dei suoi dettagli e sfumature. Le prime commissioni risalgono alla fine degli anni ’50 del ‘400, momento in cui Antonello è attestato a Reggio Calabria. Al marzo del 1457 risale infatti un documento con cui Antonello, “pictor civis Messane”, si impegna a consegnare uno stendardo da parte del maestro della confraternita di San Michele dei Gerbini di Reggio Calabria.[1] Nei tre anni di silenzio delle fonti che separano la commissione reggina da un secondo soggiorno calabrese (1460), gli storici dell’arte (Cavalcaselle) hanno ipotizzato un viaggio di Antonello nel centro Italia, nel corso del quale il maestro sarebbe entrato addirittura in contatto con Piero della Francesca[2]. Gli anni tra il 1460 e il 1470, anche se la seconda parte del decennio si contrassegna per una totale assenza di documentazione sull’artista, furono fruttuosi in termini di fama, e Antonello ricevette numerose importanti commissioni conoscendo, sia direttamente che indirettamente, la cultura pittorica delle Fiandre (Petrus Christus, Jean Fouquet) e il suo portato più rivoluzionario, la pittura ad olio. Tra il 1471 e il 1472, poi, Antonello fu particolarmente impegnato a Noto, cittadina dove, per la chiesa di Santo Spirito, di un altro gonfalone e dove ebbe modo anche di confrontarsi con il pittore Francesco Laurana. Nel 1473 è ancora a Messina, per poi spostarsi a Venezia intorno al 1475. Dopo l’esperienza in laguna, Antonello tornò in Sicilia, e morì nella sua città natale, Messina, nel 1479. Come sembrano indicare le richieste precedenti alla sua dipartita, il pittore venne sepolto presso il cimitero del convento di Santa Maria del Gesù, vestito con il saio dell’ordine dei frati minori francescani. Il cimitero venne distrutto dalla piena del 1863.
Un appunto su Jan Van Eyck e sulla pittura ad olio quattrocentesca
Considerato a buona ragione il principe indiscusso del primo rinascimento nordico, Jan Van Eyck fu l’artista che impresse alla pittura una svolta radicale, epocale, riuscendo a rinnovarla profondamente, soprattutto dal punto di vista della rappresentazione del reale. Pur in chiave diversa, l’impatto di Jan van Eyck nelle Fiandre può essere paragonato a quello con cui il giovane Masaccio (1401-1428) cambiò la storia dell’arte italiana. Van Eyck riportò in auge una tecnica, quella della pittura ad olio, che pure era già attestata negli scritti di Teofilo e in quelli di fine Trecento di Cennino Cennini[3]. Vasari, nella vita di Antonello, scriveva proprio di come Van Eyck
“si mise a provare diverse sorti di colori, e come quello che si dilettava dell’archimia, a far di molti olii per far vernici et altre cose, secondo i cervelli degl’uomini sofistichi come egli era”[4]
e di come, al termine delle sue sperimentazioni,
“alla fine trovò che l’olio di seme di lino e quello delle noci, fra tanti che n’aveva provati, erano più seccativi di tutti gl’altri”[5]
La riscoperta della pittura ad olio, che rispetto alla tempera con leganti proteici (albume d’uovo) impediva l’opacizzazione del pigmento con l’essiccazione, fu dunque decisiva per le sorti dell’arte occidentale.
Antonello da Messina e la pittura fiamminga
Fu ancora Giorgio Vasari a testimoniare con fermezza l’affinità tra la pittura di Antonello e quella fiamminga. Sempre nella vita del maestro messinese, lo storico aretino trattò parlò di Antonello da un lato come allievo di Jan Van Eyck, dall’altro come maestro inventore e, di conseguenza, portatore in Italia della magnifica pittura ad olio. Per lo storico aretino, infatti, Antonello, dopo aver osservato a Napoli una “tavola di mano di Giovanni da Bruggia”[6], dipinta a olio, partì per le Fiandre, dove, “in Bruggia pervenuto prese dimestichezza grandissima col detto Giovanni”. Alla morte del maestro, Antonello “se ne tornò di Fiandra per riveder la sua patria”.
La ritrattistica di Antonello Da Messina venne considerata, e lo è tutt’ora, una pittura rivoluzionaria, e le forti ascendenze fiamminghe portarono, nel Cinquecento, anche esperti come il veneziano Marcantonio Michiel (1484-1552), collezionista e studioso d’arte, ad attribuire il San Girolamo nello studio (Fig. 1) proprio allo stesso van Eyck, e non ad Antonello.
Il San Girolamo è un dipinto ad olio su tavola di tiglio. Si tratta di un dipinto la cui realizzazione pare, effettivamente, essere figlia di un’opera similare di van Eyck (Fig. 2) e facente parte del perduto Trittico Lomellini. In realtà l’opera di Antonello, nella sua composizione e nei suoi volumi, si pone nettamente in contrasto con il lavoro di Jan Van Eyck nel quale, come si può ben vedere, sono totalmente assenti la sapiente orchestrazione prospettica e la dettagliata architettura proposte invece da Antonello. I punti di contatto con la cultura fiamminga tuttavia ci sono, e si ritrovano nel sapiente uso della luce, che sembra propagarsi da una molteplicità di punti. Ancora di gusto fiammingo è poi la ricchezza dei dettagli che ornano il contesto entro cui San Girolamo agisce: dagli animali alle piante, passando per i vasi sparsi in primo piano e sulla scaffalatura alle spalle del santo, o ancora per le piastrelle a motivi geometrici.
Nell’opera di Antonello, Girolamo è osservabile dall’esterno, e nello specifico da una grande porta culminante in un arco ribassato. Incredibile è il talento di Antonello Da Messina nel ricreare un ambiente realista, all’interno del quale lo sguardo dello spettatore, lungi dal fermarsi alle figure in primo piano, riesce ad andare oltre l’ambiente dello studio spingendosi oltre i vetri di una finestra che si apre al paesaggio.
Note
[1] M. Bussagli, Antonello da Messina, p. 16.
[2] Ivi, p. 23.
[3] Ivi, p. 14.
[4] G. Vasari, Le Vite, p. 375.
[5] Ibidem
[6] Ivi, p. 377.
Bibliografia
Maria Francesca Alberghina, Fernanda Prestileo, Salvatore Schiavone, IRR and XRF investigations on Annunciata by Antonello da Messina to trace the original appearance of the blue veil, in “Archeomatica”, 1, pp. 22-27.
Federica Ammiraglio (a cura di), Van Eyck, I classici dell’arte, Rizzoli / Skira, 2004, p. 21.
Giulio Carlo Argan, Il Rinascimento, Sansoni per la scuola, 2015, p.223.
Gioacchino Barbera (a cura di), Antonello da Messina. Sicily’s Renaissance Master, New York, Metropolitan Museum of Art, 2005.
Marco Bussagli, Antonello da Messina, “Art Dossier”, Milano, Giunti, 2014.
Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa (a cura di), Antonello da Messina, catalogo della mostra al palazzo Reale di Milano, Milano, Skira, 2019.
Claudia Cieri Via, The invisible in the Visible. The Annunciation by Antonello da Messina from narrative to icon, in “IKON. Journal of Iconographic Studies”, vol. 9, 2016, pp. 261-268.
Mauro Lucco (a cura di), Antonello da Messina, l’opera completa. Antonello da Messina e la pittura fiamminga, Milano, Silvana Editoriale, pp 27-41.
Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti (1568), Torino, Einaudi, 2000.
Sitografia
https://www.frammentiarte.it/2014/antonello-da-messina/
https://www.finestresullarte.info/arte-base/antonello-da-messina-vita-opere-pittore-siciliano
https://www.analisidellopera.it/antonello-da-messina-vergine-annunciata/
https://www.balarm.it/news/magazine/al-museo-salinas-i-capolavori-di-antonello-4851
https://www.foliamagazine.it/annunciazione-rinascimento/#:~:text=Nel%20Quattrocento%2C%20la%20scena%20dell,personaggi%20principali%2C%20Maria%20e%20Gabriele.