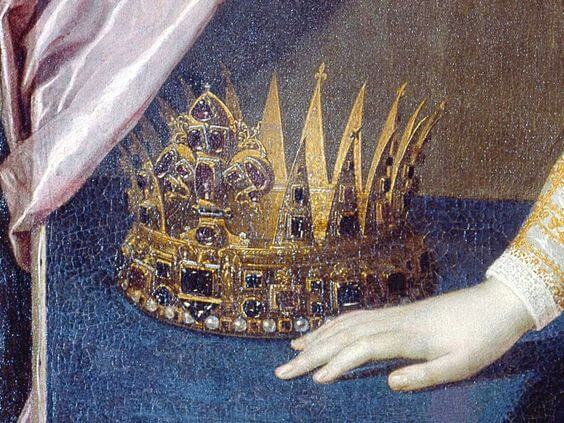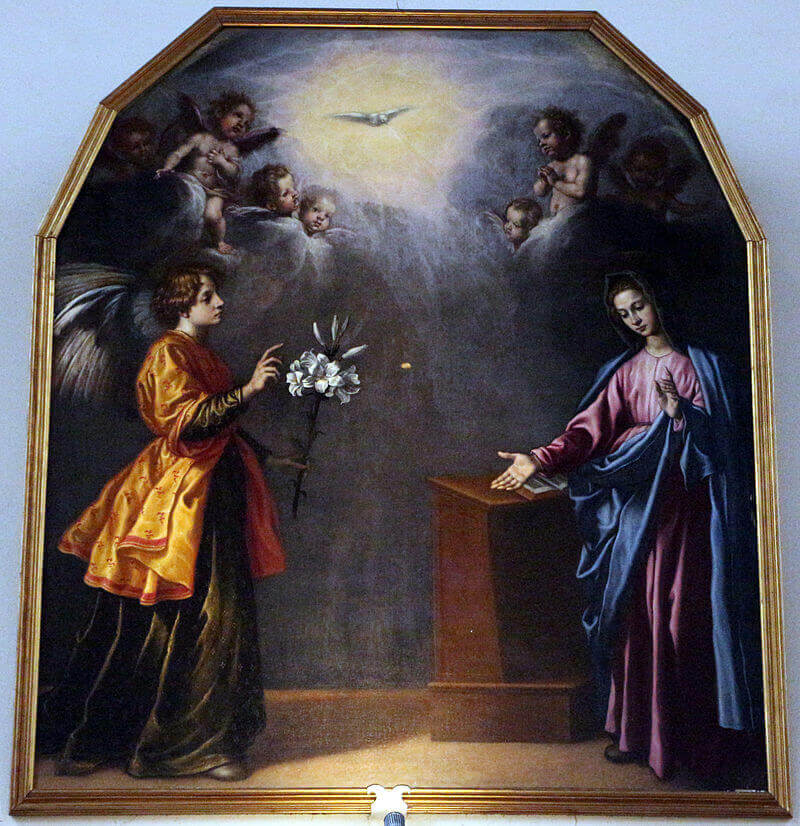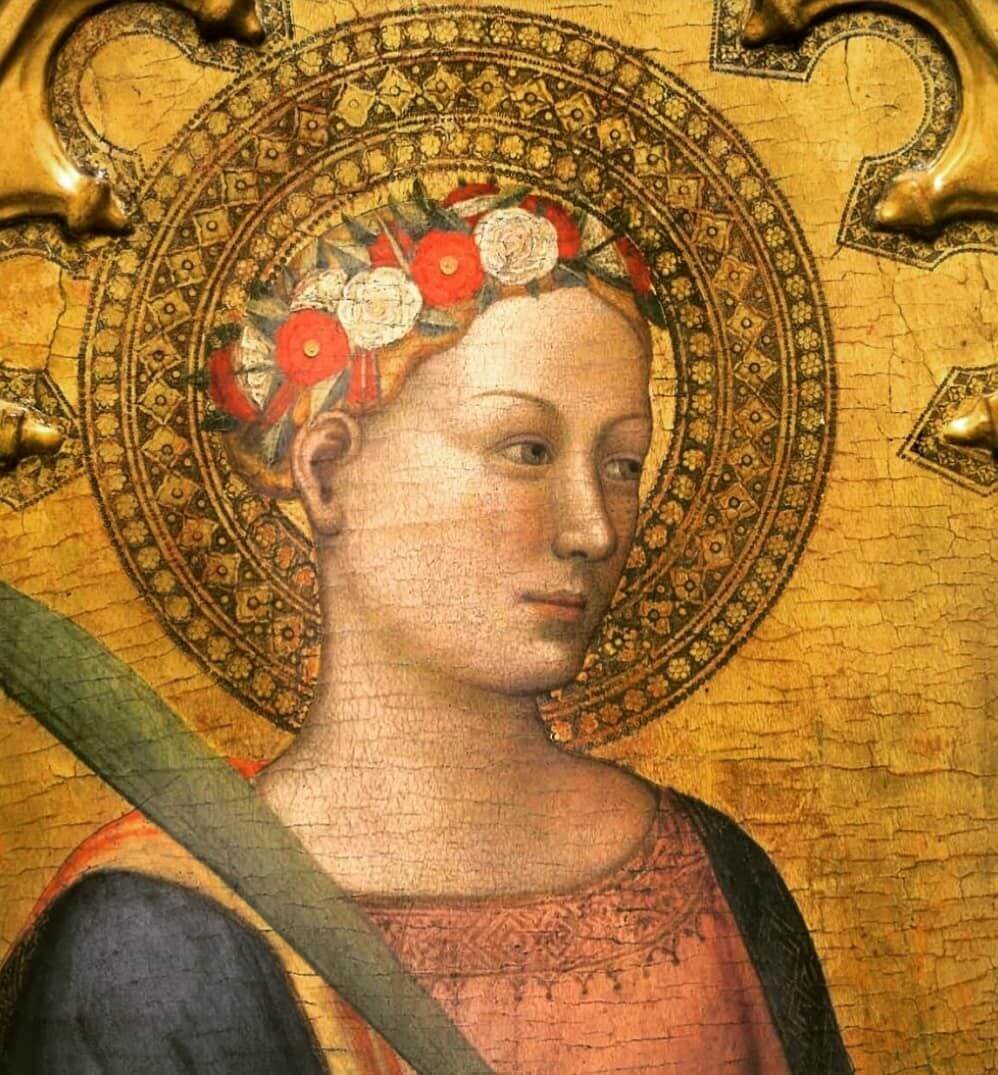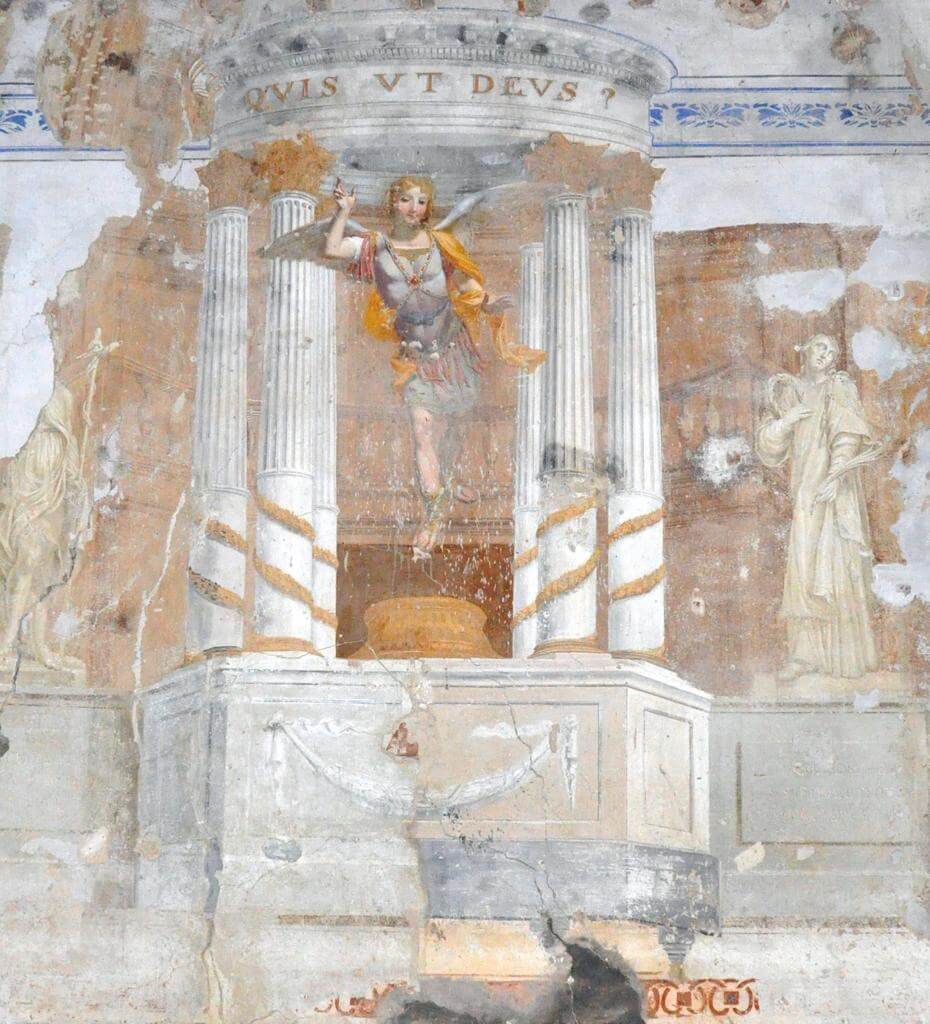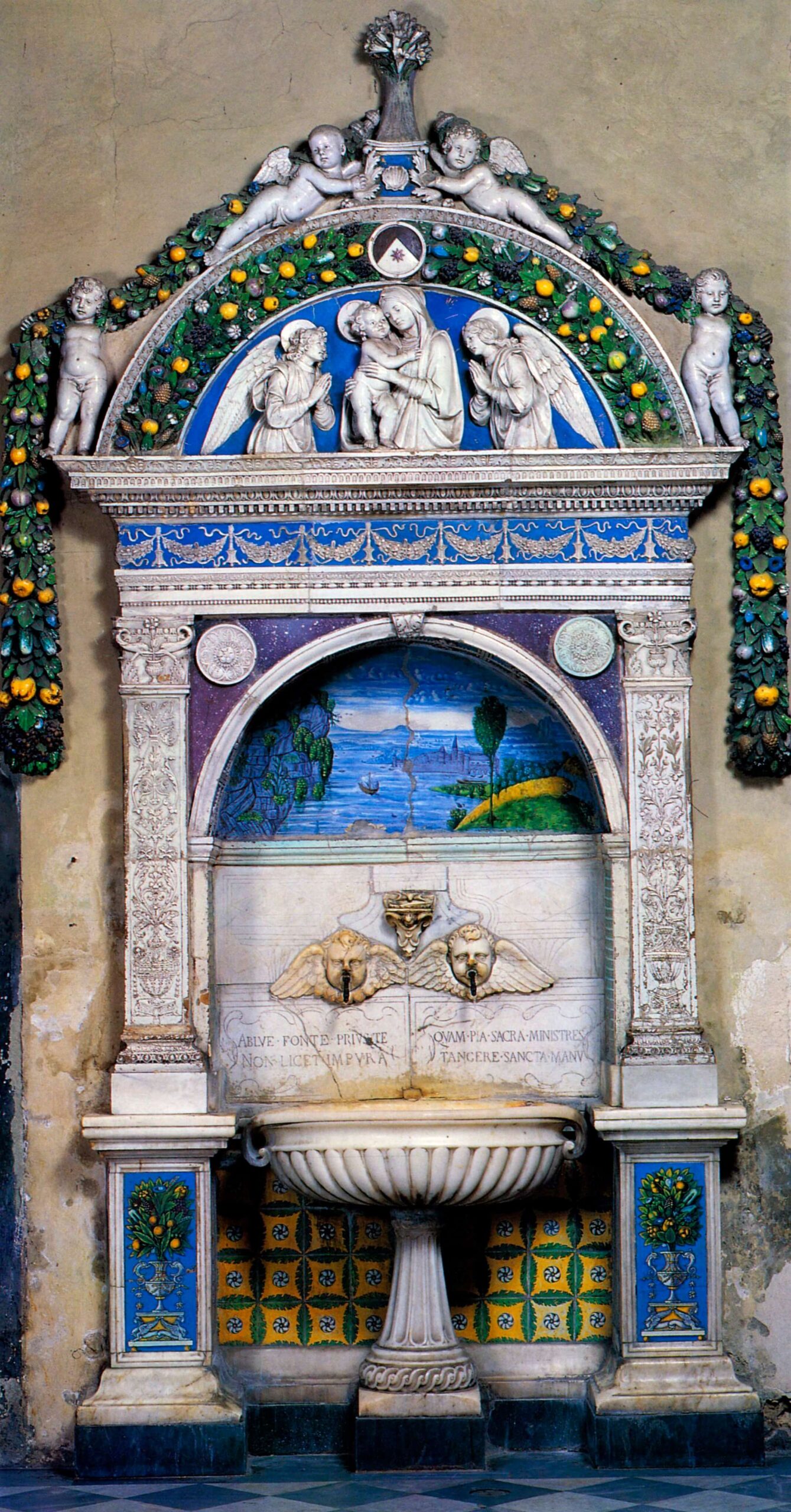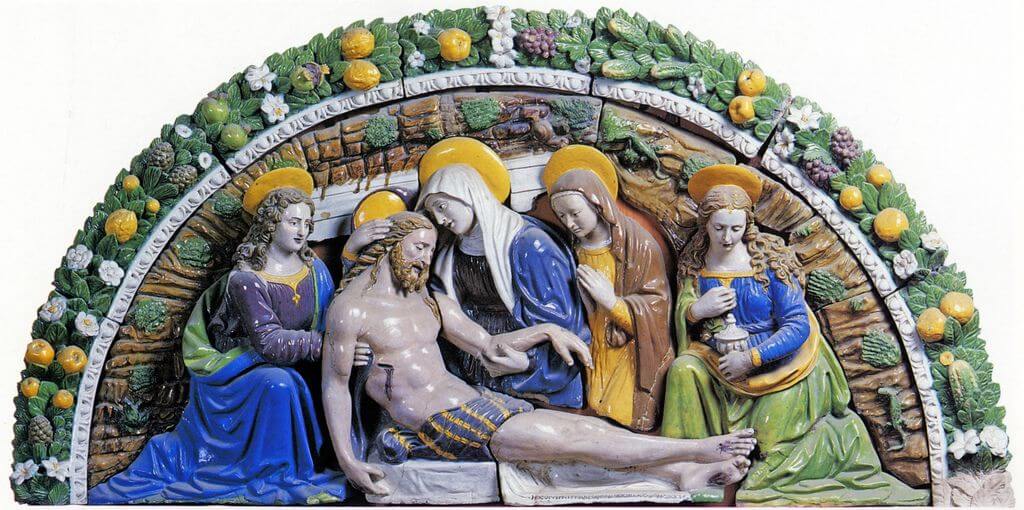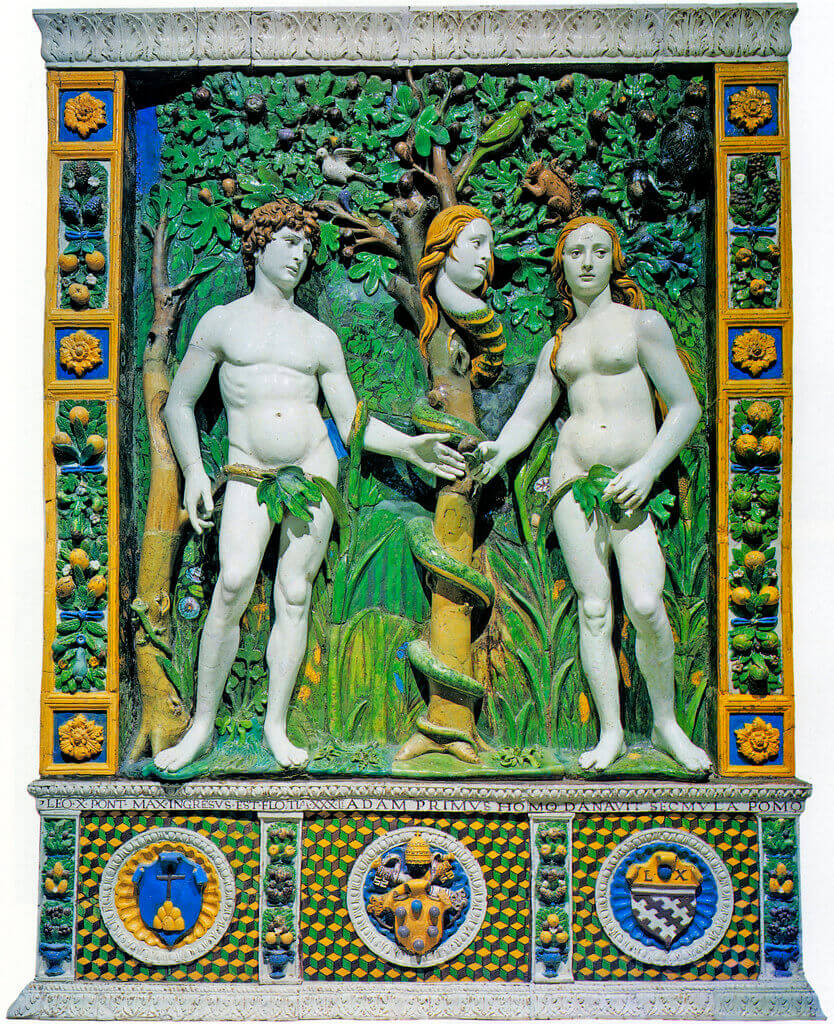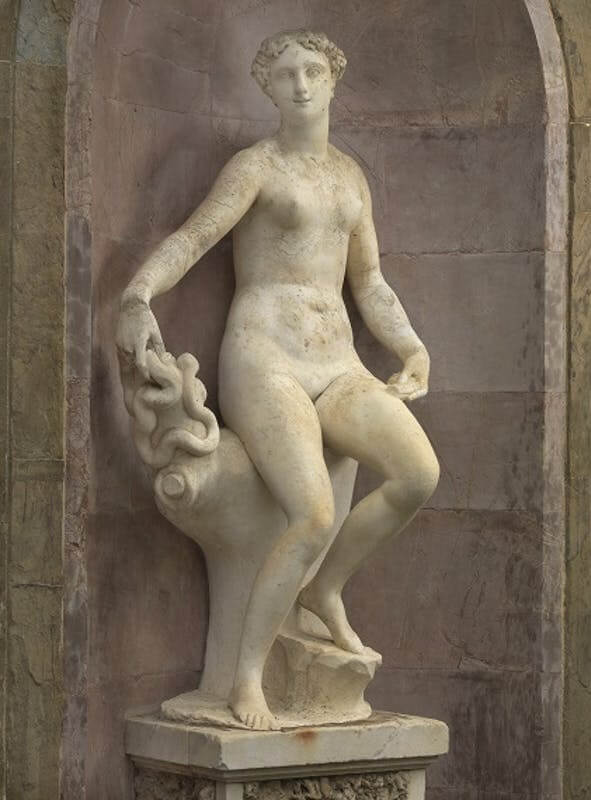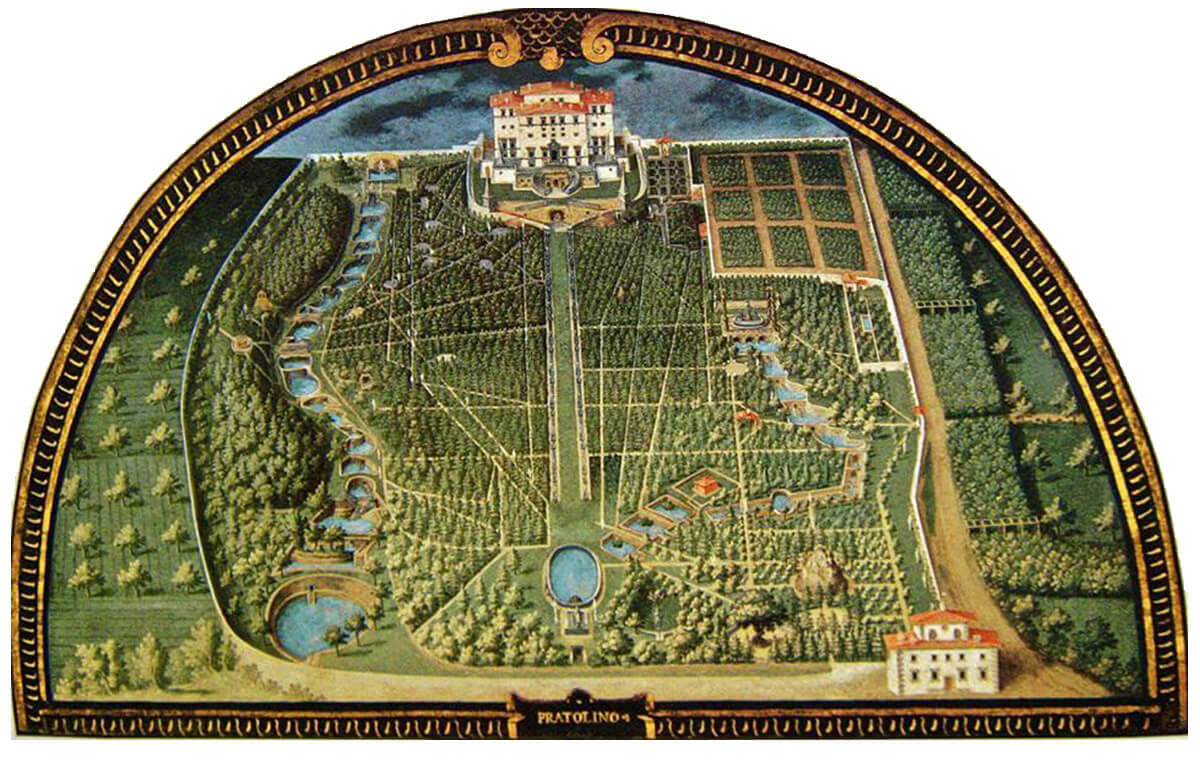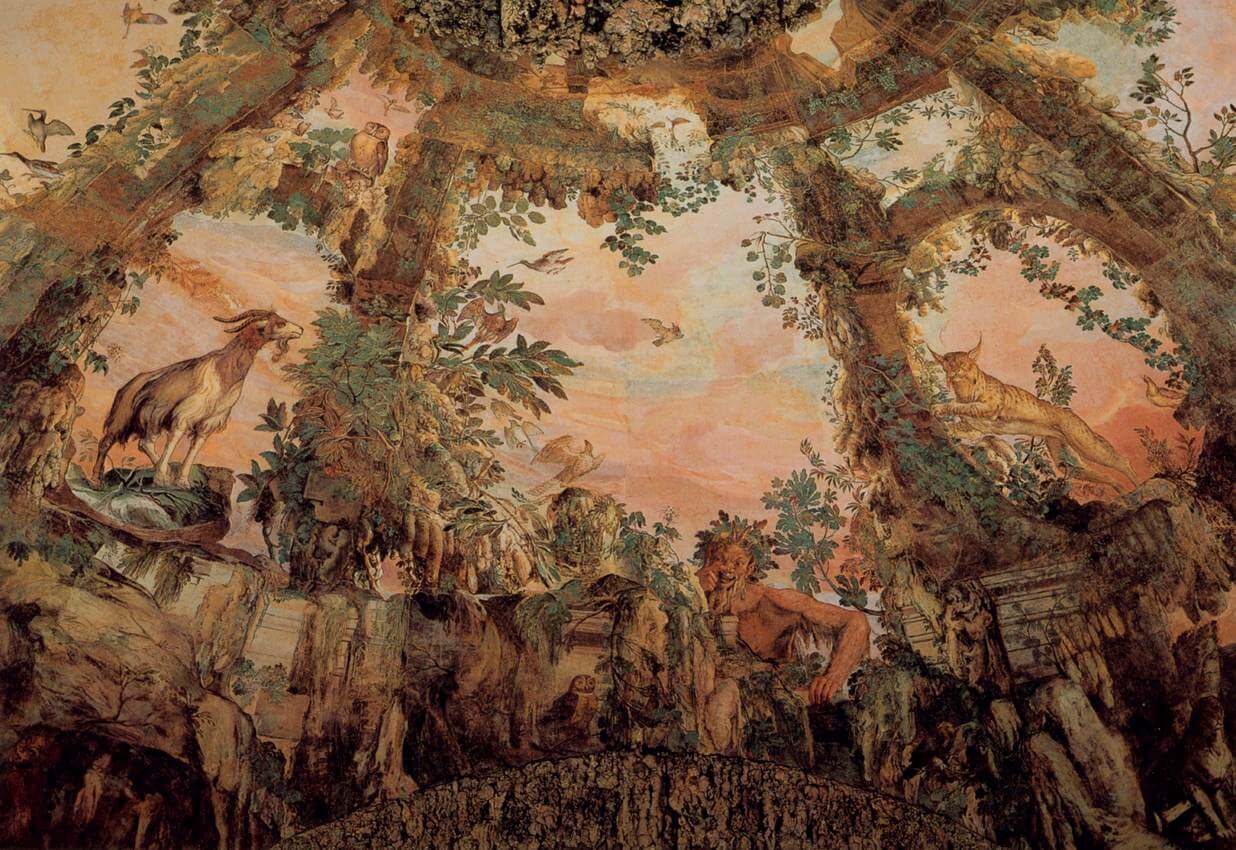IL DIADEMA DI FONTENOVA A MONSUMMANO TERME
A cura di Luisa Generali
Introduzione: il diadema di Fontenova
Dopo aver tracciato le vicende storiche e artistiche dell’affresco di Fontenova a Monsummano Terme (PT) passiamo ora a raccontare l’origine del diadema di Fontenova, un tempo pensato per incoronare l’immagine della Vergine, e che ad oggi per motivi conservativi si trova nel Museo della Città e del Territorio dello stesso paese (fig.1).

L’idea di rendere omaggio all’immagine sacra di Fontenova nacque dalla volontà del Granduca Ferdinando I (1549-1609) di offrire un ex voto a suo nome. Questa promessa fu portata a compimento nel 1609, un anno dopo la morte dello stesso duca, dal figlio Cosimo II (1590-1621), che fece arrivare a Monsummano il prezioso gioiello creato nelle botteghe orafe granducali. Con la posa di questo monile i Medici avevano così suggellato tutti i passaggi fondamentali per l’affermazione del culto di Fontenova, prima con la costruzione del Santuario, poi con l’inizio della campagna decorativa a opera dei grandi maestri del Seicento fiorentino (che andò avanti fino al 1633), ed infine con l’omaggio del prezioso diadema.
La controriforma: i culti mariani e le incoronazioni
L’intensificarsi dei culti mariani nella cornice della controriforma assunse anche una ragione storica in quanto la protesta luterana aveva notevolmente ridimensionato il ruolo di Maria, per cui di controparte la chiesa cattolica ebbe la necessità di rafforzare il credo nelle masse servendosi anche del sostegno e della partecipazione attiva dei regnanti. Risale alla seconda metà del XVI secolo, sull’onda delle predicazioni postridentine, la missione del frate Girolamo Paulucci de Calboli da Forlì (1552-1620), grande devoto di Maria che si dedicò a diffondere fra la gente l’usanza di incoronare le immagini sacre della Vergine, guadagnandosi l’appellativo di “Apostolo della Madonna”. Si impose così fra i fedeli la consuetudine di rinunciare alle proprie ricchezze per contribuire alla realizzazione di monili e corone che sarebbero state offerte alle tante icone mariane venerate nella penisola. La rinuncia dei beni materiali per donarli a Maria significava mettere da parte l’agiatezza per votare la propria anima alla Regina dell’umiltà. Col passare dei secoli tale tradizione popolare venne ufficializzata dal Capitolo Vaticano di San Pietro che, guardando “all’antichità, la venerazione e il carattere miracoloso dell’immagine”, aveva il compito di formalizzare il rito, disciplinando, in base a delle regole, il fiorire sempre più incontenibile delle incoronazioni.
Il diadema di Fontenova
Il diadema di Fontenova, considerato uno dei prodotti d’oreficeria fiorentina più pregevoli e meglio conservati del XVII secolo, si mostra ancora oggi in tutto il suo splendore, luccicante di pietre e gemme preziose. L’inserimento sull’affresco di questo magnifico oggetto metallico, che andava a nobilitare e abbellire l’immagine, cambiava sensibilmente anche l’iconografia dell’opera originaria, non più solo raffigurante la Madonna in adorazione del Bambino, ma anche Maria Regina dei Cieli, in quanto madre di Gesù, Re dell’Universo, l’unica vera fonte di ricchezza a cui aspirare.
Come in altri contesti simili, anche a Monsummano fu presa la decisione difficile quanto necessaria di separare la corona dall’affresco: in genere l’aggiunta di elementi metallici sulle pitture murarie, così come per altri supporti, si avvaleva di mezzi invasivi quali ganci, viti o chiodi, andando a gravare pesantemente sull’opera. Questa separazione, che snatura e priva il contesto di un suo fondamentale dato storico, ha d’altra parte consentito una maggiore protezione e fruizione di entrambe le opere, assicurando anche all’affresco una salvaguardia maggiore. Per ricordare gli eventi seicenteschi che portarono all’incoronazione della Madonna di Fontenova, talvolta è stata posta sulla fronte della Vergine una corona in sostituzione dell’originale, in modo da non smarrire la memoria e quella componente devozionale in cui la stessa collettività si era riconosciuta per secoli (fig.2).

Attualmente la corona è custodita nel Museo della Città e del Territorio di Monsummano, che trova spazio negli ambienti del Palazzo dell’Osteria dei Pellegrini, progettato dallo stesso Gherardo Menchini come rifugio per i forestieri, e che quindi si trova in stretta relazione storica-religiosa con il Santuario. Fa parte dell’allestimento del museo una sezione destinata proprio al Tesoro di Fontenova, che nei secoli ha raccolto tutto il fervore dei devoti tramite donazioni di varia natura: dagli ex voto più datati in lamina d’argento (tra cui si conservano anche altri esemplari di corona), agli oggetti per la liturgia, agli arredi tessili come i paramenti e i mantellini per la protezione dell’icona.
Ritornando al diadema (fig.3), sorprende la finezza del disegno e la preziosità che in ogni centimetro riveste la superficie, realizzata da una placca in rame ricoperta di uno strato d’oro su cui si inserisce una magnifica distesa di gemme. Sul retro un’iscrizione ricorda il voto di Ferdinando I e la data 1608, mentre i puntali prendono le forme del giglio fiorentino alternato a stelle, e due mezzi gigli. Oltre la grande quantità di pietre preziose e semipreziose disposte simmetricamente, coesiste anche una finissima lavorazione in filigrana e smalti che determinano l’eccezionalità del gioiello.
Il riconoscimento della stessa simbologia di cui si avvale la decorazione con la preminenza del giglio fiorentino (emblema della città di Firenze) e delle stelle ad otto punte (simbolo di Maria, fonte di luce e di salvezza) in cristallo di rocca, se da una parte voleva porre l’attenzione sul rinnovato sentimento religioso di cui la famiglia Granducale si faceva portavoce, “spogliata” delle sue gioie per donarle alla Vergine, dall’altra ostentava una vera e propria propaganda politica di affermazione dell’egemonia fiorentina, la cui sovranità era stata riconosciuta dalla stessa Chiesa.

Le corone granducali
Sebbene l’intento devozionale, sono infatti lampanti i confronti fra il diadema di Monsummano e le corone granducali, tutti manufatti provenienti dalle medesime botteghe orafe della capitale. Qui avevano preso forma i “simboli del potere” di natura politica che riconoscevano al reggente lo status di Granduca della Toscana. Prima fra tutte le insegne regali, per il suo affermatissimo ruolo celebrativo, fu proprio la corona, realizzata dal fiammingo Hans Domes (seconda metà XVI secolo) sulla base del disegno della bolla papale del 1569 promulgata da Papa Pio V che, dopo la presa di Siena da parte di Firenze, sancì il riconoscimento ufficiale di Cosimo I (1519-1574) come “Magnus Dux Etruriae” (fig.4). Vista la transitorietà di questi oggetti che venivano creati per essere in fretta disfatti e nuovamente forgiati, sono fondamentali i ritratti in cui è possibile osservare come doveva essere l’aspetto originario del primigenio copricapo creato appositamente per il regnante fiorentino, che assumeva per la prima volta un titolo governativo mai esistito prima. Nelle opere commemorative di Giovan Battista Naldini (1535-1591) e di Ludovico detto il Cigoli (1559-1613) vediamo il Granduca in abiti di rappresentanza con il mantello d’ermellino sfoggiare la corona in cui spicca, in posizione centrale, il giglio rosso accompagnato da una schiera di lance aperte verso l’esterno che correvano circolarmente lungo la circonferenza (fig.5-6).
Risale allo scorso anno la mostra a Palazzo Vecchio dal titolo “Nel Palazzo di Cosimo. I simboli del potere” in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I e Caterina de’ Medici, inaugurata il 13 dicembre 2019, a 450 anni esatti dalla lettura ufficiale della bolla di Papa Pio V che decretava la nascita del Granducato di Toscana. Il percorso, finalizzato ad una rilettura storica-artistica degli ambienti del palazzo durante il ducato cosimiano, ha esibito nella Sala delle Udienze i tre oggetti celebrativi del regno: il collare del Toson d’oro (ordine cavalleresco di cui faceva parte anche Carlo V), lo scettro e la corona (fig.7). Seguendo le tradizioni artigianali fiorentine, questi monili, che non si possono considerare copie ma vere e proprie creazioni poiché rappresentative di un prototipo non più esistente, sono stati realizzati dal maestro Paolo Penko grazie ad un accurato studio delle fonti scritte e iconografiche. Guardando da vicino la creazione del maestro Penko (fig.8) si noterà la straordinaria perizia nell’esecuzione tecnica dei dettagli, a partire dalla smaltatura scarlatta dei gigli con riflessi dorati, alla messa in posa delle perle e delle pietre preziose selezionate una ad una, ed alla lavorazione del metallo per le decorazioni ai piedi delle punte e nella dentellatura. Per arrivare infine alla riproduzione del cammeo in agata scolpita raffigurante la personificazione del fiume Arno, interpretato “alla romana” come una divinità maschile semigiacente; chiude il cerchio la fascia centrale dove corre l’iscrizione latina in memoria di quei meriti che portarono Cosimo all’incoronazione: “Pio V Sommo Pontefice donò per l’eccezionale devozione e per lo zelo nei confronti della religione cattolica e per il particolarissimo amore della giustizia”. La componente emozionale di questa rievocazione storica del passato, quando 450 anni fa negli stessi ambienti si trovavano gli autentici gioielli, è stata suggellata dall’esposizione delle tre insegne regali su cuscini rossi in velluto di pura seta collocati su una cattedra coperta da un centrotavola in velluto lavorato, capolavori tessili della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze che si occupa di tramandare le antiche tecniche artigianali della lavorazione tessile (fig.9).
Dopo la morte di Cosimo, tra gli anni ‘70-‘80 del XVI secolo, venne realizzata dall’orafo Jaques Bylivelt (1550-1603) un’altra corona ancor più sfarzosa della precedente. Anche in questo caso il pezzo non più esistente ci viene tramandato dalle testimonianze visive, in cui appare spesso a fianco dei regnanti nella ritrattistica ufficiale. Particolarmente vivida è l’immagine del gioiello nel dipinto di Scipione Pulzone (1540 c.-1598) datato al 1590 che vede Cristina di Lorena (1565-1636), consorte di Ferdinando I, sostare a lato di un tavolo dove è collocata la corona, posando la mano proprio in prossimità di questa (fig.10). Le tonalità chiare che esaltano gli effetti serici dell’abito della granduchessa e del drappo che fa da sipario, restituiscono un’immagine cristallina della scena. Anche il monile appare in tutta la sua nitidezza, puntuale nei dettagli, per cui è verosimile credere che questa sia una delle sue raffigurazioni più fedeli. Rispetto al precedente esemplare le forme della corona sono più gravi, appesantite dai grandi castoni sulla base del cerchio e sul giglio centrale, mentre anche le punte che ne circondano il perimetro si fanno più spaziose per far posto alle gemme (fig.11). Pietre preziose inserite in modo da formare dei ciondoli e catene agghindano il vestito della regnante come ornamenti sulle spalle, nella cintura e nella massiccia collana: lo stesso abito sembra quindi diventare un vero e proprio “gioiello” modellato sulle forme incantevoli della corona.
Visto il legame con il santuario di Monsummano ed in particolare la sentita adorazione di Cristina di Lorena, di cui si conservano nel tesoro di Fontenova anche alcuni arredi elargiti a suo nome, si può ipotizzare una esplicita richiesta da parte dei granduchi di realizzare un diadema che evocasse ulteriormente il legame tra la casata e il monile per l’affresco miracoloso. Evidenti sono infatti i richiami del diadema di Fontenova con quello granducale eseguito da Bylivelt come suggerisce la lavorazione per l’incastonatura delle gemme, che segue un preciso intento decorativo. Per le chiare similitudini gli studiosi hanno proposto di riconoscere l’orefice responsabile del diadema di Fontenova nella cerchia di Bylivelt e più precisamente nell’erede di bottega Odoardo Vallet (prima metà XVI secolo-1622 c.), che secondo le fonti dell’epoca fu molto abile nella tecnica degli smalti, particolare ornamentale che contraddistingue anche il manufatto di Monsummano.
Bibliografia
Baccherini, F. Capecchi, Il tesoro di Maria Santissima della Fontenova, in Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, a cura di G. Carla Romby, E. Vigilanti, Ospedaletto 2001, pp. 239-241.
Capecchi, Scheda n.221. Corona, in Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, a cura di G. Carla Romby, E. Vigilanti, Ospedaletto 2001, pp.266-267.
Per una Bibliografia specifica
Francini, Zucchi, Nel palazzo di Cosimo: i simboli del potere, catalogo della mostra a cura di C. Francini e V. Zucchi, Museo di Palazzo Vecchio, 13 dicembre 2019-31 agosto 2020, Firenze 2019.
Sitografia
Sull’applicazione delle corone metalliche: http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=2268
Sul culto dell’incoronazioni mariane: http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/59/2008-10/10-156/incoronazioni%20mariane1.pdf
Sul Santuario di Maria Santissima di Fontenova e il diadema: https://www.toscanaoggi.it/Territorio/Musei-d-arte-sacra/Santuario-di-S.-Maria-a-Fontenuova-Museo-della-Citta-e-del-Territorio
http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Aculturaitalia.it%3Amuseiditalia-work_69118
Sulla mostra Nel Palazzo di Cosimo. I simboli del potere
http://musefirenze.it/nel-palazzo-di-cosimo-i-simboli-del-potere/
https://www.fondazionelisio.org/it/chi-siamo/la-fondazione/
https://www.pressreader.com/italy/corriere-fiorentino/20191214/281994674378851
https://www.500cosimocaterina.it/eventi/nel-palazzo-di-cosimo/
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/nel-palazzo-di-cosimo-i-simboli-del-potere
MARIA SANTISSIMA DELLA FONTENOVA
A cura di Luisa Generali
Introduzione. Il Santuario di Maria Santissima della Fontenova
Nel centro di Monsummano Terme, paese della Valdinievole poco distante da Montecatini in provincia di Pistoia, si trova il Santuario di Maria Santissima della Fontenova (o Fontenuova) (fig.1). La chiesa, che fa parte integrante della piazza principale dedicata al poeta Giuseppe Giusti, venne costruita nel 1606 grazie alle elemosine dei fedeli, tra cui il contributo più significativo venne apportato direttamente dalla famiglia granducale (retta all’epoca dal Granduca Ferdinando I de’ Medici) a seguito di vari eventi miracolosi attribuiti alla presenza del simulacro mariano oggi conservato nel tabernacolo dietro l’altare maggiore del santuario.

Il primo episodio prodigioso nella terra di Monsummano si manifestò nel 1573 ad una pastorella che, dopo aver sostato in preghiera davanti a una marginetta contenente l’affresco, iniziò a disperarsi non appena si accorse di aver perso il gregge. La Vergine le sarebbe dunque apparsa in soccorso indicandole dove ritrovare gli animali ed esprimendo il desiderio di far costruire una chiesa nel luogo della sua apparizione. Negli anni successivi la grande mobilitazione popolare intorno ai tanti miracoli ricevuti dai fedeli diede i primi frutti nella realizzazione di un tabernacolo a protezione dell’affresco, che secondo le fonti fu realizzato per un’edicola viaria (o marginetta), ovvero piccole architetture religiose ancora oggi frequenti in campagna, nate come luoghi di raccoglimento, riposo e protezione. Il 7 giugno 1602 un altro fatto divino determinò le sorti del futuro santuario con la comparsa improvvisa di una fonte dopo un lungo periodo di siccità. Da qui l’intitolazione a Santissima Maria di Fontenova, per il miracolo dell’acqua taumaturgica che tuttora sgorga dalle fontanelle nella cripta, insieme a una piscina per l’immersione degli ammalati.
Il Santuario e Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia
Ritornando al XVII secolo, il clamore degli episodi di Monsummano toccò gli animi dei fedeli e suscitò un grande riscontro pubblico, tanto che la notizia raggiunse la famiglia Medici a Firenze. Nel 1602 al cospetto della duchessa Maria Cristina di Lorena, moglie del Granduca Ferdinando I, avvenne la celebrazione per la posa della prima pietra del santuario che fu velocemente terminato già nel 1606. Il progetto, realizzato in stile tardo manierista, venne affidato all’architetto Gherardo Mechini, che contraddistinse la struttura con un elegante loggiato esterno. Impreziosito da decorazioni pittoriche di grandi esponenti della pittura seicentesca fiorentina, il cuore del santuario ruota attorno all’immagine votiva della Madonna in adorazione del Bambino (fig.2), accostabile alla mano di un pittore fiorentino della metà del XV secolo, per cui gli studiosi hanno proposto il nome di Giovanni di Ser Giovanni detto lo Scheggia (1406-1486), fratello minore di Masaccio (1401-1428).

Discepolo della prolifica bottega di stampo tardogotico di Bicci di Lorenzo (1373 c.- 1452), la fortuna dello Scheggia si deve soprattutto alla sua attività di decoratore per lussuose suppellettili, tra cui sono noti i suoi cassoni nuziali ornati da scene di vita cortesi. La lunga esistenza dell’artista gli permise di conoscere e in parte recepire le novità della pittura rinascimentale di Domenico Veneziano, Beato Angelico, Filippo Lippi e dei primi artisti gravitanti sotto la protezione del Magnifico: tuttavia, la frequentazione dell’ambiente fiorentino non condizionò mai definitivamente il suo stile che, malgrado le stimolanti novità pittoriche rinascimentali, rimase fedele alla sua formazione goticizzante. Anche la vicinanza al fratello (scomparso prematuramente nel 1428 a Roma) e la sua rivoluzionaria arte non sembrano aver persuaso troppo il percorso dello Scheggia, che si avvicina allo stile di Masaccio solo sporadicamente ed in particolare nei primi lavori. Dopo un periodo di collaborazione col fratello e la sua dipartita, lo Scheggia preferì invece reinventarsi e si specializzò, come precedentemente accennato, nella decorazione di opere d’arredo in legno (da qui lo pseudonimo “Scheggia”) ovvero cassoni, cassepanche, spalliere, deschi da parto (tondi beneaugurali per le nascite) per una committenza altolocata, strettamente legata nell’ornamento al gusto gotico-cortese. Entrato a far parte della corporazione dell’arte della pietra e del legno, già dal 1432 Giovanni di Ser Giovanni divenne dunque uno tra gli esperti del mestiere più apprezzati in questa tipologia d’opere “domestiche”, sebbene dall’altro lato fu probabilmente proprio la specificità del genere a non incoraggiare mai del tutto l’artista verso un aggiornamento dello stile pittorico.
L’affresco di Maria Santissima della Fontenova
Nell’affresco di Monsummano l’immagine incorniciata dietro l’altare, raffigurante la Vergine e il Bambino, è solo una parte del brano dell’affresco in realtà più ampio che si trova nascosto sotto il grande pannello allestito per l’esposizione degli antichi ex voto, testimonianza della grande devozione popolare vissuta intorno al simulacro. Il culto della Madonna di Fontenova ha portato cioè ad oscurare l’affresco completo per conferire importanza esclusiva all’immagine mariana; l’opera nella sua interezza cela infatti una sacra conversazione con i Santi Antonio Abate, Vito, Sebastiano e Giuliano l’ospitaliere ritratti a coppie ai lati della Madonna in trono (fig.3). Il gruppo centrale raffigurato è una variante del tema della Madonna col Bambino, qui nella versione iconografica più specifica della Vergine in adorazione (fig.4): Maria si presenta seduta su un semplice trono ligneo, in preghiera con lo sguardo malinconico e la testa leggermente reclinata in adorazione del Bambino benedicente, il quale giace sulle sue ginocchia. Il seggio, con gli alti braccioli in legno intagliato, è coperto nella spalliera da un drappo che imita i tessuti in voga al tempo e ricade con naturalezza.
Il disegno domina la Sacra Rappresentazione e determina la fisicità dei Santi, così come accade per il corpicino del Bambino e la figura della Vergine, circoscritta da una linea di contorno che ne delimita l’immagine, mentre le aggraziate mani unite nella preghiera appaiono leggermente di scorcio. Unica eccezione stilistica tra le figure sembra essere rappresentata dal primo Santo a sinistra identificato come Sant’Antonio abate, che nel volto di tre quarti mostra una più consapevole plasticità definita volumetricamente da ombre e luci.
L’iconografia della Vergine in adorazione, all’epoca tema già noto e circolante in Toscana, fu reso celebre a Firenze soprattutto nella seconda metà del XV secolo da artisti pienamente rinascimentali, tra cui facciamo gli esempi di Filippo Lippi (1406-1469) e Andrea del Verrocchio (1435-1488) (fig.5-6). Si trova nel museo civico della cittadina di Fucecchio (poco distante da Monsummano), insieme ad una Sacra conversazione (1440-1450) già assegnata proprio allo Scheggia, una tavola raffigurante la Vergine in adorazione del Bambino attribuita a Zanobi Machiavelli (1418-1479), artista della cerchia di Lippi che nel rinnovato clima rinascimentale fece del calligrafismo tardogotico il suo punto di forza (fig.7). Machiavelli per la collegiata di San Giovanni Battista a Fucecchio, tra il 1460-1470, realizzò questa tavola di soggetto mariano, dove ritorna evidente tutta la preziosità da miniaturista dell’Angelico, a cui il pittore indubbiamente s’ispirò per restituire nell’opera la presenza del divino attraverso l’oro, la luce e la grazia impeccabile. Molto distante dai modelli più immediati dello Scheggia, il dipinto si colloca vicino all’affresco di Fontenova per il tema interpretato della Vergine in preghiera, che ricalca la cultura figurativa dell’epoca.

Bibliografia
Carla Romby, E. Vigilanti, Museo della città e del territorio – Città di Monsummano Terme, Ospedaletto 2001.
Bibliografia specifica
Bertocci, La Madonna della Fontenova, 2018.
Sitografia
Parrocchia del Santuario di Maria Santissima di Fontenova: parrocchiafontenova.altervista.org
https://www.famigliacristiana.it/scheda-rubrica/santuario-madonna-della-fontenova-bagnarsi-con-lacqua-miracolosa.aspx
Cavazzini, Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 56 (2001): https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-ser-giovanni-detto-lo-scheggia_%28Dizionario-Biografico%29/
FRANCESCO CURRADI: LA VITA E LE OPERE
A cura di Luisa Generali
Francesco Curradi: introduzione
Francesco Curradi (1570-1661), anche noto come il Cavalier Curradi, fu un artista fiorentino “di transito” che dai canoni della controriforma aprì la strada alla pittura devozionale del pieno Seicento toscano, di cui furono celebri esponenti Cesare Dandini (1596-1657) e Carlo Dolci (1616-1686). La sua lunga vita gli permise di produrre una grande quantità di opere soprattutto per contesti sacri, motivo per cui i suoi dipinti si trovano frequentemente nelle chiese dei grandi centri cittadini così come nelle piccole frazioni periferiche, in Toscana ma anche a Roma, Napoli e in altre zone d’Italia.
Francesco Curradi nasce a Firenze come figlio d’arte di Taddeo Curradi, di professione battiloro (mestiere artigianale per la produzione di foglie d’oro), già noto alle cronache locali come riporta Filippo Baldinucci, che nel suo testo Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua gli dedicò una breve biografia per la sua riconosciuta “natura d’ingegno sublime”. Tra le varie conoscenze Curradi padre scelse la bottega di Giovan Battista Naldini (1535-1591), perché il figlio Francesco potesse apprendere l’arte della pittura da un grande maestro erede diretto del Pontormo e della tradizione manierista. Sebbene la prima formazione, già nei primi lavori autonomi Curradi sembra invece prendere le distanze dal passato, guardando piuttosto alle novità della pittura coeva di Jacopo da Empoli (1551-1640), Matteo Rosselli (1578-1650) e Jacopo Vignali (1592-1664), in linea con i dettami della controriforma che invitavano agli effetti empatici e alla compostezza delle immagini sacre. In questo filone stilistico controriformato, che affondava le sue radici nel classicismo di primo Cinquecento in chiave “purista”, si inserisce la parabola artistica di Francesco Curradi.
Le opere
Tra le opere d’esordio ancora memori degli insegnamenti di bottega del Naldini trova posto la Nascita della Vergine (fig.1-2), opera realizzata nel 1598 per il duomo di Volterra. La grande tavola centinata, che offre lo spunto al pittore per rappresentare uno spaccato di vita quotidiana, si contraddistingue per la compostezza della scena e la delicatezza nel rappresentare le figure muliebri dalle espressioni miti che assistono alla nascita. Sebbene un retaggio ancora tardo manierista, l’artista sembra già sperimentare quell’intonazione di naturalezza e decoro della pittura riformata, a cui si aggiungono i particolari descrittivi delle acconciature e dell’abbigliamento femminile aggiornato alla moda coeva.
Dieci anni più tardi nel pieno della sua maturità Curradi divenne uno degli artisti più apprezzati nell’esecuzione di soggetti sacri, sposando a pieno le tendenze artistiche fiorentine controriformate da cui deriverà un’impostazione spaziale sempre più povera e libera da ogni particolare concreto, in modo da lasciare spazio unicamente agli atti di fede compiuti dai protagonisti. Questa componente spirituale così evidente, forse per la stessa devozione dell’artista, insignito nel 1633 da Urbano VIII con il titolo di cavaliere dell'Ordine di Cristo, raggiunge punte di patetismo, vicine a quelli che saranno i tratti distintivi dell’opera di Carlo Dolci.
È del 1610 l’Annunciazione con i Santi Antonio Abate e Miniato (fig.3) per la chiesa di San Francesco a San Miniato (PI). La scena si svolge in un ambiente incorporeo sulle tinte grigie, presidiato dai due santi che si trovano su un gradino ribassato rispetto al piano in cui ha luogo l’evento. Unica suppellettile è l’inginocchiatoio ligneo dove Maria si offre mestamente alla volontà divina: il pallore dell’incarnato, rafforzato dal manto scuro che le incornicia il volto, s’intona con l’atmosfera livida della rappresentazione. Quest’immagine compassionevole doveva arrivare dritta gli occhi del fedele provocando empatia, mentre la sontuosa veste indossata dall’angelo diventa il solo elemento di decoro ammesso, oltre a fungere al pittore da espediente per dar prova della propria maestria nella resa preziosa e realistica delle stoffe.

Questa attenzione per i dettagli dei tessuti è lampante anche nel San Lorenzo per la chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze (fig.4), capolavoro del Curradi di poco antecedente (1608): nello spazio disadorno della stanza impegnata dalla sola figura intera del santo il piviale in broccato si illumina di riflessi e cangiantismi.

Sulla stessa impronta dell’Annunciazione di San Miniato è un’altra tela di medesimo soggetto, di poco successiva (1615), per il convento soppresso del Petreto a Scansano, oggi nella chiesa di San Francesco a Grosseto (fig.5). Anche in questo caso l’ambientazione è quasi del tutto assente e l’unico elemento fisico è ancora una volta l’inginocchiatoio a fianco di Maria, ritratta a figura intera, con gli occhi socchiusi e la mano protesa, totalmente accondiscendente. Anche in questo caso l’eleganza formale è assegnata alla creatura celeste, vessillo della magnificenza divina, elegantemente ammantata da una tunica verde e una sopravveste gialla-dorata con minuscoli motivi floreali a grappoli (fig.6).
Le caratteristiche tipiche della pittura controriformata ritornano nella Predica di San Francesco Saverio datata al 1619 per la chiesa di San Giovannino degli Scolopi a Firenze (fig.7-8). L’opera scinde il piano della predica, occupato dalla figura del sacerdote missionario, da quello dei presenti in primo piano, le cui origini esotiche costituiscono il pretesto per restituire all’opera quei dettagli sfarzosi delle stoffe che diventano la firma del Curradi. Anche in questo caso colpisce l’attenzione meticolosa nei riflessi serici della tunica dell’uomo seduto a sinistra, mentre sulla destra un elegantissimo motivo floreale su sfondo azzurro percorre la veste di un astante ritratto di spalle.
Per la stessa chiesa di San Giovannino risale invece al 1635 l’Immacolata Concezione (fig.9). Rispetto ai modelli della tradizione Curradi segue le indicazioni della controriforma, ideando un’iconografia immediata, di facile lettura, in modo da escludere gran parte di quella simbologia che riempiva le opere manieriste di medesimo soggetto. L’intento ancora finalizzato a raggiungere l’emotività del fedele viene espresso nella scelta non così frequente di rappresentare la Vergine come una giovinetta ancora acerba, vestita di bianco (come indicato dal libro dell’Apocalisse), in linea con il dogma che sancisce la purezza di Maria, senza peccato. Intorno alla sua figura esile, in piedi su una falce di luna e su un globo, che sembra a sua volta assumere le caratteristiche del satellite, fanno da cornice una schiera di cherubini: in basso due personaggi dell’antico testamento, Re Davide e il figlio Salomone, dalla cui stirpe ha origine il ramo familiare di Gesù, esibiscono i consueti abiti sontuosi di stampo curradiano. Peculiare la scelta di rappresentare Salomone mentre sorregge una tavola su cui è scritto “Non erano ancora gli abissi e io ero già concepita”, versetto tratto dal libro dei Proverbi a lui attribuito. Questa frase pronunciata dalla personificazione della divina sapienza, ovvero la forza collaboratrice di Dio per la salvezza degli uomini, è stata sovrapposta dalla liturgia alla figura della Vergine, indicata come sede della divina sapienza.

Una seconda maturità
Tra gli anni ‘30 e i primi anni ‘40 lo stile del Cavalier Curradi subisce un lento ma costante mutamento, orientato verso forme solenni e un vivace colorismo, forse derivante dalla conoscenza diretta delle novità romane in seguito a un suo soggiorno nella città pontificia. Sono tuttavia evidenti in questa fase, anche forti richiami all’opera di Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613), che nei primi anni del secolo aveva profondamente scosso gli equilibri della pittura fiorentina, unendo il colorismo nord-italiano alla compostezza del disegno toscano.
Fa parte di questo momento di svolta nel percorso artistico del Curradi la tela di Montopoli (PI) conservata nella pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista, forse commissionata a seguito delle peste del 1630, come indicherebbe la presenza di San Carlo Borromeo, la cui intercessione era spesso invocata contro la pestilenza (fig.10). Si nota immediatamente come la scena acquisti una nuova monumentalità: i colori più densi e vibranti creano un’atmosfera soffusa, mentre le figure sapientemente orchestrate, tornate ad affollare lo spazio della rappresentazione, sono pervase da espressioni pensierose quanto malinconiche. L’immagine della Vergine, modulata sulla tipica delicatezza cigolesca, emana sentimenti di conforto e serenità: relegato sul lato sinistro della tela si trova invece Santo Stefano che, in parte oscurato nel volto da un cono d’ombra, appare assorto in un’intima contemplazione.

Appartiene al medesimo periodo anche la pala d’altare raffigurante La Vergine assistita da Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria che presenta a due frati di Soriano l’immagine di San Domenico (fig.11), datata al 1640 nella chiesa dei Santi Jacopo e Lucia a San Miniato, luogo favorevole al Curradi dove lavorerà a più riprese. In un alone abbagliante Maria, coperta da un manto blu punteggiato di stelle, si protende sopra la finestra centrale (creata appositamente per l’adorazione di un simulacro raffigurante San Domenico) e, come in un gesto di protezione, posa le mani sulla cornice riducendo il divario fra spazio reale e spazio artificiale. Tra le diverse figure che in questa fase assumono spesso caratteri tipizzati, il frate inginocchiato in basso sulla destra in atteggiamento d’adorazione rappresenta quella componente pietistica che è ancora parte integrante della cultura del tempo: l’aspetto devozionale infatti non scompare, ma viene rivisitato alla luce di un’armonia di fondo più corale.

Si colloca invece alla metà del secolo, in un momento ormai tardo della carriera del Curradi, la Madonna della Mercede per la propositura dei Santi Jacopo e Filippo a Pontedera (fig.12). La svolta coloristica del Curradi qui si accentua ulteriormente portando nel cielo dell’apparizione una tavolozza di colori cangianti del tutto surreali. L’atmosfera si tinge di un alone variopinto che dal violaceo passa al rosa, fino al giallo che va a circoscrivere e costituisce il cuore della visione mistica. Molte opere dell’ultimo periodo s’intoneranno su questo denso e vivace cromatismo che diverrà la caratteristica principe dell’ultima maniera del maestro.

Lo stesso albore iridescente si ritrova nella pala d’altare per la chiesa di Santa Trinita a Firenze (fig.13). La sacra conversazione riccamente affollata di personaggi articolati intorno al gruppo della Madonna col Bambino è permeata da questa atmosfera rosata, evidenza concreta della partecipazione del divino attraverso la luce, mentre la poetica degli affetti, suggerita da sguardi e gesti incrociati tra gli angeli e i santi, trasmette un’impressione d’insieme dinamica e armoniosa al contempo. La struggente figura della Santa in abito monastico rivolta di spalle tocca i vertici della pittura curradiana, così come il tenero Bambinello, animato da una più reale naturalezza.

Ultimo esempio di questa carrellata di opere si trova nella chiesa di Santa Lucia della piccola frazione di Calenzano (San Miniato). Recuperata in tempi recenti e assegnata senza incertezze alla mano dell’artista intorno alla metà del XVII secolo, il dipinto rappresenta La visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria (fig.14). In una luce paradisiaca al di fuori di ogni contesto terreno la Vergine con il Bambino appare alla Santa, inginocchiata accanto alla ruota del suo martirio, mentre veste un elegantissimo abito dai motivi rossi. Colpisce la morbidezza della materia pittorica tutta giocata sugli effetti luministici e pulviscolari di questo bagliore violaceo che si irradia dall’immagine della Vergine fino ad invadere l’intero spazio della tela, e che si accorda alla perfezione con il languido sguardo della Santa magneticamente rapito dalla visione. Il taglio della scena che mostra la giovane di profilo, invita lo spettatore alla contemplazione di tanto splendore.

Bibliografia
Campigli, Scheda n. 90, Madonna del Rosario con i Santi Stefano, Domenico, Carlo Borromeo e Francesco, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, pp. 196-197.
Benassai, “Per Francesco Curradi: le tele di San Miniato e alcune aggiunte al suo catalogo”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 82.2003, 70, pp. 59-82.
Bitossi, Scheda n. 58, Visione mistica di Santa Caterina d’Alessandria, in Visibile pregare. Arte Sacra nella Diocesi di San Miniato, a cura di R. P. Ciardi, Ospedaletto 2013, Vol. III, pp. 212-213.
Sitografia
Trezzani, CURRADI, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 31 (1985): https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-curradi_(Dizionario-Biografico)/
Sull’Annunciazione di San Francesco a Grosseto: http://atlante.chelliana.it/centro_sfrancesco_interno.htm
CIGOLI, IL PAESE DI LUDOVICO CARDI
A cura di Luisa Generali
Introduzione
Poco distante da San Miniato, in provincia di Pisa, sorge su un’altura il borgo di Cigoli (fig.1), dove nel 1559 nacque da un’agiata famiglia il celebre pittore delle lune galileiane Ludovico Cardi (1559-1613), passato alla storia con lo pseudonimo del suo luogo natale: “il Cigoli”.

Nel 1913, in occasione dei trecento anni dalla morte, il paese celebrò la memoria del Cardi erigendo nella piazzetta centrale un monumento del cigolese, rappresentato a mezzo busto con una fierezza tipicamente ottocentesca che voleva omaggiare l’integrità morale dell’artista (fig.2). L’opera prende ispirazione dalle sembianze reali del Cigoli, tramandate grazie a vari ritratti e autoritratti noti, tra cui il più celebre conservato agli Uffizi e dipinto negli anni fra il 1604 e il 1606 nel culmine della sua attività (fig.3). Qui il pittore si ritrae consapevole del suo status sociale, già acclamato dalla corte granducale come un vanto per Firenze, tanto che lo stesso Granduca Ferdinando I nel 1604 volle che la sua fama di pittore, come rappresentante della grandezza dell’arte fiorentina, si ampliasse anche nel panorama artistico romano. La figura del Cigoli si staglia palpitante su uno sfondo scuro, attraversato da un bagliore caldo che illumina e al contempo ombreggia i lineamenti del suo viso, l’elegante casacca e il vistoso cappello in pelliccia. All’altezza del petto la luce schiarisce appena anche la mano dell’artista mentre tiene i pennelli e un compasso, strumento simbolo dell’architettura a cui si dedicò grazie agli insegnamenti appresi nella bottega di Bernardo Buontalenti (1531-1608). Lo sguardo di sbieco rivolto allo spettatore fa trasparire un animo vigile e attento ma anche una vena malinconica, tipica di una personalità sensibile, come Filippo Baldinucci, nel suo testo Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua (ultimi decenni del Seicento), ricorda nell’incipit della vita dedicata al pittore:
“Ludovico Cardi da Cigoli, il quale essendo stato da natura arricchito di un'animo nobilissimo, di bontà, e di prudenza, d'amorevole tratto, e di tutte quelle doti, che vagliono a render un’uomo naturalmente perfetto […]”.
È proprio Baldinucci che ripercorre le esperienze giovanili del Cardi fra Cigoli e la cittadina d’Empoli, dove iniziò la sua erudizione intellettuale qualche tempo prima del definitivo “salto” a Firenze:
“Venne poi questa famiglia ad abitare nella Terra d'Empoli, sette miglia lontana da Cigoli verso Firenze, ritenendo però sempre in esso Castello di Cigoli sua Casa, Villa, che dir la vogliamo […].
[…] Ne sarà cosa difficile il venire in cognizione dello spirito grande, che egli diede a conoscere in sé stesso, ne' primi anni di sua fanciullezza mentre sappiamo, che l'applicarlo allo studio delle lettere umane, furono i primi pensieri del Padre suo. Studiò egli adunque nella Terra d'Empoli appresso un molto Letterato Sacerdote, chiamato Bastiano, soprannominato Morellone, sino all'età di 13 anni con tanta apertura d'ingegno, che gli bastò quel poco, per poter poi in età cresciuto dar saggio di sé, con sue belle composizioni, nelle più famose Accademie di nostra Città […]”.
Inoltre il biografo racconta i tormenti adolescenziali del giovane Cigoli che, seguendo gli spostamenti del Padre alla volta di Firenze, si trovò in bilico fra la passione per lo studio delle lettere, caldeggiate dalla stessa famiglia, e l’arte che aveva avuto modo di conoscere nella capitale toscana e alla quale presto cedette entrando nella bottega di Alessandro Allori (1535-1607), allievo prediletto ed erede del Bronzino:
“[…] ma Lodovico il figliuolo scoprendo ogni di più suo naturale talento, e l'alto genio alle buone arti, datosi a vedere le stupende Pitture di questa Città, sentissi così forte stimolare dal desiderio d' applicare anche a cose di Disegno che ormai non poteasi riconoscere in lui, quale de' due affetti, o quello delle lettere, o quello di sì bell'Arte, maggiormente occupasse i suoi pensieri, perché in un tempo stesso mescolando l'uso di questa, e di quelle, e studiava sopra i libri, e disegnava sopra carte, piccole, e spiritose figure, sin che vinta finalmente sua volontà dall'amore della Pittura fu d'uopo al Padre, benché contro sua voglia, ad essa applicarlo”.
Nonostante il trasferimento a Firenze fu sempre forte il legame con Cigoli, dove fece ritorno per tre anni in seguito a dei problemi di salute derivati dall’aria insalubre respirata nei laboratori anatomici del suo maestro, utilizzati per lo studio dal vero sui cadaveri:
“Aveva Alessandro Allori alcune stanze per entro i Chiostri della Venerabile Basilica di S. Lorenzo, ove, come studioso che egli era della Notomia, introduceva del continuo umani Cadaveri, cuegli scorticando, e tagliando a suo bisogno, ed al giovanetto Cigoli, non so sé per far compagnia al Maestro, o pure per appagare suo gran genio in quegli studij tanto necessarj all'Arte sua, veniva fatto il passare i giorni, e talora l'intere notti fra quelle malinconiche operazioni, quando non potendo a lungo andare sua tenera età far riparo alla violenza, che facevano a' suoi sensi gli odori corrotti, e gli spaventosi aspetti di quei morti, aggiunta l'immobile fissazione, con che egli gl'andava osservando, e disegnando, finalmente gli fu forza il cadere sotto il peso d'una mala sanità, che oltre i più altri travagli, che gli apportava, non solo gl'impediva l'uso delle membra, ma di quando in quando facevalo patire accidenti di mal caduto, tarto, che egli fu obligato da' Medici, a fine di campare sua vita, ad abbandonare Firenze, ed all'aria nativa ritirarli nella sua Villa di Cigoli […]”.
Tornato a Firenze dopo il turbolento periodo di degenza, a cui si unì anche il lutto dei genitori, la carriera di Ludovico Cardi fu finalmente pronta a decollare grazie alla frequentazione della bottega del Buontalenti che lo introdusse alla corte medicea e a certi entourage intellettuali, dove conobbe e divenne amico del grande scienziato Galileo Galilei (1564-1642). Dopo l’immatricolazione all’Accademia del Disegno nel 1578 e l’apertura di una propria bottega insieme al pittore Gregorio Pagani (1559-1605), le prime commissioni granducali sancirono così la consacrazione definitiva dell’artista, tanto da giungere a Roma dove per la committenza di Papa Paolo V Borghese, tra il 1610 e il 1612, affrescò la cupola della cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, rappresentando la celebre Immacolata Concezione con la luna come scientificamente osservata al telescopio da Galilei.
Le opere nel territorio circostante Cigoli
Il legame di Ludovico Cardi con il suo territorio d’origine emerge anche artisticamente nelle opere pittoriche attorno ai luoghi della sua giovinezza, per cui fu molto attivo a più riprese durante tutta la carriera con commissioni di tipo devozionale. Il primo esempio dell’evoluzione stilistica del pittore è la tavola raffigurante il Noli me tangere, capolavoro datato intorno al 1580-90, per il Conservatorio di Santa Chiara a San Miniato, dove si trova ancora oggi (fig.4). Il dipinto rappresenta l’incontro tra Cristo risorto e la Maddalena che, in uno slancio di entusiasmo nel riconoscere il Redentore, viene fermata da quest’ultimo dicendole di non toccarlo. Qui il Cigoli dimostra già una sicura dimestichezza prospettica che si nota nella staccionata in progressivo digradare sullo sfondo, insieme a un controllo modulato della luce e delle ombre. Lo stile appare ancora condizionato dell’insegnamento manierista del maestro, ben visibile nelle forme levigate della Maddalena, mentre inizia ad emergere l’interesse per l’uso morbido del colore irradiato da una luce calda che rende la fisicità del Cristo molto più naturale.

Fu proprio questo transito dalla tradizione fiorentina verso il colorismo padano-veneto la cifra distintiva del Cardi, non a caso chiamato “il Tiziano, e 'l Coreggio fiorentino”, come riportato dallo stesso Baldinucci, e che via via andò sempre più perfezionando, mitigato anche dall’opera contemporanea del pittore urbinate Federico Barocci (1528/1535-1612) che lo avvicinò allo studio di Correggio (1489-1534) e della pittura Veneta, tanto da far supporre la possibilità di un viaggio-studio dello stesso Cigoli nel nord Italia fra gli anni 1586-1587.
Tra i luoghi del Cigoli fu senz’altro Empoli il territorio nel quale ricevette più committenze, agevolato dalla conoscenza della sua famiglia proprio in questa cittadina dove aveva ricevuto la sua prima formazione, ma anche dal vivace clima religioso e culturale in stretta relazione con Firenze. Tra le opere empolesi ricordiamo l’Immacolata Concezione, datata al 1590 circa, per la Chiesa di San Michele Arcangelo nella località di Pontorme (fig.5), luogo natio di Jacopo Carucci noto come il Pontormo (1494-1557), che fu tra i modelli massimi di riferimento per lo stesso Cigoli. Elaborata sugli esempi iconografici vasariani, l’opera emana un’austera sacralità personificata dalla visione della Vergine, di una bellezza incantevole, avvolta in una veste sgargiante e inserita in un contesto celestiale animato da cangiantismi. Sotto i suoi piedi si spiegano due grandi ali che dividono la scena tra il mondo divino dell’apparizione e quello terreno, dove insieme ad Adamo ed Eva contorti in pose michelangiolesche presenziano diversi personaggi dell’antico testamento. La parte centrale, andata persa per un principio d’incendio, lascia ancora intravedere la falce di luna e le ali del demonio qui rappresentate in maniera inconsueta a metà tra quelle di un pipistrello e quelle di una farfalla, più precisamente avvicinabili nel manto a delle ali di una falena per cui diversi riferimenti simbolici ed etimologici farebbero supporre ciò: la falena è infatti un insetto della notte, in passato avvicinato al male e alla sventura, e come la farfalla simbolo di vanità e bellezza effimera. Inoltre, la falena è fatalmente attratta dalla luce che ne costituisce anche la radice originaria della parola (dal greco phos = luce), la stessa che contraddistingue anche in nome di Lucifero (portatore di luce), l’angelo ribelle che peccando di superbia volle sfidare Dio. Un’altra analogia riguarda proprio la livrea di questi insetti, spesso disegnata con motivi che ricordano immagini macabre come teschi e inquietanti mascheroni, a cui sembra ispirarsi anche il Cigoli.

Sempre a Empoli per la Chiesa di Pianezzoli nel 1593 il Cardi lavorò alla Madonna col Bambino fra i Santi Michele Arcangelo e Pietro, oggi conservata al Museo d’Arte Sacra di San Miniato (fig.6). L’impostazione classica e devozionale in linea con la controriforma è vivacizzata dai dettagli della pesatura delle anime sulla bilancia, a cui il demonio, sconfitto sotto i piedi dell’Arcangelo Michele, si aggrappa in un ultimo scatto vitale, facendo abbassare verso gli inferi l’anima peccatrice e alzare verso la Vergine l’anima pia. Il volto di Maria tradisce un chiaro rimando a Correggio e Leonardo, mentre l’impostazione scenica, così come le figure dei due Santi, sono ancora memori del linguaggio manierista fiorentino.

Fa parte di questo periodo (1595 c.) La Madonna del Rosario tra i Santi Domenico di Guzman, Monica ed Agostino Vescovo, conservata a Pontedera (Pisa) nella Chiesa del Crocifisso, che mostra un naturalismo ancor più spiccato ed evidente nel morbido incarnato dei volti e nella gestualità dinamica delle figure (fig.7). Sono temporalmente vicine anche le due tele raffiguranti la Resurrezione di Lazzaro (fig.8), per il Conservatorio di Santa Marta a Montopoli (Pisa), datata al 1598, e il San Pietro che cammina sulle acque (fig.9) per la Chiesa di San Pietro a Riottoli a Empoli (1599). Quest’ultima un secolo più tardi (come avvenne per molti dipinti del Cigoli e non solo) attirò le attenzioni dell’avido collezionista mediceo, il Gran Principe Ferdinando (1663-1713), che volle trasferire a Firenze nelle sue raccolte un nucleo importante dell’opera del Cigoli, oggi esposto alla Galleria Palatina. In entrambe i dipinti sopracitati si nota come l’artista si sia soffermato sulla caratterizzazione della figura dolce e mite di Cristo, derivata dallo studio di Correggio, a cui combina certi particolari iconografici ricorrenti, come l’aureola rossa a forma di croce.
Sempre a Empoli, facendo un balzo in avanti nel 1608, Ludovico Cardi realizzò per la Compagnia della Croce nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani la struggente Deposizione (fig.10), già afferente al suo ultimo periodo, influenzato dal suo soggiorno a Roma: qui Cigoli rimase fortemente condizionato dal classicismo dei Carracci che ebbe modo di frequentare, mentre la conoscenza del naturalismo disarmante di Caravaggio sembrò solo sfiorarlo, troppo lontano da quel linguaggio tradizionale a cui il pittore era ancora attaccato. Nella Deposizione empolese le due componenti romane sono comunque ben ravvisabili nelle atmosfere ombrose che mirano a far risaltare il classicissimo corpo eburneo di Cristo. Anche in questo caso l’opera empolese fu sottratta dal luogo originario per cui fu pensata dal Gran Principe Ferdinando che la fece sostituire con una copia di Anton Domenico Gabbiani (1652-1726), mentre l’originale è conservato alla Galleria Palatina.

Le opere a Cigoli
E’ del 1598 la tavoletta votiva che ci riporta a Cigoli tra gli ex voto dedicati alla miracolosa effigie lignea della Madonna dei Bambini; infatti se ci troviamo nei dintorni di San Miniato non si potrà non notare lo slanciato prospetto del Santuario della Madre dei Bimbi che domina il colle di Cigoli nel punto più alto del paese, epicentro di un culto secolare legato ad una serie di miracoli mariani destinati ai bambini, ancora oggi molto sentito dai fedeli. L’aspetto odierno della facciata fa parte di un progetto ottocentesco (1870-1873) volto a sacralizzare il luogo miracoloso e per questo pensato come un tempio della cristianità, scandito da paraste con coronamento a punte, mentre la parte centrale è conclusa da un frontone (fig.11).

Già documentato nel 1194 l’impianto originale della chiesa, intitolata a San Michele, venne modificato con l’arrivo a Cigoli dei frati Umiliati della congregazione di Ognissanti di Firenze intorno alla metà del XIV secolo, periodo in cui è stato datato anche il rilievo ligneo policromo raffigurante la taumaturgica Madonna col bambino, considerato dagli studiosi come d’ambito fiorentino dipendente dai modelli cimabueschi e giotteschi (fig.12-13-14). Enigmatiche rimangono ancora le numerose varianti di Maestà diffuse nel territorio lucchese e pisano, come la Madonna dei Vetturini (fig.15) attribuita storicamente a Nino Pisano (ora al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa), che hanno fatto pensare alla possibilità di una diretta dipendenza dall’esempio cigolese.
Il culto intorno alla Madonna dei Bambini si risvegliò a Cigoli nel 1451, quando la Vergine, che disse di “chiamarsi Maria e di abitare a Cigoli fra Rocco e Michele” (le due chiese del paese), apparve ad una donna che aveva perso il figlio dopo il parto, riportando in vita il neonato. A questo fatto, riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede nel Settecento, seguirono una serie di eventi divini testimoniati dalla grande quantità di ex voto di diverse epoche e tipologie, fra cui si trova anche un piccolo omaggio pittorico attribuito all’ambito di Ludovico Cardi, conservato nel Museo d’Arte Sacra di San Miniato (fig.16).

Nel 1598, infatti, il pittore fece dono di questa tavoletta votiva al santuario per la grazia ricevuta del nipote Giovanni Battista[1], nato zoppo, che per intercessione della Vergine di Cigoli guarì miracolosamente. L’operetta rappresenta il bambino in adorazione dinnanzi al tabernacolo gotico che ancora oggi custodisce il simulacro, affiancato dalla madre che indica al fanciullo l’immagine sacra a cui rivolgere le sue preghiere. Stilisticamente la tavola conserva delle caratteristiche figurative molto semplici, tipiche di un linguaggio popolare ed intuitivo, forse frutto di un lavoro di bottega che al di là dell’opera d’arte doveva piuttosto significare il ricordo e la riconoscenza per l’avvenuta guarigione. Questo episodio della vita del Cigoli, tramandato grazie all’ex voto e legato alle sue vicende familiari, costituisce più che mai una testimonianza concreta dell’affezione profonda che univa l’artista con le radici tradizionali e religiose del suo paese.
Note
[1] Successivamente biografo dello zio nella stesura del testo Vita di Lodovico Cardi Cigoli: 1559-1613.
Bibliografia
Grassi, “Ancora il Cigoli a Figline: (con una data per Tommaso Gherardini)”, Paragone, Anno 69, terza serie, numero 138 (marzo 2018), pp. 66-77.
Guicciardini Salini, D. Parri, Omaggio al Cigoli, brochure per la mostra in occasione dei 400° anniversario alla morte, 9-24/11/2013 Palazzo Grifoni – San Miniato (PI).
Siemoni, S. Pucci, Tre autori per un unico tema – La deposizione dalla croce- Studi, scoperte e restauri in Santo Stefano, Empoli 2014.
Macchi, Lodovico Cardi detto il Cigoli, il suo ambiente e la sua terra d'origine, prefazione di Roberto Paolo Ciardi, Pisa 2009.
Barbolani Di Montauto, Lodovico Cigoli: i committenti figlinesi, l'amicizia col Pagani e il "colorire naturale e vero, Il Cigoli ei suoi amici-colorire naturale e vero, a cura di Novella Barbolani di Montauto, Figline Valdarno, Palazzo Pretorio, Chiesa dell'antico Spedale Serristori, 18 ottobre 2008 - 18 gennaio 2009, 2008 Figline, pp. 19-38.
Siemoni, Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese, Santa Croce 1997.
Sitografia
Chappell CARDI, Lodovico, detto il Cigoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 19 (1976): https://www.treccani.it/enciclopedia/cardi-lodovico-detto-il-cigoli_%28Dizionario-Biografico%29/
Per la Vita di Ludovico Cardi detto il Cigoli nelle notizie dei Professori di Filippo Baldinucci: http://smartarc.blogspot.com/2016/09/la-biografica-di-lodovico-cardi-detto-il-cigoli-nelle-notizie-de-professori-di-filippo-baldinucci.html
Per il rinnovo della facciata di Cigoli: http://smartarc.blogspot.com/2016/05/il-rinnovamento-della-chiesa-di-cigoli-nell-800.html
Per il Santuario della Madonna dei Bambini a Cigoli: https://www.madrebimbicigoli.it/index.php?c=3
Per la Madonna dei Vetturini: https://www.turismo.pisa.it/cultura/dettaglio/Madonna-dei-Vetturini
VOLTI FEMMINILI AL BARGELLO
A cura di Luisa Generali
Introduzione
Visitare il Bargello e la vasta raccolta di opere statuarie che conserva offre lo spunto per delle riflessioni sulla rappresentazione artistica delle donne e il mutare nel corso dei secoli del ruolo assunto dal genere femminile attraverso il mezzo espressivo della scultura.
Salendo al primo piano dell’edificio, nelle stanze dedicate alle opere plastiche in pietra del Quattrocento fiorentino, si nota come le figure di donna non siano solo adottate per rappresentazioni allegoriche definite da un canone di bellezza classico e idealizzato, ma si accostino nell’arco del Rinascimento a un tipo di immagine individuale e memoriale, che si esprimerà pienamente attraverso la forma del busto ritratto. La riscoperta dei volti femminili passa in primo luogo attraverso alcuni profili all’antica assunti come simboli di virtù e modelli, che nel Rinascimento acquisirono nuova vita in sintonia con il vivace clima culturale fiorentino. I ritratti allegorici sviluppati secondo la tradizione antica delle donne e gli uomini virtuosi, come gli eroi e le eroine della mitologia e i personaggi storici, si plasmarono sui testi della classicità e lo studio della glittica che appassionava i collezionisti d’arte.
La statuaria del '400 al Bargello
L’artefice della rinascita del genere fu probabilmente Desiderio da Settignano (1430 c.-1464), di cui si ricorda l’affascinate quadro marmoreo dell’Olimpia (proprietà del Palacio Reale di Granja e recentemente esposto alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo a Palazzo Strozzi, Firenze, fig.1). In questa fase il volto di profilo della sovrana macedone appare ancora fortemente idealizzato, rispecchiando quella serie di caratteristiche che permangono dalla classicità, quale un concetto di bellezza puro e austero, e una serie di attribuiti che aiutano a collocare Olimpia come regina sapiente, doppiamente incoronata dal diadema e una ghirlanda di alloro. Oltre all’intento moraleggiante che il volto dell’eroina doveva suggerire, l’opera rappresenta un esempio eccezionale di pregevolezza artistica, eseguito con una maestria ineguagliabile per gli ambienti di un raffinato appassionato d’arte. La tecnica esecutoria del rilievo, condotta grazie a uno stiacciato sottilissimo, regala un senso impalpabile di eterea leggerezza.

Nel graduale evolversi della figura della donna nell’arte, la stessa conformazione del quadro in pietra raffigurante teste muliebri si avvicina a poco a poco alla ritrattistica, cedendo il posto alle dame fiorentine acconciate e vestite alla moda rinascimentale. È il caso della Giovane gentildonna (1464-1466 c., fig.2) in abito damascato e con la tipica pettinatura, firmata da Mino da Fiesole (1429-1484): gli accessori e la ricchezza della veste, restituiti attraverso un sapiente uso del rilievo in tutte le sue gradazioni, suggeriscono l’alta posizione sociale della fanciulla.

Personalità femminili si trovano modellate anche in materiali diversi dalla pietra, come nel caso del medaglione risalente agli anni 1465-1470 in terracotta invetriata, attribuito ad Andrea della Robbia (1435-1525) e raffigurante il Volto di una giovane donna (fig.3). Anche quest’opera conservata al Bargello, unica nel suo genere per vividezza, sorprende per la soavità malinconica che segna il volto della fanciulla, rinvigorito dagli squillanti colori che ne sottolineano la giovane freschezza. La testa muliebre, liberata tridimensionalmente dal clipeo (forse destinato a una decorazione architettonica), si rivolge leggermente di lato come intimidita, spostando lo sguardo dall’osservatore: le forme edulcorate del ritratto fanno pensare a un omaggio utopico alla bellezza rinascimentale fiorentina, così come suggerisce l'acconciatura alla moda, formata da un intreccio di ghirlande, e la collana di perle, simbolo di purezza e di prestigio sociale.

Ma è senz’altro il genere dei busti ritratto, che si fa strada nella metà del Quattrocento, a incrementare la rappresentazione dei soggetti femminili in funzione memoriale, come per il Ritratto di gentildonna datato agli anni 1455-1460 e attribuito alla bottega di Desiderio da Settignano (fig.4). L’identità ancora ignota della giovane dama viene ritratta attraverso la percezione artistica dello scultore che ne restituisce un’immagine cortese, tendente alla tipizzazione nello stile di Desiderio, con i caratteristici occhi a mandorla, gli zigomi alti ben evidenti, e la bocca chiusa in un misurato sorriso. Indicano la moda femminile del tempo il corpetto che scopre al centro del petto la camicia rifinita dal plissé e la pettinatura ornata con la “brocchetta da testa”, un gioiello a rosetta in voga nella seconda metà del Quattrocento, che veniva posto sul colmo del capo a chiusura dell’elegantissima acconciatura stretta da nastri e fili di gemme.

Fra i busti-ritratto più famosi del Bargello si trova senz’altro quello di Battista Sforza (1446-1472, moglie del duca di Urbino, Federico da Montefeltro, fig.5), individuata attraverso l’epigrafe sulla base e opera di Francesco Laurana (1430 c.- 1502). Al nome latinizzato della dama è premesso il termine “diva”, in genere usato in età romana per commemorare membri della famiglia scomparsi. L’impressione imperturbabile della donna restituisce tutta la fierezza imposta dal ruolo di sovrana ligia al dovere, mentre lo sguardo assente suggerisce forse una realizzazione postuma alla morte di Battista, modellata grazie all’ausilio della maschera funebre: questa ipotesi sarebbe in sintonia con la datazione del busto stimato agli anni ‘70 del Quattrocento. Forti sono le influenze pierfrancescane dello stile essenziale di Laurana, nelle forme sublimate del volto, quasi geometriche, che ne fanno un’opera modernissima.

Ma l’opera capitale per eccellenza fra i ritratti di dame e fanciulle di epoca rinascimentale è senz’altro La dama col mazzolino (fig.6), eseguita da Andrea del Verrocchio (1435-1488) nella sua piena maturità artistica (1475-1480): la scultura è considerata un unicum delle raccolte italiane per l’altissima qualità conseguita, oltre che per l’innovazione eclatante nell’estensione del busto, in cui sono ritratte anche le mani. Lo spettatore subisce il fascino integerrimo e senza tempo emanato dalla dama, ferma nella gestualità aggraziata delle mani e nei leggeri movimenti delle dita: questa azione naturale e gentile è volta a difendere il mazzolino di fiorellini di campo tenuto sul petto, così come si potrebbe proteggere una cosa preziosa e rara. Curiosa è l’identificazione della donna per cui la critica rimane divisa, forse riconosciuta come Ginevra de’ Benci, per la somiglianza con il noto ritratto di Leonardo da Vinci, in cui originariamente la figura era eseguita fino al mezzo busto insieme alle mani (in seguito tagliate), mentre un’altra interpretazione vede nella Dama col mazzolino il ritratto di Lucrezia Donati, amata platonicamente da Lorenzo il Magnifico. Sappiamo come l’interesse di Leonardo per il dato naturale e lo studio anatomico del corpo non fosse solo finalizzato alla scienza, ma anzi venisse spesso impiegato nelle sue opere pittoriche per esprimere al meglio, come in un dialogo, il moto dei sentimenti umani: ricordiamo l’intensa mimica dei corpi degli Apostoli nel cenacolo milanese, così come l’atteggiamento placido della Gioconda, in cui è lampante la ripresa compositiva verrocchiesca nel taglio della figura.

La ritrattistica femminile del '500 al Bargello
Facendo un balzo nella metà del secolo successivo, la bellezza femminile è questa volta impiegata per rappresentare il principio cristiano della Legge nuova (fig.7), opera datata al 1579 e realizzata dall’artista di formazione celliniana, Domenico Poggini (1520-1590). L’opera del Bargello fu ideata insieme al suo pandant espresso mediante le fattezze di una matrona velata e raffigurante la Legge antica (oggi conservata a Palazzo Medici Riccardi), personificazione del Vecchio testamento in confronto con i nuovi principi di perdono e salvezza diffusi dal Vangelo, comunicati dalla Legge nuova. Per esprimere questo ideale religioso in linea con il clima controriformato, lo scultore scelse l’immagine di una giovane donna dal portamento fiero, coperta da un panno sottilissimo e molto aderente al corpo, mentre sorregge il nuovo libro della legge: particolare attenzione venne impiegata dall’artista nella definizione dei capelli, pettinati in un’acconciatura raccolta a cerchio e terminante in tre code. Il confronto tra le due Leggi, realizzate per la chiesa di San Pancrazio, offrì a Poggini l’occasione di poter interpretare anche stilisticamente i concetti di “antico” e “nuovo”, costruendo l’immagine di una matrona austera e classicamente panneggiata, a paragone di una giovane vigorosa, modernamente cinquecentesca.

Fa parte del medesimo linguaggio figurativo toscano il busto di Virginia Pucci Ridolfi (fig.8), scultura storicamente attribuita a Domenico Poggini, sebbene le ultime interpretazioni protendano piuttosto verso il nome di Ridolfo Sirigatti (1553-1608), per una più congeniale inclinazione al naturalismo. La giovane donna, nipote dello storico Francesco Guicciardini, dopo il matrimonio con Giovanni Francesco Ridolfi, trovò sepoltura a soli ventotto anni in Santa Maria sopra Minerva a Roma. La lastra sepolcrale di pregevole realizzazione riporta nel medaglione un ennesimo busto ritratto identico nella fisionomia al volto del Bargello, e che ne permette quindi l’identificazione: le caratteristiche della donna dai grandi occhi e la fronte spaziosa, sono trattate similmente nell’esecuzione di entrambi le sculture, tanto da far supporre la loro realizzazione per mano di uno stesso autore. Come si deduce dalla cura con cui sono state trattate le decorazioni del corpetto e l’elegante bavero, il ritratto fiorentino, datato al 1578-1580 circa, doveva essere destinato ad un uso domestico-privato, mentre nell’effigie sepolcrale romana domina un maggior rigore esornativo, in sintonia con l’autorevolezza del luogo.

Chiudiamo infine, con il ritratto femminile forse più celebre della storia della scultura, assunto come il simbolo di un passaggio epocale di stile che apre le porte al Barocco, ovvero il Busto-ritratto di Costanza Bonarelli (fig.9), realizzato fra il 1637-1638 da Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). La storia dell’opera s’intreccia con la vita privata dell’artista che ritrae in una situazione intima il volto di Costanza, moglie di un collaboratore dell’atelier e sua amante: l’espressione della donna è animata da una forza emotiva e sentimentale nuova, colta in un momento di spontaneità che la rende incredibilmente viva. Bernini infonde al marmo la morbidezza della carne e il soffio vitale dell’anima che si trasforma in movimento, azione e potenza espressiva tesa a rimarcare la vivace personalità di Costanza; sono infatti accentuate certe caratteristiche dinamiche della sua immagine, come la chioma mossa e disordinata dei capelli, la camicia aperta sul seno e la bocca dischiusa, bloccata nell’attimo prima di continuare a parlare.

Fu proprio la passione travolgente, che definì il fascino impetuoso di questa scultura senza tempo, la causa stessa che spinse Bernini a macchiarsi di violenza quando scoprì il tradimento dell’amata con il fratello Luigi Bernini: così il volto della donna venne fatto sfregiare da un servo dell’artista, vanificando per sempre quell’omaggio d’amore e d’arte restituito attraverso il ritratto di Costanza e che oggi più che mai diventa espressione di libertà.
Bibliografia
Gnignera, Una brocchetta da testa con tre perle et uno balascio, in Antonio del Pollaiolo - Ritratto di giovane gentildonna, Chiale Antiquariato, Racconigi 2013, pp. 49-67.
Nesi, “La Legge e la Gloria: Domenico Poggini e Gherardo Silvani in Palazzo Medici Riccardi a Firenze”, in Erba d’Arno, 110.2007(2008), pp. 59-66.
Ricci, “Ritratti di Virginia Pucci Ridolfi”, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, Anno 9, fasc. 12, 1915, pp. 374-376.
Caglioti, Scheda 2.2 (Olimpia regina dei Macedoni), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 94.
Campigli, Scheda 1.3 (Dama col mazzolino), in Verrocchio, il maestro di Leonardo, catalogo della mostra a cura di Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, Venezia 2019, p. 86.
Caglioti, Desiderio da Settignano: profili di eroi ed eroine del mondo antico, in Desiderio da Settignano: scultore della Firenze rinascimentale, catalogo della mostra a cura di Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Nicholas Penny, Milano 2007, pp. 87-101.
IL PERSEO DI BENVENUTO CELLINI
A cura di Luisa Generali
Introduzione alla vita di Benvenuto Cellini
Un posto d’eccezione nella scultura monumentale fiorentina del Cinquecento è riservato al Perseo e al suo autore Benvenuto Cellini (1500-1571), uno fra gli artisti più abili della corte di Cosimo I e sicuramente per ingegno e stravaganza anche uno dei personaggi più bizzarri dell’epoca, non meno inquieto di certi altri artisti noti per aver condotto una di vita di eccessi. A dispetto del suo talento che raggiunse vette altissime nella scultura, nell’oreficeria ma anche nella musica e nella poesia, Cellini trascorse un’esistenza tormentata a causa del pessimo carattere contraddistinto da un ego spropositato e iracondo, descritto anche da Giorgio Vasari “in tutte le sue cose animoso, fiero, vivace, prontissimo e terribilissimo”. Questa sua spavalda indole, che lo portò a macchiarsi più volte di omicidio, gli costò fin da giovanetto l’esilio a Siena, dove perfezionò le sue competenze come orefice già acquisite in parte a Firenze. Le disavventure con la giustizia precipitarono velocemente quando nel 1523 commise il primo delitto che lo costrinse a fuggire da Firenze e spostarsi a Roma, qui ottenne i favori e l’indulgenza di Papa Clemente VIII, per cui lavorò in qualità di maestro della zecca, e combatté in prima linea durante il sacco di Roma (1527). In seguito ad un incessante catena di accuse legate a litigi, risse, furti e omicidi nel 1537 Cellini si spostò a Parigi alla corte di Francesco I de Valois, dove il suo sogno d’artista libero e indipendente da ogni accademismo sembrò potersi finalmente realizzare, almeno fino al 1544 quando rientrò frettolosamente in patria a Firenze. Qui trovando l’accoglienza del nuovo regnante Cosimo I de’ Medici, lavorò senza sosta per ben nove anni alla commissione ducale del bronzo monumentale raffigurante Perseo, la sua fatica più grande e tormentata (fig.1).

La personalità di quest’uomo, tipica del binomio che contraddistingue l’artista per eccellenza, geniale ma sregolato, prorompe pagina dopo pagina nella sua Vita dettata ad un garzone di bottega fra il 1558 e il 1566, in un momento di forte declino dopo che tutto l’entusiasmo intorno alla messa in opera del Perseo si spense repentinamente insieme alla richiesta di nuove commissioni. L’intento dell’opera letteraria, che assunse i connotati di un’autobiografia romanzata senza precedenti, è finalizzato alla legittimazione e al riconoscimento del proprio status di artista nella corte medicea, sfociando in una sorta di autocelebrazione personale che trova la sua massima ragion d’essere proprio nell’impresa del Perseo. Dai brani dedicati alla realizzazione dell’opera emerge una costante lotta nel superamento di sé stesso e dei suoi colleghi-rivali, che sprezza con la sua peculiare irriverenza: in particolare, la sfida si fa sempre più competitiva con Baccio Bandinelli (1493-1560), il preferito di Cosimo, che ripetutamente Cellini nella su Vita accusa di “sparlare”, alimentando i dubbi del duca nei suoi confronti e nella concreta possibilità di fusione del grande bronzo. Non mancano a questo proposito episodi macchiettistici nello studio dell’artista in cui lo stesso Cellini e il Duca, poco ottimista, discutono sull’effettiva criticità tecnica della scultura:
“[…] e venendo più spesso a casa, ch'ei non soleva, una volta infra l'altre e' mi disse: Benvenuto, questa figura non ti può venire di bronzo, perché l'arte non te lo promette. […] E Or dimmi, Benvenuto, come è egli possibile, che quella bella testa di Medusa, che è lassù in alto in quella mano del Perseo, mai possa venire? Subito io dissi: Or vedete, Signor mio, che se Vostra Eccellenza Illustrissima avessi quella cognizione dell'arte, che lei dice di avere, la non arebbe paura di quella bella testa, che lei dice, che la non venissi; ma sì bene arebbe da aver paura di questo piè diritto, il quale si è quaggiù tanto discosto. A queste mie parole il Duca mezzo adirato, subito si volse a certi Signori, che erano con Sua Eccellenza Illustrissima, e disse: Io credo, che questo Benvenuto lo faccia per saccenteria, il contrapporsi a ogni cosa: e subito voltomisi con mezzo scherno, dove tutti quei che erano alla presenza facevano il simile, e ' cominciò a dire: Io voglio aver teco tanta pazienza di ascoltare che ragione tu ti saprai immaginare di darmi, che io la creda.”
Il pensiero ossessivo intorno all’opera scatenò la furiosa reazione dell’artista nel celebre episodio dell’incendio della fucina durante la fusione della statua, quando, sebbene febbricitante dalla fatica, dopo aver appreso la notizia da un garzone, esplose in tutta la sua rabbia:
“O Benvenuto, la vostra opera si è guasta, e non ci è più un rimedio al mondo. Subito che io sentii le parole di quello sciagurato, messi un grido tanto smisurato, che si sarebbe sentito dal cielo del fuoco, e sollevatomi del letto presi li mia panni e mi cominciai a vestire, e le serve e il mio ragazzo e ognuno, che mi si accostava per aiutarmi, a tutti io davo o calci, o pugna […]”
Dopo la buona riuscita della fusione, le fasi di cesellatura e rifinitura dell’opera perdurarono per ben cinque anni, fino al momento della “scopertura” sotto la loggia del Lanzi, il giorno 27 aprile 1554, evento tanto atteso che sancì in un tripudio di lodi ed encomi la vittoria personale di Cellini e il proprio primato sul panorama artistico fiorentino:
“Or come piacque al mio glorioso Signore ed immortale Iddio, io la finii del tutto, e un Giovedì mattina io la scopersi tutta. Subito, che e ' non era ancora chiaro il giorno, vi si ragunò tanta infinita quantità di popol, che e ' saria impossibile il dirlo; e tutti a una voce facevano a gara a chi meglio ne diceva […].”
Il Perseo sotto la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria
L’interpretazione in chiave allegorica del mito classico fu il tema più ricorrente nelle corti rinascimentali scelto per l’autocelebrazione delle casate, proprio come avvenne anche a Firenze con il Perseo, l’eroe figlio di Danae e Zeus che riuscì ad uccidere Medusa, l’unica sorella mortale delle Gorgoni. Secondo la mitologia greca il giovane eroe si offrì di portare la testa del mostro come dono nuziale al tiranno Polidette, regnante dell’isola di Serifo, dove era prigioniero insieme alla madre Danae. Perseo quindi partì per la sua impresa supportato da Atena ed Ermes, che gli donarono una serie di oggetti magici: i sandali alati per volare, un copricapo per diventare invisibile, una borsa di pelle per nascondere la testa del mostro, e un falcetto. Dopo varie peripezie il giovane riuscì a scovare il nascondiglio di Medusa, la terribile creatura dalla chioma di serpenti che pietrificava chiunque incrociasse il suo sguardo, frutto di una punizione scagliata da Atena che ingelosita dalle attenzioni di Poseidone per la ragazza decise di trasformarla in un mostro. Arrivato al nascondiglio delle Gorgoni, Perseo attaccò di spalle Medusa servendosi dell’immagine del mostro riflessa sullo scudo di Atena e sferrando così il colpo decisivo alla testa.
La lettura allegorica del mito in questo caso si riferisce alla nuova reggenza medicea, detentrice delle virtù morali che demolirono i nemici repubblicani, visti come mostri e personificati nella testa decapitata di Medusa, alzata trionfalmente dall’eroe. Pensata in un dialogo visivo e metaforico con La Giuditta e Oloferne di Donatello, l’esaltazione plateale della sconfitta degli avversari soggiogati e decapitati, diventa anche un monito intimidatorio dell’egemonia medicea. Le virtù civiche del regno mediceo sono invece pronunciate nell’integrità morale e fisica di Perseo, che Cellini interpreta in un nudo snello e vibrante, mosso dagli effetti epidermici delle masse muscolari (fig.2). La testa di Medusa esanime, di una bellezza ermafrodita, ricorda gli stessi tratti dell’eroe che mentre sfoggia il suo trofeo non si scompone, rimanendo severo e integerrimo (fig.3): questa similitudine fra i volti della vittima e del carnefice, secondo parte della critica, sarebbe interpretabile alla luce delle teorie neoplatoniche per cui l’eroe greco diverrebbe metafora dell’uomo virtuoso, chiamato a sconfiggere le sue stesse pulsioni primitive per innalzarsi verso la perfezione. Oltre l’impressionante precisione con cui è definita la muscolatura dell’addome, colpisce la perizia da orefice con cui sono trattati alcuni dettagli come l’estrema ricercatezza nella definizione dei boccoli dell’eroe, piuttosto che i capillari particolari dell’elmetto a forma di drago, oppure la cesta di serpenti che copre la testa di Medusa (fig.4).

Non manca inoltre un po' del protagonismo di Cellini nella sua firma incisa in bella vista sulla tracolla, mentre guardando alla nuca dell’eroe, fra le insenature del casco e dei capelli si vede affiorare una maschera dalle fattezze umane, forse identificabile con lo stesso artista che attraverso questo strambo espediente manierista avrebbe lasciato celatamente una traccia immortale di sé sulla scultura (fig.5-6).
Il basamento
La grandiosità di questo monumento non è circoscritta al solo bronzo monumentale ma si estende secondo un orientamento verticale anche nel basamento e nella lastra bronzea sottostante, affrontando nelle varie componenti diverse tipologie di scultura: dall’opera a tutto tondo, alla lavorazione del marmo, passando per i bronzetti all’antica fino al basso e alto rilievo. Con il gruppo del Perseo Cellini affermava così la padronanza totale dell’arte scultorea in tutte le sue sfaccettature.
La base, di cui l’originale è conservato al Museo Nazionale del Bargello, si presenta come un elaboratissimo ricamo marmoreo, prova del virtuosismo tecnico dell’artista anche nella lavorazione della pietra (fig.7). L’opera si compone di immagini di varia natura, che spaziano da figure grottesche e macabre a un repertorio antichizzante e simbolico come avviene per le teste di capricorno, emblema assunto dal duca Cosimo I. Immagini inquietanti unite a elementi rigogliosi di vita, come le ghirlande di frutta e l’erme di Diana Efesia Polymastos (dai molti seni), simbolo per eccellenza di fertilità, vogliono forse richiamare il ciclo di morte e rinascita inaugurato da una rinnovata età dell’oro sotto il ducato cosimiano. Nelle quattro nicchie che si aprono su tutti i lati della base sono inserite “le belle figurine”, ovvero i bronzetti all’antica dedicati alle benevole presenze che intervennero nelle vicende di Perseo, a partire dalla madre Danae qui ritratta insieme al figlio fanciullo avuto con Zeus che si unì a lei sotto forma di pioggia d’oro. L’artista interpreta Danae come una Venere classica, dal nudo pingue e morbido, affiancata dal bambinetto che per attirare la sua attenzione solleva le braccia allungando l’esile corpicino (fig.8). Fra gli attori del mito si trova anche Zeus, padre di Perseo, restituito attraverso la tipica effige classica del dio severo e barbuto, avvolto in un ampio panneggio, mentre si prepara a scagliare una saetta (fig.9): l’impetuosa forza in potenza generata da Zeus sembra creare un turbine vorticoso che smuove realisticamente anche la sua chioma. Indispensabile al racconto mitico sono le due divinità amiche Atena, dea della guerra e della saggezza interpretata attraverso un nudo classico estremamente lineare e polito (fig.10), e lo scattante Ermes, fermato in uno curioso movimento ginnico, nel momento appena prima di elevarsi per spiccare il volo mentre alza le mani e piega una gamba, restando sulla punta di un unico piede (fig.11). Anche in questo caso il nudo mostra una gracilità che epidermicamente nasconde una complessa tensione muscolare.

Secondo la testimonianza di Cellini nemmeno la duchessa Eleonora di Toledo rimase impassibile difronte la magnificenza dei quattro bronzetti, tanto che si oppose alla loro fruizione pubblica, volendoli per sé, al sicuro nelle sue stanze: una decisione ripudiata dallo stesso artista che di nascosto approfittò dell’assenza dei duchi per “impiombare” le statuette nella base per la quale erano nate, pronto a tutto pur di portare a termine il suo progetto. Con il consueto tono irriverente Cellini raccontò l’episodio:
[…] per più di dua ore non ragionorno mai d'altro che delle belle figurine; di sorte che e' n'era venuta una tanto smisurata voglia alla Duchessa, che la mi disse all ora: Io non voglio, che queste belle figurine si vadino a perdere in quella basa giù in Piazza, dove elle porteriano pericolo di esser guaste; anzi voglio, che tu me le acconci in una mia stanza, dove le saranno tenute con quella reverenza, che merita le loro rarissime virtuti. A queste parole, io mi contrapposi con molte infinite ragioni; e veduto che ella s’era risoluta, che io non le mettessi in nella basa, dove le sono, aspettai il giorno seguente, me ne andai in Palazzo alle ventidue ore, e trovando che il Duca e la Duchessa erano cavalcati, avendo di già messo in ordine la mia basa, feci portare giù le dette figurine, e subito le impiombai, come le avevano a stare. Oh! quando la Duchessa lo intese, e gli crebbe tanta stizza, che se e' non fussi stato il Duca, che virtuosamente mi aiutò, io l'arei fatta molto male.”
Chiude infine il complesso programma iconografico del Perseo il rilievo bronzeo raffigurante La liberazione di Andromeda, l’ultima parte del mito che viene narrata e incastonata nel parapetto della stessa loggia, attualmente sostituita da una copia mentre l’originale si trova Bargello (fig.12). Sempre secondo la leggenda, una volta che Perseo uccise Medusa scappò con la sua testa per tornare verso l’isola di Serifo, con l’intento di vendicarsi del tiranno che teneva prigionieri lui e sua madre Danae. Mentre sorvolava il paese degli Etiopi l’eroe s’imbatté in una fanciulla bisognosa di aiuto, Andromeda figlia di Cefeo e di Cassiopea, legata ad una roccia e data in sacrificio ad un mostro marino per placare la collera di Poseidone: a quel punto Perseo, forte del suo equipaggiamento, si precipitò ad uccidere il mostro liberando Andromeda che in seguito divenne sua sposa. La vicenda, narrata con l’ausilio del rilievo che passa da un grado di aggetto molto alto all’incisone, è costruita intorno alla figura centrale della fanciulla, ritratta nuda con i lunghi capelli sciolti e mossi dal vento, stretta fra il pericolo del mostro che sta per divorarla e il capannello di astanti disperati. La cifra stilistica adottata da Cellini fa riferimento alla drammaticità di certi rilievi di Donatello, da cui trae l’intensità espressiva di alcuni personaggi (sconcertante è il grido lanciato dall’uomo in fondo la scena) e la tagliente incisività del modellato. Giocando sull’alternanza tra i repentini passaggi di aggetto mossi dalla contrastante alternanza di luce e ombre, il rilievo acquista profondità e una vena narrativa nuova, molto vicina alla pittura.

Bibliografia
Cellini, Vita di Benvenuto Cellini orefice e scultore fiorentino scritta da lui medesimo, pubblicata dal Dottor Francesco Tassi, Tomi 3, Firenze 1829.
Vasari - Degl'accademici del disegno, pittori, scultori et architetti e dell'opere loro e prima del Bronzino, 1568, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze 1568, edizione Giunti-Newton Compton Editori 1997.
Testo digitalizzato
https://it.wikisource.org/wiki/Le_vite_de%27_pi%C3%B9_eccellenti_pittori,_scultori_e_architettori_(1568)/Accademici_del_Disegno_e_il_Bronzino
Pegazzano, Cellini e la scultura francese del Cinquecento, Firenze 2008.
Mariucci; C. Sirigatti, L. Spano, G. Uzzani, P. Zanieri, Toscana da non perdere. Guida ai 100 capolavori, Firenze 2008, pp. 32-33.
Capriotti, L’ alibi del mito: un’altra autobiografia di Benvenuto Cellini, Genova 2013.
Palumbo, “Un tema narrativo nella "Vita" di Benvenuto Cellini: "l’impresa" del Perseo”, in Biblioteca dell’"Archivum Romanicum", 375,1 – 2011, pp. 305-317.
Sitografia
Camesasca, CELLINI, Benvenuto, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 23 (1979). Testo online: https://www.treccani.it/enciclopedia/benvenuto-cellini_(Dizionario-Biografico)/
www.polomuseale.firenze.it - http://www.polomuseale.firenze.it/areastampa/files/53185184f1c3bc7c07000000/02%20SALA%20MICHE_PDF.pdf
IL CULTO DI SAN MICHELE A CRESPINA
A cura di Luisa Generali
Introduzione
Nelle colline pisane, non troppo distante dalla costa, si trova il borgo di Crespina, ricordato nelle cronache locali come un antico insediamento romano che, probabilmente per il particolare paesaggio boscoso, venne battezzato con un nome che evocasse i suoi acri rovi (“acre spinarium”). Con la dominazione longobarda stanziata in questi luoghi tra la fine del VII e l’inizio del VIII secolo si dette inizio alla tradizione secolare del culto di San Michele, molto venerato dai popoli goti che si riconoscevano nelle caste dominanti dei guerrieri e che identificarono l’arcangelo, capo dell’esercito celeste, come loro protettore. La devozione verso il culto micaelico, intessuta nella storia religiosa e sociale del paese, sopravvive ancora oggi nei due edifici sacri (per distinguerli ribattezzati dai paesani “la chiesa vecchia” e “la chiesa nuova”) e trova espressione nelle opere devozionali che nei secoli vennero dedicate all’immagine dell’arcangelo. La chiesa “vecchia”, oggi sconsacrata, ha vissuto un recente passato come teatro cittadino, per poi essere oggetto nel 2011 di una campagna di restauri che ha riportato alla luce le settecentesche decorazioni: qui probabilmente aveva luogo il primissimo oratorio di fondazione longobarda, in seguito sostituito con la chiesa priorale, già presente nei registri della diocesi lucchese nel 1260. La chiesa “nuova”, edificata nell’arco del XIX secolo e terminata nel 1891, si trova invece “sul poggio” (la parte alta del paese) ed esibisce una sobria facciata in stile neoclassico (fig.1). Tale edificio divenne il rinnovato cuore della comunità crespinese, custode di quei tesori di fede già venerati nell’antico complesso che col tempo sfortunatamente cadde in stato di abbandono.

Nell’Ottocento la nuova chiesa e la devozione al culto di San Michele entrarono a far parte del repertorio figurativo macchiaiolo e di quello naturalista, trovando a Crespina e nell’entroterra pisano gli scenari ideali per esprimere in pittura l’idillio di un mondo ancora incontaminato: grazie all’accoglienza e alla protezione di alcune famiglie benestanti che risiedevano nelle ville di campagna crespinesi per i soggiorni estivi, molti artisti trovarono ispirazione negli scorci paesistici del borgo, affascinati dalla liricità della vita contadina e i costumi popolari di questi luoghi. È di Silvestro Lega (1826-1895), che fu ospite dei fratelli livornesi Ludovico e Angiolo Tommasi (anch’essi pittori e proprietari della villa di Bellariva), l’opera di collezione privata ritraente La chiesa di Crespina, datata al 1886, che segna con pennellate veloci e fluide la chiesa nuova appena costruita e il grande piazzale antistante (fig.2). Appartiene invece alla mano di Adolfo Tommasi (1851-1933), cugino dei fratelli Tommasi sopracitati, La fiera di San Michele (fig.3), opera datata al 1889 circa, che con un taglio descrittivo molto vivace, ascrivibile al filone della pittura naturalistica, rappresenta il clima di festa durante la ricorrenza patronale con il tradizionale mercatino davanti il sagrato della chiesa. Per le celebrazioni di San Michele che si svolgono ogni anno il 29 settembre, ricorre anche l’antichissima fiera delle civette, presente nell’albo regionale delle fiere storiche in quanto nata dalle vecchie usanze contadine di ammaestrare le civette per la caccia alle allodole. Tale pratica, oggi vietata, ha trasformato le sue origini venatorie in una vera e propria festa in onore di questi affascinanti rapaci, a cui il comune di Crespina nel 2019 ha dedicato il Parco delle civette, uno spazio protetto per la loro tutela, in simbiosi con la valorizzazione dell’ambiente naturale.
Le opere di San Michele a Crespina
Tornando nella chiesa nuova di San Michele, tra i pezzi più pregevoli qui conservati si trova senz’altro la tavola trecentesca a fondo d’oro raffigurante il santo patrono e santo titolare della chiesa (fig.4). L’opera, che fu riportata all’attenzione del pubblico e della critica da Mario Salmi nel 1939, in occasione della storica mostra a Firenze per l’anniversario della morte di Giotto, è posta non a caso centralmente dietro l’altare maggiore, poiché rappresenta per la collettività un’immagine simbolo di riconoscimento dell’identità locale crespinese. Attualmente gli studi concordano nell’attribuire il San Michele al seguace di Giotto, Bernardo Daddi (1290 c.-1348), che ingentilì la pittura del maestro ricorrendo a raffinate soluzioni figurative e coloristiche. La tavola cuspidata, datata fra il 1330 e il 1340 circa, ritrae San Michele in veste marziale, così come viene spesso identificato nell’immaginario collettivo, quale angelo-guerriero che nel libro dell’Apocalisse uccide il drago, metafora del male. Il Santo è qui ritratto nell’attimo esatto in cui, sollevando la spada, raccoglie tutte le forze prima di sferrare il potente colpo che ucciderà il demone, già immobilizzato sotto i suoi piedi. Lo sforzo fisico del gesto fa risaltare appieno il corpo dell’arcangelo e la sua veste rossa, decorata da gemme e gioielli (fig.5), mentre il volto grave mostra un’espressione concentrata e sicura; inoltre caratterizzano il San Michele i capelli biondi e mossi, fermati sulla fronte da un diadema, e le ponderose ali piumate. L’estrema ricercatezza di certi dettagli, uniti al decorativismo dei colori, ricorre nell’opera di Daddi che oltre a Crespina impiega la stessa tonalità di rosso della veste di San Michele anche per l’abito talare del San Lorenzo, conservato alla Pinacoteca di Brera (1340 c.), e per alcuni fiori che compongono l’incantevole ghirlanda di Santa Cecilia al Museo diocesano di Milano (fig.6-7).
L’iconografia del San Michele si diffuse nel medioevo in due formule frequenti, di cui la più antica e iconica rappresentava l’arcangelo insieme agli attributi della lancia (o della spada) e del globo, simbolo dell’intervento divino operato per la salvezza del mondo. Sembra invece diffondersi più tardi ma con un successo maggiore nel tempo, l’iconografia narrativa proferita nell’Apocalisse che ritrae il momento dell’uccisione del drago per mano del Santo, a cui spesso si combina anche l’attributo della bilancia come metafora di giustizia. L’unione parziale di queste due rappresentazioni venne interpretata da Giotto in un pannello del Polittico di Bologna (1335), dove San Michele si mostra frontalmente con un roseo abito sacerdotale e rosse ali spiegate, insieme agli attributi della lancia e del globo (fig.8-9). Sebbene alcuni esempi del San Michele in tunica secondo una tradizione diffusa soprattutto in ambito orientale, l’iconografia dell’arcangelo che si andò affermando fu quella in abiti bellici, spaziando da scintillanti armature corazzate alle più varie e fantasiose soluzioni. In prevalenza l’abbigliamento marziale dell’arcangelo verte spesso sui modelli del mondo antico, a cui anche Bernardo Daddi si ispirò. In tal senso sono lampanti le corrispondenze tra l’opera crespinese e gli affreschi di Buonamico Buffalmacco (1262 c.-1340) nel Camposanto pisano, eseguiti fra il 1336 e 1341, dove fra le schiere celesti compare anche il San Michele insieme ad altri arcangeli, tutti in abiti marziali interpretati “alla romana” (fig.10-11).
Al contrario di come si potrebbe pensare le vicende della tavola attribuita a Daddi si intrecciano con la storia di Crespina solo nel 1801, quando venne acquistata per la comunità dall’abate pisano Ranieri Tempesti (1747-1819), teologo-intellettuale molto apprezzato nell’entourage altolocato, fratello del pittore Giovan Battista Tempesti (1729-1804). Guadagnandosi la stima della famiglia Del Testa Del Tignoso, Ranieri si trasferì a Crespina come cappellano privato degli stessi signori, interessandosi in prima persona ai lavori di restauro della villa padronale, detta “della Carretta” o “Belvedere” (fig.12). Il rifacimento del complesso, avvenuto nella seconda metà del Settecento e che comprese anche la costruzione del kaffeehaus, dell’oratorio e altri vari fabbricati, fu portato avanti dalla direzione dell’architetto Mattia Tarocchi, mentre la parte decorativa figurale venne affidata a Giovan Battista Tempesti, artista già noto nel pisano, formatosi a Roma nella cerchia di Pompeo Batoni (1708-1787). Il magnifico complesso divenne una residenza-gioiello fra le più rinomate delle colline pisane, emblema dell’eleganza settecentesca, ed ancora oggi un vanto per il paese.

Ritornando al personaggio alquanto curioso di Ranieri Tempesti, le cronache locali raccontano di uno scambio rocambolesco avvenuto fra lo stesso reverendo e il rettore della chiesa di Marciana che, non immaginando il valore della tavola, barattò il San Michele in cambio di una pianeta di broccato (un abito liturgico). L’icona medievale, al tempo creduta dell’Orcagna, venne così acquisita appositamente dal Tempesti per donarla alla comunità di Crespina in modo da ovviare alla mancanza degli antichi arredi del culto micaelico, andati persi nei secoli, e creare quindi un filo diretto con il passato.
Tra le attività di cui si occupò Ranieri Tempesti a Crespina ci fu anche il restauro della chiesa vecchia di San Michele, iniziato nel 1797 e concluso nel 1801 grazie alle generose donazioni del popolo. L’equipe familiare composta da Giovanni Battista Tempesti, il figlio Carlo, e lo stesso Ranieri (anche lui amante della pittura) concorsero alla decorazione dell’ambiente interno, affrescato interamente con quadrature architettoniche e brani figurativi (fig13). Tra le decorazioni settecentesche spicca per qualità esecutiva il San Michele Arcangelo (1797-98), opera di Giovanni Battista che interpreta il santo guerriero come un leggiadro fanciullo in volo con bianche ali minute e la consueta veste marziale molto particolareggiata (fig.14-15). La drammaticità delle immagini medievali spesso grevi e talvolta bizzarre qui svanisce lasciando il posto ai vezzi settecenteschi improntati su un edulcorato classicismo unito alle delicatezze rococò. Il richiamo diretto all’antichità ricorre nelle due statue monocrome di San Giovanni Battista e Santo Stefano che fanno da quinta alla scena, e nel tempietto circolare entro cui è sospeso il Santo; l’evocazione dell’arte classica emerge inoltre nella stessa ideazione iconografica di Michele, che spesso venne assimilato figurativamente al dio Mercurio per alcune evidenti analogie che accomunano il messaggero degli dei con l’arcangelo, in una ricorrente contaminazione fra sacro e profano. Un parallelo con l’affresco di Crespina si riscontra nel San Pietro liberato dall’angelo, opera dello stesso Tempesti datata un decennio prima (1786 circa) e conservata nella galleria di Palazzo Blu a Pisa (fig.16-17). Qui è la creatura angelica a ricoprire il ruolo di vero protagonista, irrompendo nel carcere in un alone di luce abbagliante che investe San Pietro e parte dell’ambiente circostante. La deflagrante apparizione dell’angelo, modulato sulle tinte tenere del rosa, contrasta decisamente con il cupo fondale della tela, restituendo una sorprendente dicotomia. Rispetto all’opera pisana il San Michele di Crespina mantiene i tipici tratti “leziosetti” del volto alla maniera del Tempesti, mentre un’ombreggiatura più densa e marcata modella il corpo dell’arcangelo in volo: colpisce inoltre la ricercatezza e la vivacità della sua veste marziale, diversificata nelle varie componenti da un tripudio di colori, quali la lorica violacea, il gonnellino verde con le frange rosse e lo svolazzante drappo giallo.

Facendo un balzo in avanti nel XX secolo, non si spegne col tempo il sentimento devozionale di Crespina rivolto al culto di San Michele, quando tra il 1950-1954 vengono commissionati all’artista milanese, Antonio Domenico Gajoni (1889-1966), gli affreschi per gli interni della chiesa “nuova”. Gajoni, formatosi a Parigi e già collaboratore di Gino Severini (1883-1966), nel soffitto dell’edificio celebra ancora una volta la gloria del santo patrono nel drammatico momento della sconfitta degli angeli ribelli, incorniciato da un algido colonnato prospettico che contribuisce ad accrescere la solennità della scena e contrasta drammaticamente con i bagliori del cielo e il fuoco infernale dove i demoni sono confinati (fig.18). Qui l’artista adotta uno stile classicheggiante suggestionato dal trionfalismo della pittura barocca, unita ai modelli figurativi del San Michele dipinti da Guido Reni (1575-1642) e Luca Giordano (1634-1705), ancora oggi fra i più noti nell’immaginario comune (fig.19-20).
Bibliografia
Pepi, Crespina nella pittura dell’800, Pisa 1986.
Don Piero d’Ulivo, Crespina e il suo San Michele, Livorno 1989.
Ducci, Da una tavola dipinta con San Michele arcangelo riflessi e riflessioni, in Tesori medievali nel territorio di San Miniato, Ospedaletto 1998.
Camarlinghi, La fiera delle civette, in Crespina e il suo territorio, a cura di M. Camarlinghi, 1999 Pontedera, pp. 143-152.
Pepi, Crespina e la pittura, in Crespina e il suo territorio, a cura di M. Camarlinghi, 1999 Pontedera, pp. 41-46.
Simoncini, Strapaese, in Crespina e il suo territorio, a cura di M. Camarlinghi, 1999 Pontedera, pp. 115-142.
F. Pepi, Itinerario alla scoperta del territorio di Crespina-Sulle orme di Giovanni Mariti, pubblicazione a cura del Comune di Crespina e l’Associazione Culturale Fuori dal Museo, 2012.
Renzoni, Relatore Prof. A. Tosi, Il pittore e la città. Tempesti e le prime grandi commissioni, in Giovanni Battista Tempesti pittore pisano del Settecento, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Pisa, anno accademico 2012, pp. 229-264.
Renzoni, Relatore Prof. A. Tosi, Scheda n.195 - S. Michele Arcangelo, S. Giovanni Battista, S. Stefano, in Giovanni Battista Tempesti pittore pisano del Settecento, in Giovanni Battista Tempesti pittore pisano del Settecento, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Pisa, anno accademico 2012, pp. 240-241.
Sitografia
Renzoni, TEMPESTI, Giovanni Battista in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 95 (2019). https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-tempesti_%28Dizionario-Biografico%29/
Menichetti, Crespina espone i suoi orgogli agresti Silvestro Lega invita i macchiaioli in villa, Il Tirreno (Livorno), Archivio, 09/03/1998. https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/1998/03/09/LN104.html
Festa delle civette
https://www.terredipisa.it/events/antica-fiera-delle-civette-crespina-lorenzana/
GIOVANNI DELLA ROBBIA: FIRENZE E IL CONTADO
A cura di Luisa Generali
Introduzione
La lavorazione della terracotta invetriata, diffusa nelle forme rinascimentali dalla bottega dei della Robbia, venne aggiornata nel corso del Cinquecento da Giovanni della Robbia (1469-1530 c.), terzogenito di Andrea, che prese le redini della bottega ed estese ulteriormente a Firenze e nel contado l'arte di famiglia, incoraggiandone la fruizione in termini più popolari.
Allontanatosi dalla prima produzione robbiana, Giovanni ne rinnovò il linguaggio in base alle moderne tendenze cinquecentesche, accostandosi ad uno stile molto più esuberante, fondato su una vivace policromia di forte impatto visivo. Il grande cambiamento apportato dalle nuove generazioni, fra cui oltre a Giovanni si ricorda anche l’attività dei fratelli, Fra’ Mattia (1468-1532 c.) e Luca Bartolomeo (1475-1548), fu senz’altro l’uso totalizzante degli smalti colorati che ricoprivano e differenziavano le varie componenti dell’opera come in un dipinto, ricorrendo a un ricco repertorio cromatico, enfatizzato da vivaci contrasti. Svincolati dalla solennità scultorea delle figure bianche su fondale azzurro che aveva reso ben nota l’arte dei della Robbia nel Quattrocento, i soggetti rappresentati si animarono di policromie, accentuando gli effetti pittorici. La bottega rafforzò inoltre nella produzione l'utilizzo di motivi ornamentali derivati dall' architettura e dall'arte classica (quali ghirlande di frutta, racemi fitomorfi, candelabre, rabeschi ecc.), ricorrendo a un corredo di motivi sovrabbondanti che dovevano meravigliare per l'eccessivo decorativismo e i colori brillanti: la combinazione creata dall’unione di queste componenti, sebbene gli esiti siano spesso esagerati, è il vero timbro distintivo dello stile di Giovanni che troverà grande riscontro sul territorio fiorentino, soprattutto in contesti ecclesiastici. Tra le tipologie di opere più frequenti nel catalogo robbiano cinquecentesco si nota una particolare attitudine alla modellazione in rilievo che ben si prestava, alla stregua di un quadro tridimensionale, ad oggetti devozionali quali pale d'altare (sempre più monumentali e complesse), tabernacoli eucaristici, fonti battesimali ed edicole. Gestite come ampie specchiature dove accogliere icone mariane oppure storie del Vangelo, le superfici piane divenivano lo spazio ideale su cui costruire una minuziosa narrazione, spesso aperta su ambienti e paesaggi molto dettagliati, racchiusi in schemi decorativi altrettanto copiosi. Il dato descrittivo degli episodi, unito agli esiti realistici determinati degli smalti colorati, aveva il merito di avvicinare il fedele alla comprensione di tali immagini ed aumentarne il senso di compartecipazione emotiva e spirituale. Tali caratteristiche, volutamente devozionali, spiegano l’ampia diffusione sul territorio dei manufatti robbiani, declinati in una vasta gamma di varianti, pur rimanendo sempre inconfondibili nello stile. Lo sviluppo della bottega dovette anche il suo exploit ai ritmi di lavoro sempre più celeri, grazie a stampi e calchi che permisero la serializzazione di alcuni pezzi, in modo da consentire una rapida esecuzione e costi contenuti.
Soffermandosi invece sui soggetti iconografici più ricorrenti si noterà come gran parte di questi siano spesso palesi citazioni tratte da opere di Andrea Verrocchio (1435-1488), Domenico Ghirlandaio (1448-1494), ed altri celebri artisti della cerchia fiorentina. Questi richiami iconografici, talvolta interpretati come prodotti artigianali privi di originalità, sono stati in tempi recenti riletti dalla critica e giudicati come parte integrante dello scambio fra le arti, in cui pittura e scultura dialogavano e si influenzano costantemente. Il recupero di tali fonti visive, ormai assunte dalla collettività come modelli insuperabili, era inoltre una prassi comune nel Cinquecento per ribadire la grandiosità del recente passato e renderlo fruibile anche in contesti più periferici.
Opere
La prima opera attribuita internamente a Giovanni della Robbia al di fuori dell’orbita paterna è il Lavamani in marmo e terracotta (1498), posto nella sagrestia di Santa Maria Novella, considerato un unicum tra le suppellettili di questo tipo (fig.1). La committenza degli stessi frati domenicani è rivelata dalla presenza del blasone centrale inserito nel soprarco della lunetta, appena sopra il rilievo raffigurante la Madonna col Bambino fra angeli, che denuncia ancora gli influssi della tradizione di famiglia, ed in particolare della maniera di Andrea. L’insistente decorativismo che unisce motivi classici a geometrie ripetitive, congiuntamente a ghirlande e vasi ricolmi di frutta, delinea fin da subito il netto cambiamento di rotta che distinguerà il nuovo linguaggio robbiano. Risalta centralmente, nella lunetta interna alla struttura, il delicato e colorito scenario lagunare in maiolica dipinta, allusivo alla purezza dell’acqua impiegata per gli abituali riti di abluzione (fig.2).
Tra gli arredi liturgici più richiesti alla bottega di Giovanni, i fonti battesimali esagonali furono una tipologia molto apprezzata soprattutto nel contado fiorentino, dove ancora si conservano alcuni esempi molto simili tra loro nel formato e nell’iconografia. La reiterazione di tali modelli fu una pratica molto in voga, come dimostrano i fonti battesimali di Galatrona, in provincia di Arezzo, riferibile all’anno 1510 e quello di San Pietro a Sieve (FI), datato al 1518, modellati entrambi nelle specchiature con Storie di San Giovanni Battista e classicamente smaltati di bianco (fig.3-4). Lo stesso schema, ma nella variante policroma, viene riproposto a Cerreto Guidi (FI) nel 1511 e a San Donato in Poggio (FI) nel fonte datato 1513. Prendendo a modello l’opera di Cerreto Guidi nella Chiesa di San Leonardo, immediate appaiono le citazioni tratte dal Battesimo di Cristo di Verrocchio (1472-1475), con il noto intervento di Leonardo da Vinci agli esordi (fig.5-6), e il San Giovannino nel deserto (1485-90) di Domenico Ghirlandaio nel ciclo di affreschi della Cappella Tornabuoni a Santa Maria Novella (fig.7-8).
Il sodalizio con l’architettura, già ampliamente sviluppato dagli avi di Giovanni (basti pensare ai celeberrimi tondi robbiani degli Innocenti), venne portato avanti dalla bottega che eccelse fra l’altro nella realizzazione di lunette: fra queste ricordiamo per il particolare pregio i pezzi oggi esposti a Villa la Quiete, un tempo nella chiesa di San Iacopo a Ripoli, raffiguranti l’Incredulità di San Tommaso e il Noli me tangere (primi decenni del XVI secolo). In origine realizzate a conclusione degli altari della chiesa, le due mezzelune congiungono l’uso dei colori nel paesaggio al nitore delle figure smaltate di bianco, secondo ancora le consuetudini tradizionali.
Nell’Incredulità di San Tommaso attribuita a Giovanni (fig.9), il dettagliato paesaggio esterno in cui è ambientata la scena, ricco di minuzie naturalistiche, vegetali e animali, sottolinea il candore del gruppo centrale, puntualmente derivato dall’opera di Andrea Verrocchio a Orsanmichele (fig.10). La medesima impostazione coloristica è adottata nel Noli me tangere (fig.11), attribuita alla collaborazione tra Giovanni e il fratello Marco (fra’ Mattia), in cui emerge un’attenta coerenza spaziale dello scorcio paesaggistico, molto ben calibrata nel lento degradare prospettico verso la città.
Un tono diverso assumono invece le lunette risalenti al secondo e terzo decennio del secolo: corpose nei volumi e nei colori, spiccano per il pittoricismo che vogliono imitare, ottenendo un immediato effetto decorativo. Di grande fascino è la lunetta della Visitazione (1517) al Museo Bandini di Fiesole (fig.12), in cui la soluzione policroma del cielo, disteso a pennellate sfumate, prepara l’atmosfera dell’incontro fra Maria e Elisabetta. Risalgono invece al 1521 le due lunette al Bargello raffiguranti Le Marie al sepolcro e l’Annunciazione (fig.13-14), attribuite a Giovanni nel suo stile più noto e popolare, improntato alla costruzione delle immagini secondo gli schemi pittorici del classicismo cinquecentesco.
Al secondo-terzo decennio del XVI secolo appartiene anche il Ciborio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa (FI), uno tra i molti esemplari esistenti della stessa tipologia, ricalcati e prodotti quasi serialmente per le chiese del contado (fig.15). La struttura modellata sulle ormai assodate formule rinascimentali si sviluppa sui diversi piani della composizione, scandita da cornici dentellate ed eterogenei motivi decorativi. Ai lati dello sportello, due angeli in adorazione aleggiano su un pavimento rivestito di piastrelle scorciate prospetticamente.

Fra i vertici delle “robbiane” attribuite alla mano di Giovanni si trova anche il dossale raffigurante Adamo ed Eva (fig.16), commissionato per il passaggio di Papa Leone X in visita a Firenze nel 1515. La pala ritrae il momento della tentazione da parte del serpente, ritratto con una testa di donna dalle sembianze simili a quelle di Eva. I corpi nivei dei progenitori, modellati quasi a tutto tondo, si stagliano sulla parete arborea del fondale, occupata in gran parte dalla chioma dell’Albero della Conoscenza del bene e del male su cui posano diversi animali. Anche in questo caso la critica ha rintracciato come fonte visiva di confronto l’incisione del tedesco Albrecht Dürer (1504) di medesimo soggetto (fig.17). Tuttavia, fonti d’ispirazione simile non dovevano certo mancare nella stessa Firenze, come dimostra il brano ad affresco dipinto da Masolino da Panicale nel 1424-1425 nella Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (fig.18).

Esemplare dell’opera di Giovanni nella sua maturità è la pala del Presepio (1521), proveniente dalla chiesa di San Girolamo delle Poverine, oggi conservata al Bargello (fig.19). L’opera, caratterizzata dall’evidente pittoricismo, sorprende per la monumentalità e la vividezza dei colori che distinguono l’ampio scenario aperto alle spalle della natività. Dello stesso periodo (1522) è il Tabernacolo delle Fonticine in Via Nazionale, così chiamato per la sua funzione di fontana pubblica, riportato all’antico splendore da un recente restauro (fig.20). La struttura si articola intorno al vano centrale occupato dalla grande pala raffigurante la Madonna col Bambino, affiancata dai Santi Jacopo, Lorenzo e Giovannino. Al di sopra il Padre Eterno e una teoria di angeli adoranti determinano una cornice interna che si conclude con le Sante Barbara e Caterina d’Alessandria, entrambe poste in due nicchie laterali. La densa concentrazione di elementi figurativi e ornamentali crea un effetto vicino all’horror vacui (terrore del vuoto), che trova un corrispettivo anche nella cornice esterna addobbata da festoni e teste di Santi.
Di questa tipologia si presenta anche la Madonna col Bambino e San Giovannino per il Castello dei Conti Guidi a Vinci, datata al 1523 (fig.21). Insieme all’immancabile ghirlanda di frutta che contorna la pala centinata, anche il fondale presenta una copertura ad arabeschi, formando un motivo decorativo molto elegante che vuole designare il drappo del trono su cui siede la Vergine.

Avviandosi verso gli ultimi lavori di Giovanni della Robbia, a tutti gli effetti fra i protagonisti del XVI secolo, non possiamo non ricordare i sessantasei medaglioni per il cortile della Certosa del Galluzzo (1523), da cui sporgono magnifiche teste raffiguranti vari personaggi allegorici e cristologici di una bellezza ideale e antica. Secondo un revival bicromatico, l’incarnato lattiginoso delle teste si accompagna a note di colore gialle e celesti (fig.22-23-24-25). L’impresa del Galluzzo fu probabilmente coadiuvata dal fratello Luca Bartolomeo della Robbia e da Giovan Francesco Rustici (1475-1554), valente scultore e ceramista fiorentino, che sulle medesime linee cromatiche dei medaglioni sopracitati impostò anche il suo Noli me tangere con Sant’Agostino nella lunetta (secondo decennio del XVI secolo), oggi al Bargello; secondo il Vasari quest’ultima opera fu invetriata in collaborazione proprio con Giovanni della Robbia (fig.26). L’episodio dell’incontro fra Gesù e Maria è realizzato in smalto bianco mentre al colore giallo è assegnato lo spazio dell’orizzonte, metaforicamente allusivo agli sfondi dorati, segno della presenza della grazia divina. A Rustici va il merito di aver saputo lavorare la terracotta alla stregua del marmo, elaborando un finissimo stiacciato che delinea minuziosamente il contesto esterno in cui si svolge la scena.

Dopo la scomparsa di Giovanni l’eredità della bottega, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non fu raccolta tanto dai figli, quanto piuttosto dalla famiglia Buglioni (in particolare da Benedetto e Santi), che oltre alle tecniche di lavorazione acquisì anche il tipico linguaggio artistico robbiano, detenendo il monopolio della terracotta invetriata fino alla seconda metà del Cinquecento.
Bibliografia
- Campigli, Scheda 1 (Bottega di Giovanni della Robbia, Tabernacolo eucaristico, Chiesa di Santa Maria Assunta, Bassa), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, p. 36.
- Campigli, Scheda 16 (Giovanni della Robbia, Fonte battesimale, Pieve di san Leonardo, Cerreto Guidi), in Visibile pregare, Ospedaletto 2000, pag. 64-65.
- Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.
- Gentilini, F. Petrucci, F. Domestici, “Della Robbia”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014.
- G. Vaccari, “La tecnica della terracotta invetriata”, in Art dossier; 134.1998, Firenze 2014, pp. 17-18.
- Galli, N. Rowley, Un vergiliato tra le sculture del Quattrocento, in Santa Maria Novella: Dalla "Trinità" di Masaccio alla metà del Cinquecento, a cura di A. De Marchi e C. Sisi, Vol. II, Firenze 2016, pp. 59-95.
- Visonà, R. Balleri, Dagli altari della chiesa di San Jacopo di Ripoli al Conservatorio delle Montalve a La Quiete: le terrecotte invetriate di Giovanni e Marco della Robbia e oltre, in Capolavori a Villa La Quiete, Catalogo della mostra a cura C. Giometti, D. Pegazzano, Villa la Quiete, Firenze,26 luglio-30 ottobre 2016, Firenze 2016, pp. 77-101.
Sitografia
- Gentilini, DELLA ROBBIA, Giovanni Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 37 (1989): http://www.treccani.it/enciclopedia/della-robbia-giovanni-antonio_%28Dizionario-Biografico%29/
Pala d’altare, Adamo ed Eva: https://art.thewalters.org/detail/35961/adam-and-eve/
Tabernacolo delle Fonticine: https://2017.gonews.it/2016/12/12/terminato-restauro-del-tabernacolo-delle-fonticine-via-nazionale/
Lunetta, La visitazione: https://www.piccoligrandimusei.it/blog/portfolio_page/museo-bandini-di-fiesole/
Certosa del Galluzzo: http://www.certosadifirenze.it/
I DELLA ROBBIA E LA TERRACOTTA INVETRIATA
A cura di Luisa Generali
La scultura dei della Robbia: alcuni esempi
È di qualche mese fa l’accordo per la restituzione da parte dell’Italia alla Germania della Maddalena attribuita ad Andrea della Robbia (fig. 1-2), opera sottratta a una famiglia ebrea tedesca che ne era proprietaria durante il secondo conflitto mondiale. Finita in Italia erroneamente e qui rimasta a lungo, l’opera rappresenta una giovane Maddalena, dai tratti acerbi e l’espressione innocente, secondo un’interpretazione del tutto contraria allo stereotipo del suo personaggio di peccatrice penitente, peraltro inesatto; nella rappresentazione di della Robbia completamente smaltata di bianco, Maria di Magdala è restituita, infatti, secondo le sembianze di una fedele seguace di Gesù, dall'aspetto esile e il volto luminoso, scoperto dai lunghi capelli mossi, particolare iconografico che caratterizza le immagini della Santa a cui si uniscono anche gli attributi dell’ampolla contente l’unguento profumato e il libro, simbolo di conoscenza. L’opera in questione offre anche l’occasione per ripercorrere le vicende della bottega che l’ha realizzata, iniziando dal maestro della terracotta invetriata, Luca della Robbia (1399-1482), a cui andò il merito di aver perfezionato questa tecnica secondo gli ideali rinascimentali che si andavano definendo in Toscana.
Nel panorama dei grandi scultori del Rinascimento fiorentino Luca della Robbia si formò come scultore sull’esempio classicista di Nanni di Banco (1380/1390 c.-1421), grazie al quale divenne uno dei maggiori esponenti della tradizione antica, a paragone del più rivoluzionario Donatello (1386-1466): un confronto di stili che la storia dell’arte ha riconosciuto come paradigma nelle famose Cantorie per il duomo di Firenze.
Negli anni ‘40 del Quattrocento Luca della Robbia iniziò a sperimentare la tecnica della terracotta invetriata, creando rilievi in creta rivestiti di smalto colorato e cotti, dall’effetto finale sorprendentemente luminoso. I benefici portati dalla smaltatura erano su più fronti vantaggiosi, in quanto la superficie impermeabile acquisiva una resistenza maggiore agli agenti atmosferici e manteneva inalterato lo splendore dei colori, oltre al lato economico che vedeva la ceramica molto meno dispendiosa rispetto ad altri materiali. Anche Vasari nelle sue Vite non manca di ricordare l’invenzione di Luca come un “ghiribizzo” geniale, sottolineando i vantaggi pratici di questa tecnica, insieme alla sua grande diffusione: “Et avendo una maravigliosa pratica nella terra, la quale diligentissimamente lavorava, trovò il modo di invetriare essa terra co’l fuoco, in una maniera che e’ non la potesse offendere né acqua né vento. E riuscitoli tale invenzione, lasciò dopo sé eredi e figliuoli di tal secreto. E così fino al tempo nostro, i suoi descendenti hanno lavorato di tal mestiero, e non solo ripiena di ciò tutta la Italia, ma e mandatone ancora in diverse parti del mondo. “[…] Onde Luca della Robbia merita somma lode, avendo alla scultura questa parte aggiunta, potendosi con bellezza e con non molta spesa ogni luogo acquatico et umido abbellire”.
La tecnica dell’invetriatura rappresentava la rinascita di un’abilità già conosciuta dagli antichi, che Luca della Robbia seppe reimpiegare nelle forme del linguaggio rinascimentale, portando la terracotta al pari delle altre arti maestre, secondo una tavolozza standardizzata sulle cromie dell'azzurro e del bianco, rispettivamente adottate per gli sfondi e le figure. Altre tonalità (come il giallo, il verde, il bruno, il nero) vengono progressivamente inserite nelle opere robbiane per la colorazione di dettagli decorativi quali ghirlande, fregi vegetali e di frutta, mattonelle a motivi tessili, decori a grottesche e candelabra, costituendo un insieme di elementi esornativi che sanciranno il marchio di fabbrica della bottega.
La prima applicazione dell’invetriatura risalente al 1442 è documentata nel Tabernacolo del Sacramento originariamente realizzato per la Cappella di San Luca dello Spedale di Santa Maria Nuova, oggi nella chiesa di Santa Maria a Peretola (fig.3). L’artista per il tabernacolo murario crea una struttura in marmo a forma di edicola, definita da lesene scanalate con capitelli corinzi e culminante in un timpano al cui interno è raffigurato Dio Padre benedicente. Alla lavorazione della pietra utilizzata per definire la struttura e i rilievi figurativi, si affianca per la prima volta l’uso della ceramica invetriata: l’azzurro fa da fondale alla Deposizione nella lunetta, mentre un festone vegetale inframezzato da tre teste di cherubini corre sull’architrave. Sono preziosissimi i particolari decorativi sperimentati in questa prima opera, che saranno ampliamente sviluppati dalla bottega dei della Robbia nel corso del tempo: qui già compare il tema esornativo dei fiori modellati a rilievo in diverse qualità e colori in mezzo alle ghirlande, mentre nella base si stende un fregio a nastro con motivi a rosette blu, arricchito da “pattern” erbacei su sfondo nero che si ritrovano anche nei pennacchi della lunetta (fig.4).
La tecnica della terracotta invetriata fu eseguita non solo per opere in rilievo ma anche per gruppi statuari a tutto tondo come nel caso della Visitazione compiuta intorno al 1445 per la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, dove ancora oggi è esposta (fig.5). L’opera è uno fra i primi lavori di grandi dimensioni attribuiti a Luca della Robbia, che per la scena dell’abbraccio fra Elisabetta e Maria scelse di rappresentare entrambe con un avvolgente colore bianco. L’armonia dei corpi e la loro gestualità passano attraverso la formazione classica dell’artista, che per la Vergine modella un ovale perfetto, ideale di pura bellezza. Tratti più naturalistici segnano invece il volto anziano di Sant’Elisabetta, inginocchiata di fronte a Maria e immersa con questa in una comunione empatica di sguardi.

Ma senz’altro sono le innumerevoli immagini devozionali raffiguranti la Madonna col Bambino conservate nei principali musei del mondo a sancire il successo della bottega dei della Robbia attraverso il canone ormai fissato nell’immaginario collettivo delle terrecotte smaltate a figure bianche su fondale azzurro. Questa formula visiva sarà una costante della bottega come dimostrano gli esempi dalla Madonna della mela (fig.6) e la Madonna del Roseto (fig.7), entrambe conservate al Bargello. Se nella prima opera la figura di Maria è rappresentata a tre quarti in un’ambientazione astratta, nella Madonna del roseto madre e figlio sono invece collocati a figura intera in un giardino di cespugli verdeggianti e rose bianche, chiuso da uno spicchio di cielo. In entrambi i rilievi risalta la magnificenza rigorosa della Vergine, velata e assorta nella contemplazione malinconica del suo stato di madre, mentre Gesù tiene in mano un frutto rotondeggiante, identificato con la mela, simbolo legato alla redenzione dal peccato originale tramite il suo sacrificio.
Intorno alla metà del secolo la bottega si arricchì del talento del giovane Andrea della Robbia (1435-1525), nipote di Luca, dal quale apprese i segreti dell’invetriatura e ne ereditò le formule compositive di successo: fra queste il tema della Madonna col Bambino fu una delle tipologie maggiormente sviluppate dallo scultore, che seppe conferire al rapporto fra madre e figlio una più tenera affettuosità. Un esempio è rappresentato dalla pala centinata per lo Spedale di Santa Maria Nuova (fig.8), databile intorno al 1470-75, in cui Andrea addolcì la classica maniera austera dello zio, a favore di un maggior naturalismo delle figure: nell’opera anche il fondale azzurro viene privato quella sua componente astratta divenendo un cielo atmosferico, solcato da filiformi nuvole.

Queste celebri opere votive hanno conosciuto una fortuna tale che sono entrate a tutti gli effetti nella tradizione figurativa italiana, continuando ancora oggi ad essere riprodotte in diverse varianti come oggetti di devozione domestica specialmente nella forma di tondi e medaglioni.
La compresenza nella bottega di Luca e Andrea della Robbia fino al 1482, anno in cui il nipote ne ereditò la bottega, solleva qualche dubbio attributivo in merito a certe opere, come nel caso del Busto di Santa al Bargello, databile negli anni 1465-70 (fig.9). Impostata sul modello dei busti reliquari per cui non si esclude un’originaria funzione, la Santa presenta il classico nitore robbiano del volto, accompagnato da una spiccata colorazione dei dettagli, fra cui risalta la deliziosa spilla a forma di fiore che allaccia la mantella.

L’intensità degli smalti e il repertorio figurativo che caratterizzava le terrecotte dei dell Robbia ne fecero anche un’arte decorativa molto apprezzata proprio per lo spiccato senso ornamentale, andando quindi a interfacciarsi con diverse tipologie di opere impiegate in contesti architettonici, quali stemmi, fregi, cornicioni, lunette ecc. Fra gli apporti ornamentali che la bottega intraprese in importanti edifici ricordiamo i famosissimi Tondi raffiguranti bambini in fasce, realizzati nel 1487 da Andrea della Robbia per il loggiato esterno dell’Ospedale degli Innocenti (fig.10). Ognuno dei dieci medaglioni raffiguranti bambini in terracotta bianca su fondo blu mostra particolari diversificati nella gestualità e nelle caratteristiche tipicamente puerili degli infanti, restituite dall’artista con attenta verosimiglianza.

Il tema della puerizia è affrontato anche nel Busto di fanciullo al Bargello (fig.11), che la critica riferisce ad Andrea della Robbia negli anni tra il 1465 e 1470: la scultura si inserisce nel prolifico filone rinascimentale dedicato ai ritratti di bambini, spesso ricollegato alla devozione per Gesù Bambino e San Giovannino. L’artista sceglie una colorazione monocroma per il volto e i capelli del fanciullo, mentre dispone le uniche note di colore nell'abito e nelle iridi, in modo da enfatizzarne il vivace sguardo: la verosimiglianza naturalistica e l’inclinazione sentimentale che caratterizza l’aspetto del bambino riconducono allo stile di Andrea, sensibile alle novità della pittura coeva.

La sobria armonia che caratterizza la prima linea di produzione della bottega dei della Robbia mutò con l’arrivo del nuovo secolo verso un linguaggio molto più narrativo, vicino all’intenso coinvolgimento che sapeva suscitare l’odierna pittura. Fra i discendenti della famiglia della Robbia fu Giovanni (1469-1529/30), figlio di Andrea, uno degli esponenti più attivi nella ridefinizione dello stile dei della Robbia, incentrato sulla messa in opera di grandi pale d’altare ricolme di personaggi e dettagli ornamentali dai colori sgargianti.
La Pietà (fig.12) realizzata da Giovanni della Robbia nel 1514 e conservata al Bargello costituisce un esempio del lessico artistico adottato dalla bottega nel XVI secolo, all’insegna di un abbondante decorativismo che, come in questo caso, spesso muta in un vero e proprio horror vacui. L’opera, raffigurante la pietà fra Santa Maria Maddalena e San Giovanni, riduce la consistenza plastica dei rilievi e insiste molto sul dato pittorico nella descrizione esuberante del paesaggio, aperto sullo sfondo verso la città di Gerusalemme: nel mezzo un cielo surreale, striato da inquiete nuvole gialle, partecipa metaforicamente al dramma della morte di Cristo.

Bibliografia
Petrucci, Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’ Mattia), Giovanni della Robbia, Luca della Robbia il "Giovane", Francesco della Robbia (Fra’ Ambrogio), Girolamo della Robbia, Santi di Michele Buglioni, Firenze 2008.
Ciseri, “Scultura del Quattrocento a Firenze”, in Art e dossier, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.
Tardelli, "La Visitazione", Luca della Robbia: nella chiesa di San Leone, Pistoia 2017.
Fonti
Vasari (ed. 1550), Vita di Luca della Robbia scultore, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Ed. a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Vol. I, pag. 232-235, Torino 2015.
LA GROTTA GRANDE DI BOBOLI
A cura di Luisa Generali
Tra gli angoli più suggestivi di Boboli un capitolo a parte deve essere obbligatoriamente riservato alla Grotta Grande detta anche del Buontalenti (fig.1), uno spazio artificiale in cui il concetto di mimesi della natura si unisce al linguaggio artistico manierista, in una complessa antologia di significati metaforici.

Alla stregua dei due esempi fiorentini precedenti, la Grotta di Madama (nello stesso giardino di Boboli) e la Grotta degli animali a Castello, Francesco I de’ Medici (1541-1587), erede di Cosimo, commissionò la Grotta Grande di Boboli all'architetto Bernardo Buontalenti (1531-1608) che impostò il suo programma su un ambiente già esistente, il vivaio, realizzato da Davide Fortini e Giorgio Vasari negli anni ’50 del Cinquecento, il cui scopo originario era quello di conservare l’acqua proveniente dalla sorgente della Ginevra, come scorta per Palazzo Vecchio. Appartiene a questa prima fase dei lavori, iniziata sotto il ducato cosimiano, la soluzione della facciata “all’antica”, aperta da un pronao distilo sostenuto da colonne in pietra rossa che ancora oggi costituiscono il prospetto frontale della grotta. Risalenti a questo periodo sono anche le due nicchie ai lati del loggiato, dove nel 1560 vennero collocate le sculture di Apollo (fig.2) e Cerere (fig.3) di Baccio Bandinelli (1493-1560) in collaborazione con Giovanni Fancelli. Provenienti da contesti diversi, il pendant tra le due statue fu creato ad hoc, trasformando l’Eva, che Baccio Bandinelli aveva proposto per il coro di Santa Maria del Fiore (poi scartata), in Cerere, divinità della terra e dei raccolti, accompagnata dal grano e dal serpente come attributi. La scultura dell’Apollo venne invece ideata su ispirazione michelangiolesca, riproponendo in scala minore le forme del David, qui declinato nelle vesti iconografiche di un Apollo pitico nel momento successivo allo scontro col drago-serpente Pitone. La parte sommitale della facciata è animata da un ornato decorativo composto da un molteplice impiego di elementi terrestri e marini che preludono all'ambientazione interna dell’antro; il fondale intorno all'arcata centrale è inoltre spartito simmetricamente da un disegno a campiture geometriche realizzato in tessere musive. Giacciono semi-sdraiate a fianco del blasone mediceo due allegorie femminili, identificate come la Pace e la Giustizia o Concordia, qualità identificative del regno toscano, mentre chiudono i lati esterni del prospetto alcune partiture ornamentali elogiative e di gusto classico.
Passando all'interno della grotta (fig.4), risale agli anni compresi fra il 1583 e il 1593 l’intervento buontalentiano che estese e trasformò l’originario vivaio in un ampio spazio articolato in tre camere comunicanti fra loro, interamente ornate da opere plastiche e pittoriche. Il filo conduttore che unisce i tre vani venne forse indicato dallo stesso duca, Francesco I, amante dell’arte e appassionato di alchimia, la cui fama di sovrano eccentrico è rimasta immutata nei secoli. Sono molteplici le commissioni che Francesco assegnò ai suoi artisti unendo agli intenti celebrativi le sue bizzarre passioni al confine fra scienza ed esoterismo, nell'intento inarrestabile di apprendere i segreti ignoti del creato. Fra i più noti lavori promossi dal duca ricordiamo il parco di Pratolino, ritratto in una delle celebri lunette di Giusto Utens (l’assetto originario è stato nei secoli trascurato e modificato), in cui fu riversata tutta la genialità del duca, stravolgendo il tipico rigore simmetrico dei giardini all'italiana per privilegiare piuttosto l’aspetto meraviglioso e incantevole offerto dalla natura (fig.5). Anche in questo caso Buontalenti si occupò di elaborare l’impianto del giardino scegliendo un’impronta scenografica, tipica buontalentiana, con un dispiegarsi intrecciato di sentieri, vie e viottoli, a cui si alternavano bacini d’acqua, fontane e grotte dagli svariati e fantasiosi connotati.
Ugualmente famosissimo come riflesso delle passioni incondizionate del duca è il suo studiolo privato in Palazzo Vecchio (fig.6), luogo intimo concepito per esporre curiosità e oggetti da collezione, a cui faceva da cornice, nell'allestimento ancora oggi immutato, un preziosissimo programma icnografico fondato sui quattro elementi naturali e simbologie alchemiche.

Le bizzarre passioni di Francesco I furono documentati in un dipinto di Giovanni Stradano (1523-1605), Il laboratorio dell’alchimista (1580 c.), presente proprio nello studiolo, in cui lo stesso sovrano è ritratto in primo piano sulla destra, nel bel mezzo di un esperimento alchemico, all'interno del movimentato laboratorio che venne allestito appositamente nel Casino di San Marco (fig.7). Lo stile nitido dello Stradano, di origini fiamminghe, mette in luce i dettagli più inusuali di questa officina, disseminata di strumenti e macchinari di ignara funzione.

Rispetto ai significati allegorici in chiave celebrativa della dinastia Medici che costellavano con immagini simboliche la Grotticina di Madama e quella di Castello, la Grotta Grande di Boboli assume piuttosto i connotati di un percorso di conoscenza, introspettivo, che l’uomo deve esplorare per giungere alla verità. Questo viaggio immersivo che trae origine dalle cavità ancestrali e primigenie dell’universo, rappresentate nella prima camera della grotta, attraversa la natura selvaggia, i miti antichi e la storia, che grazie al cammino nelle profondità dell’antro conducono gradualmente l’umanità verso la civiltà e la conoscenza.
Sul significato recondito della grotta una lettura più precisa ci viene suggerita dall'episodio ritraente lo Sbarco a Itaca (1561-62), opera del sopracitato Stradano, presente nella parete nord della Sala di Penelope in Palazzo Vecchio (fig.8). Il brano pittorico racconta il momento dell’arrivo di Ulisse a Itaca mentre giace nel sonno, vegliato dalla presenza di Minerva nelle vesti di un giovane pastore, trasportando visivamente il relativo passo del capito tredici tratto dall’Odissea:
"In capo al porto vi è un olivo dalle ampie foglie:
vicino è un antro amabile, oscuro,
sacro alle Ninfe chiamate Naiadi;
in esso sono crateri e anfore
di pietra; lì le api ripongono il miele.
E vi sono alti telai di pietra, dove le Ninfe
tessono manti purpurei, meraviglia a vedersi;
qui scorrono acque perenni; due porte vi sono,
una, volta a Borea, è la discesa degli uomini,
l’altra, invece, che si volge a Noto, è per gli dèi e non la
varcano gli uomini, ma è il cammino degli immortali."
Proprio su questa citazione in cui si riferisce di “un antro amabile, oscuro, sacro alle Ninfe chiamate Naiadi”, il filosofo e intellettuale platonico di origine fenicia Porfirio (233 c.-305 c.) ne trasse un’intera esegesi, illustrando puntualmente il ruolo della grotta nel suo significato metaforico di cosmo, considerando gli antri come “simbolo del mondo sensibile, per il fatto che sono oscuri, petrosi, umidi; e tale è il mondo, a causa della materia di cui è costituito […]”. Porfirio continua provando come gli antichi “considerassero l’antro simbolo non solo, come si è detto, del cosmo, cioè del generato e del sensibile, ma l’oscurità degli antri li indusse a vedervi il simbolo anche di tutte le potenze invisibili, la cui essenza appunto non è percepibile allo sguardo. Di qui, penso, presero spunto anche i pitagorici e, dopo di loro, Platone quando chiamarono il cosmo antro e caverna. In Empedocle, infatti, le potenze che guidano l’anima dicono: «siamo giunte in questo antro coperto»; e in Platone nel settimo libro della Repubblica si dice di «una dimora a forma di caverna sotterranea»".

L’interpretazione filosofica di Porfirio di rimando al famoso mito della caverna di Platone potrebbe aver suggerito un parallelismo fra Ulisse, immagine dell’uomo viaggiatore alla scoperta della conoscenza, e il duca Francesco I come l’eroe omerico in costante ricerca della verità, metaforicamente espressa dal percorso iniziatico a cui sottintende il programma iconografico della Grotta Grande di Boboli. Anche il riferimento alle Ninfe Naiadi non appare casuale se si considera queste come “simbolo delle anime che discendono nella generazione, essendo potenze che presiedono alle acque e simbolo di vita”, per cui difatti sarà proprio l’acqua a costituire un elemento imprescindibile nella genesi delle spelonche artificiali cinquecentesche.
Tornando alla Grotta Grande di Boboli, la prima e più arcana tappa di questo viaggio simbolico si manifesta immediatamente nel grande vano d’accesso, le cui pareti laterali sono interamente decorate da opere plastiche raffiguranti esseri antropomorfi e paesaggi naturali realizzati in spugne e stalattiti, misti a minerali, pietrisco e tessere musive, opera di Pietro Mati. Tali figure danno luogo a due cicli narrativi interpretati come il mito di Deucalione e Pirra e l’origine dell’uomo, e una Scena arcaica-pastorale popolata da ninfe e pastori immersi in un clima idilliaco, placidamente in simbiosi con la natura (fig.9-10-11-12). L’uso delle pietre e i minerali colorati, quali corallo, quarzo ed ematite, per definire certi particolari di tali “figure di terra”, insieme allo stillicidio dell’acqua, restituivano un meraviglioso effetto luminoso, accentuato dai giochi di luce e ombra mossi dal guizzo dei pesci posti in un acquario a forma di bolla sull'oculo della cupola. Questa trovata ingegnosa attribuita all'incredibile fantasia di Buontalenti si andava a sposare magnificamente con gli affreschi di Bernardino Poccetti (1548-1612), che decorò la volta come una grande foresta suddivisa in cadenti spicchi arborei da cui si affacciano animali nostrani ed esotici, curiosi delle vicende umane (fig. 13-14-15-16-17). L’impressione d’insieme, oggi in parte alterata dal corso dei secoli, doveva essere quella di trovarsi avvolti in un contesto arcano, sorvegliati dalle titaniche presenze genitrici della terra, al centro di un microcosmo ancora caotico e selvaggio, in cui l’uomo ai primordi della sua esistenza viveva una favolosa età dell’oro. Alcuni cenni della civilizzazione che avanza nelle fasi dopo la creazione dell’uomo sono presenti nelle scene di genere affrescate appena sotto l’imposta della volta, raffiguranti le prime attività del genere umano sulla terra, impegnato in occupazioni come la pesca, o l’estrazione della pietra.

I chiari intenti cosmogonici presenti nel programma figurativo della Grotta Grande di Boboli si relazionano alla compresenza dei quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, dalla cui unione, secondo le dottrine alchemiche, avrebbe avuto origine il cosmo. La terra, come elemento principe delle cavità rocciose, viene qui illustrata dal mito di Deucalione e Pirra, coppia di sposi che dopo il diluvio universale dette nuova vita all'umanità gettando dietro le loro spalle alcune pietre, raccolte dalla Madre Terra, da cui presero forma l’uomo e la donna. Il riferimento al fuoco, nell'accezione qui di magma primigenio, si trova anche sottilmente evocato nella figura mitica di Prometeo, padre di Deucalione, che rubò questo elemento agli dei per consegnarlo agli uomini. L’acqua ricorre come principio fondante della grotta, bagnando le concrezioni calcaree delle pareti, mentre due vasche perimetrali dovevano imitare il flusso scrosciante e continuo di un piccolo torrente. L’aria invece figura nella cupola nell'apertura sommitale della volta e negli sprazzi di cielo affrescati.
Il tema dei quattro elementi appare nuovamente in modo più esplicito nel programma decorativo della Tribuna (1581-1583) voluta da Francesco I come monumentale stanza delle meraviglie all'interno degli Uffizi, assegnata ancora una volta al progetto del fidato Buontalenti (fig.18). La sala ottagonale è suddivisa in base alla simbologia degli elementi naturali, ognuno dei quali ricopre una sezione specifica dell’architettura, in modo da allestire un microcosmo equilibrato e perfetto. A cominciare dall'alto, in unione con la volta celeste, l’elemento dell’aria è suggerito dalla lanterna, collegata a un meccanismo che segnalava l’orientamento dei venti, oltre a fungere da meridiana. L’acqua è invece platealmente evocata nella decorazione della cupola disseminata di conchiglie regolarmente disposte (fig.19-20), utilizzate anche nel tamburo per realizzare racemi e motivi decorativi in madreperla (fig.21). Il fuoco risalta nel colore rosso acceso delle pareti rivestite di velluto, mentre la terra è rappresentata dai commessi marmorei che tappezzano il pavimentano.


Nel 1585 la Grotta Grande di Boboli si arricchì dei quattro Prigioni o Schiavi di Michelangelo (oggi sostituiti da copie) donati dal nipote dello scultore a Cosimo I e collocati in questa data nei quattro angoli del vano, come per sorreggere l’enorme peso della cavità (fig.22). I Prigioni, identificati come Schiavo giovane, Schiavo barbuto, Atlante e Schiavo che si ridesta (1525-1530 c.), esattamente pertinenti al clima senza tempo che si respira nella spelonca, esemplificano alla perfezione l’arte michelangiolesca del non finito, resa vibrante e spasmodica nello sforzo tormentoso dei corpi di volersi liberare dalla pietra che li ha generati pur rimanendovi eternamente intrappolati.

È nel secondo vano di collegamento tra le due camere maggiori che si ha un’evoluzione nel cammino dell’uomo a diretto confronto con il mito e il glorioso passato, rievocato nelle Storie mitologiche greco-romane affrescate sulla piccola volta dal Poccetti e Giuseppe di Luca Gieri. Fa da raccordo con l’ultima stanza il gruppo scultoreo interpretato come Enea e Didone (1558) di Vincenzo de’ Rossi (1525-1587), probabilmente qui sistemato in relazione alle pitture sopracitate ed evocando forse un sottile riferimento propagandistico che vedeva la grandezza di Firenze erede diretta di quella romana (fig.23).

Dopo la scomparsa del granduca Francesco nel 1587 la grotta fu conclusa dal fratello Ferdinando I (1549-1609) che si occupò di terminare l’ultima camera (fig. 24-25-26-27), metafora conclusiva della raggiunta consapevolezza dell’uomo che ha ripercorso le sue origini per approdare alla verità e alla bellezza, interpretata dall'arte manierista, nelle forme armoniose della Venere Anadiomene di Giambologna (1573). La conoscenza del cosmo e il suo dominio si trovano dichiarate nella decorazione della volta in cui, a differenza del bosco selvaggio che popolava la copertura della prima camera la natura è controllata da un geometrico e impeccabile graticolato percorso da tralci vegetali e fiori. Anche l’elemento dell’acqua è sottoposto al controllo meticoloso dell’ingegno umano, come succede nella fontana della sopracitata Venere, dove esili zampilli uscivano dalle bocche dei quattro maliziosi satiri (forse personificazione dei venti Zefiro, Ostro, Tramontana, Levante) affacciati alla tazza (fig.28-29), opera dell’equipe di scalpellini a seguito di Battista del Tadda (notizie 1565/1617). Confermano infine l’importanza del luogo i cosiddetti “Monti di Cristallo” (fig.30), nicchie simili a grandi ninfei di evocazione romana, contenti escrescenze calcaree e minerali, percorsi da rivoli d’acqua e montati in preziosissime cavità contornate da tessere musive ed elementi naturali di varia provenienza.
Bibliografia
M. Lorandi, Scheda Stradano, Sbarco a Itaca, in Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del Cinquecento italiano, Milano 1996, pp. 264-265.
G. Girgenti, Introduzione a Porfirio, Roma-Bari 1997.
L. Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo -(Milano) 2003, pp. 68-94.
L. Medri, La grotta del Buontalenti, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 97-98.
Sitografia
Scheda relativa alla Cerere di Baccio Bandinelli: https://www.uffizi.it/opere/bandinelli-cerere-grotta
Scheda relativa all’Apollo di Baccio Bandinelli: https://www.uffizi.it/opere/bandinelli-apollo-grotta
Approfondimento sui Prigioni o Schiavi di Michelangelo: www.accademia.org/it/esplora-il-museo/le-opere/i-prigioni-schiavi-di-michelangelo/
Scheda relativa alla Tribuna, Uffizi: https://www.uffizi.it/opere/la-tribuna
Approfondimento Enea e Didone di Vincenzo de’ Rossi: www.polomuseale.firenze.it/dodicimesidarte/?u=sezioni/ottobre.php