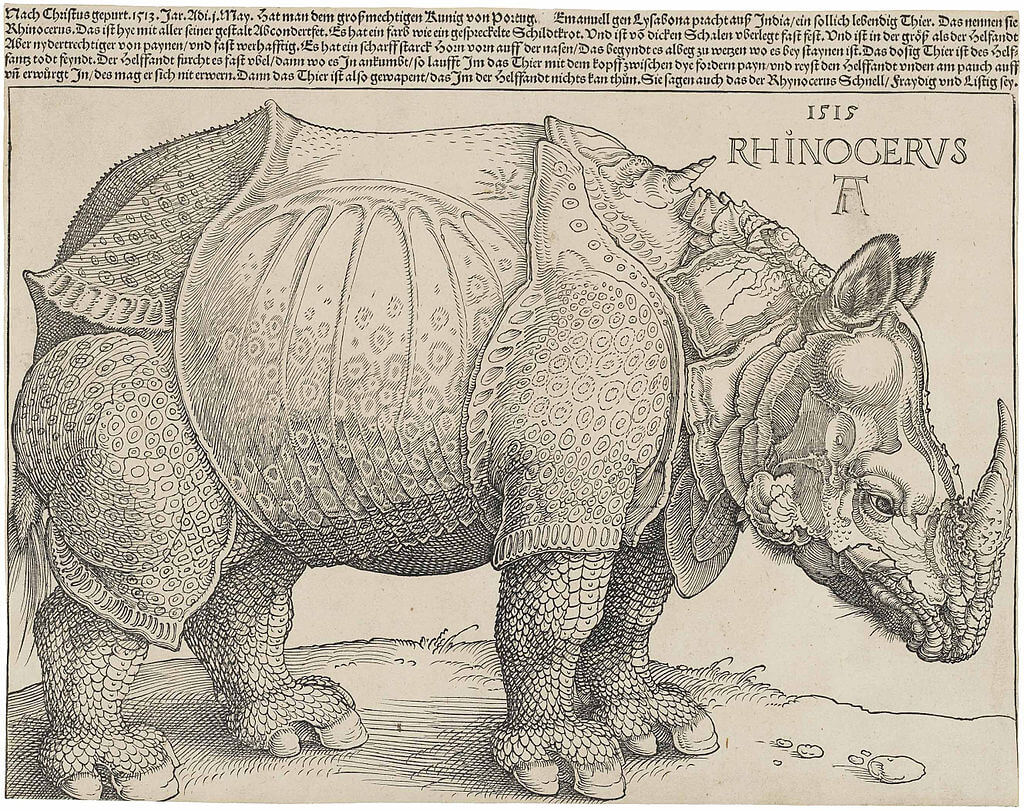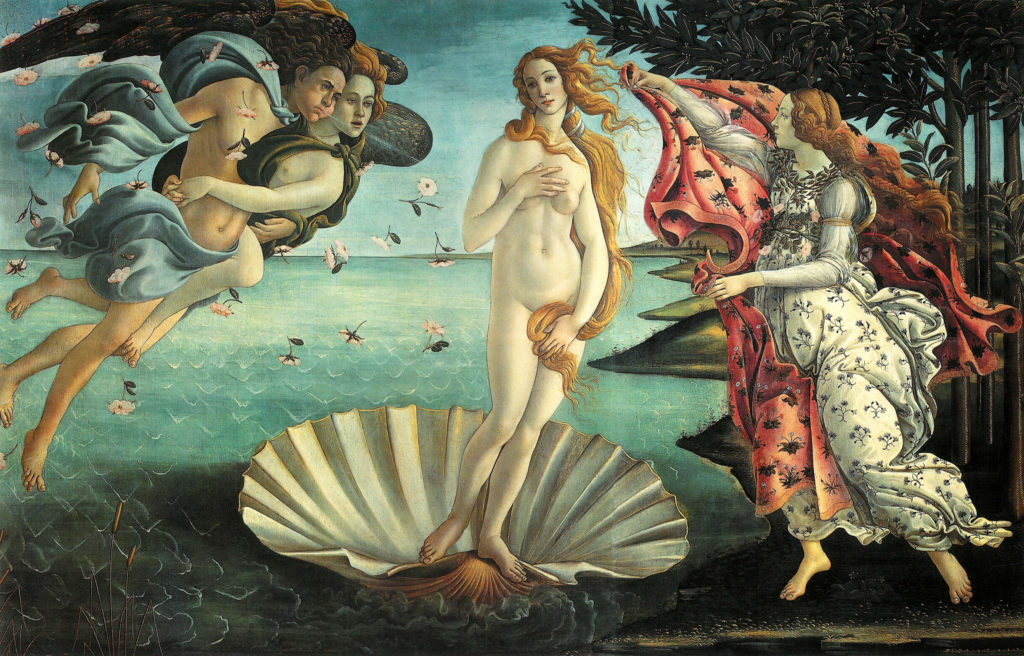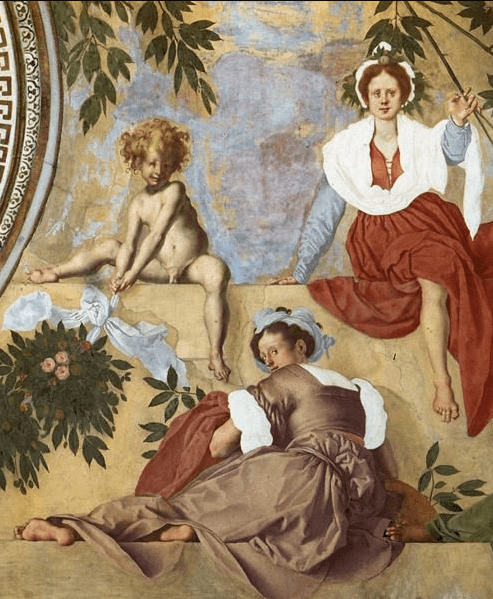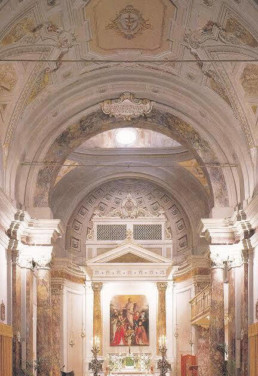LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA
A cura di Luisa Generali
Introduzione: mitici antri
Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.
La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale
La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.
Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.
Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia
Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.
Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione
Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe
Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.
Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.
Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".
Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).
Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.
Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).
Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.
Bibliografia
Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.
Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/
Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.
Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.
Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.
Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.
Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.
Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.
Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.
Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.
Sitografia
Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363
Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi
LE FONTANE A FIRENZE: TRA ARTE E ACQUA
A cura di Luisa Generali
Acqua che “colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”[1]
Il ruolo celebrativo delle fontane
A partire dal ducato di Cosimo I (1537) e con la successiva istituzione del granducato mediceo (1569) le fontane assunsero a Firenze un ruolo celebrativo sempre più rilevante, congiuntamente alla riorganizzazione delle aree verdi annesse ai palazzi del potere e alle ville di delizia. Fu il parco di Castello (fig.1-2), località alle porte di Firenze, il primo giardino ad essere rinnovato in chiave encomiastica, grazie alla commissione affidata dallo stesso Cosimo al progettista e scultore Niccolò dei Pericoli (1500 c.- 1550), soprannominato “Tribolo” per l’atteggiamento costantemente irrequieto. Formatosi come allievo di Jacopo Sansovino, con occhio vigile alle novità pittoriche che gravitavano intorno alla bottega di Andrea del Sarto, Tribolo cominciò a guadagnarsi i primi favori spostandosi su importanti cantieri italiani, fino ad ottenere la fiducia di Michelangelo, che lo ingaggiò come suo collaboratore per la sistemazione delle tombe medicee nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.
La residenza di Castello conservava un diretto legame con le radici storiche della casata, quando già nel 1477 venne acquistata da Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, del ramo cadetto della famiglia Medici, e successivamente ereditata da Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo. Vasari ci informa che proprio qui nel XVI secolo erano esposte le opere maestre di Sandro Botticelli: La Primavera e La nascita di Venere. Oggi la villa di Castello è sede dell’Accademia della Crusca, aperta alle visite degli ambienti interni su appuntamento.
Unitamente alle operazioni di ingegneria idraulica e alla progettazione architettonica dell’area collinare retrostante la dimora, la parte ideologica-celebrativa che il giardino doveva allusivamente significare venne teorizzata da un intellettuale-umanista di corte vicino al duca, forse Benedetto Varchi (1503-1565), affinché le proprie conoscenze letterarie e filosofiche potessero esaltare al meglio le glorie medicee. Immaginando una sinergia fra un’equipe di diversi esperti, il progetto a terrazzamenti adottato da Tribolo, secondo il modello del Belvedere Vaticano, ben si prestava per un’immediata rappresentazione del potere personale e dinastico di Cosimo I, attraverso il percorso dell’acqua che sarebbe discesa sfruttando la pendenza del giardino. Lo scopo ideologico del parco era quello di rappresentare l’età dell’oro nuovamente raggiunta in Toscana grazie al nesso fra natura ed arte, procedendo dal caos della selva (personificata dalla fontana del gigante Appennino) nella parte alta del terrazzamento anche detta “vivaio”, verso la Grotta degli animali: questa doveva riprodurre una sorta di microcosmo del regno animale tramite statue in pietra e bronzo raffiguranti molteplici specie, pacificate le une con le altre sotto il ducato cosimiano. L’acqua avrebbe in seguito percorso l’asse centrale, confluendo in un bacino dedicato a Venere, per poi terminare trionfalmente nel giardino all’italiana, metafora di ordine e rigore, dove si innalzava la fontana di Ercole e Anteo.
I lavori per Castello, che impegnarono Tribolo dal 1538 fino alla sua morte nel 1550, passarono progressivamente in secondo piano, valicati dal restauro di Palazzo Vecchio e il nuovo cantiere di Palazzo Pitti con annesso il giardino di Boboli, il cui primo programma fu assegnato allo stesso Tribolo nel 1549.
Il ruolo assunto dagli arredi da giardino viene osservato anche da Giorgio Vasari, che nelle sue Vite, nella parte introduttiva all’arte dell’architettura, dedica un trafiletto alle fontane rustiche realizzate con incrostazione di tartari e spugne, secondo l’imitazione artificiale della natura già sperimentata dagli antichi: tramite sistemi di cannelle inserite appositamente nella parete, l’acqua diviene elemento vivificante che “piove per le colature di questi tartari, e colando fa dolcezza nell’udire e bellezze nel vedere”.
Non dovevano discostarsi troppo dalle indicazioni vasariane le fontane a parete concepite da Tribolo per i due muraglioni che spartivano il giardino di Castello (il primo a conclusione del bacino di Venere e il secondo di contenimento del terrapieno di cui faceva parte la Grotta): entrambe le pareti dovevano accogliere una coppia di nicchie contenenti statue-fontana che avevano lo scopo di rappresentare un omaggio alla geografia dei territori fiorentini, ritraendo in forma antropomorfa i monti Senario e Falterona (nelle nicchie ai lati della Grotta), da cui avevano sorgente i rispettivi fiumi Mugnone e Arno (nelle nicchie adiacenti al bacino di Venere). Di questo complesso allestimento rustico, in parte non completato e in parte perduto, sopravvive l’Allegoria di Fiesole, attribuita all’unanimità a Tribolo e databile intorno al 1545, oggi al Museo Nazionale del Bargello (fig.3). La scultura, sbozzata nella pietra serena, costituiva la parete di fondo della nicchia contente la statua-fontana del Fiume Mugnone (oggi perduta), per una lettura simbolica combinata delle due figure, in quanto il torrente del Mugnone, affluente dell’Arno, trova la sua sorgente proprio in territorio fiesolano. Come riporta Vasari: “[…] dietro questo fiume è una femmina figurata per Fiesole, la quale tutta ignuda nel mezzo della nicchia esce fra le spugne di que’sassi, tenendo in mano una luna, che è l’antica insegna de’ Fiesolani”. L’artista scolpisce la sagoma di Fiesole come una creatura primordiale appena nata dalle viscere della roccia, mentre si svincola da questa assumendo forma umana. La pietra serena, per le sue caratteristiche naturali, contribuisce ad un effetto arcaico dell’opera che doveva artificiosamente riprodurre un contesto agreste e mitico; inoltre l’intero blocco è lavorato nell’imitazione di una vera parete rocciosa da cui pendono stalattiti e incrostazioni calcaree. La rotazione del corpo di Fiesole ricorda il movimento dei Nudi per le tombe medicee nella Sagrestia Nuova di Michelangelo (1520-1534 c.), così come lo sforzo per la liberazione dal masso che la contiene sembra essere una citazione diretta dei celebri Prigioni (1513-1515).

Lungo l’asse prospettico del viale, nella discesa che porta gradualmente verso il dominio sempre più controllato della natura, furono messe in opera due fontane monumentali a “candelabra”, sviluppate cioè su un alto e slanciato fusto in marmo, secondo un prototipo molto di moda nel primo Cinquecento fiorentino: entrambe elaborate sui modelli di Tribolo, la realizzazione effettiva degli apparati scultorei fu portata avanti dal maestro insieme a un folto gruppo di collaboratori, fra cui il nipote d’arte del celeberrimo Leonardo, Pier Francesco di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci (1530-1553). Il giovane Pierino, su cui gravava l’enorme aspettativa che potesse eguagliare la genialità dello zio, divenne allievo di Tribolo nel grande cantiere di Castello, dove si misurò con temi e soggetti all’antica che ben si coniugarono ai suoi interessi per l’arte classica.
È suggestiva l’ipotesi interpretativa che vedrebbe l’immagine di Pierino da Vinci nel Ritratto di un giovane di Agnolo Bronzino (1503-1572) alla National Gallery di Londra (fig.4), databile intorno alla metà de l XVI secolo: questa proposta identificativa, pur rimanendo incerta e del tutto da comprovare, è stata suggerita tramite il riconoscimento della statua sullo sfondo raffigurante Bacco con un’opera di medesimo soggetto, realizzata da Pierino intorno al 1547 e oggi andata persa.

Nonostante le scarse documentazioni e la breve vita di Pierino, morto all’età di soli ventitré anni, è stato possibile ricostruire un corpus di opere a lui riferibili, di cui racconta anche Vasari. Fra gli esempi più comunicativi dello stile dell’artista si trova la fontana da giardino raffigurante un Puer mingens, conservata al Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo, e in origine commissionata dalla famiglia Rinieri a Tribolo, che a sua volta affidò il lavoro a Pierino (fig.5). Emerge nell’opera una ricerca capillare nel restituire la spontaneità ilare dei bambini, esibita nell’atteggiamento vivace e soprattutto nell’ampia risata che sembra rievocare certe affinità con gli studi leonardiani sull’espressività e i moti dell’animo. La stessa cura nella lavorazione morbidissima del marmo e l’interesse al dato naturale si trova enunciata anche nella statua-fontana raffigurante un Dio fluviale (oggi al Louvre di Parigi), capolavoro di Pierino da Vinci, donato da Eleonora di Toledo al fratello García di Toledo, per il giardino napoletano di Chiaia (fig.6). Se nella figura del dio giovinetto si può riscontrare una fedeltà pedissequa ai canoni classici, quel pittoricismo di matrice leonardiana ritorna nei teneri puttini che sorreggono l’anfora da cui doveva sgorgare l’acqua, ed in maniera evidente nel volto divertito del genietto più grande, il cui spontaneo sorriso traspone plasticamente i famosi sorrisi di Leonardo.
Tornando a Castello, lungo il viale prospettico retrostante la villa, nelle prossimità della Grotta degli animali, trovava posto la Fontana di Venere-Fiorenza nel mezzo al “laberinto”, una selva fitta di sempreverdi composta secondo la testimonianza vasariana da “cipressi, lauri e mortelle, i quali girando in tondo fanno la forma d’un laberinto”. La fontana assumeva i connotati di un’oasi acquatica elevata su un ampio bacino, “delimitato da un sedere di pietra bigia sostenuto da branche di leone tramezzati da mostri marini di basso rilievo”.
Per un migliore chiarimento sull’originario aspetto cinquecentesco del giardino ci viene in aiuto la veduta aerea della tenuta medicea di Castello, eseguita tra il 1599 e il 1602 dal pittore fiammingo Giusto Utens su commissione di Ferdinando I de Medici, che fece realizzare un insieme di diciassette lunette ritraenti i più rilevanti possedimenti familiari (fig.7). L’opera, esposta alla Petraia insieme alle altre quattordici lunette rimaste, mostra l’estensione del giardino retrostante la villa, sviluppato lungo il viale prospettico dove centralmente copre un notevole spazio il boschetto circolare (o labirinto) intorno alla Fontana di Venere. Trasferita interamente alla villa della Petraia nel Settecento e sistemata in uno spazio del giardino detto “Piano della Figurina” (dove si trova ancora oggi), la fontana ha perso la sua connotazione originaria “a isola” poiché privata dello specchio d'acqua su cui doveva innalzarsi (fig.8). La candelabra marmorea esibisce ricche partizioni decorative in rilievo incentrate sul recupero del linguaggio figurativo antico che Tribolo potette studiare personalmente nei suoi viaggi a Roma. La parte inferiore del piede è avvolta da un anello di creature ibride, per metà dall’aspetto umano e per metà pesci, uniti per le code e con le braccia sollevate nell’atto di sostenere la struttura (fig.9): tra i mostri marini, che hanno l’intento celebrativo di festeggiare l’acqua, si inframezzano inserti in rilievo, mentre la grande tazza soprastante è percorsa da genietti reggi-ghirlande. L’addobbo scultoreo del fusto continua verso la vetta ampiamente ornata da fantasiosi fregi mitologici, tra cui si notano figure di satiri scolpiti con grande perizia attribuiti alla mano di Pierino da Vinci: poco più in alto alcuni puttini a tutto tondo seduti su volute formano un anello marcapiano. Conclude l’estremità della candelabra un cerchio di mascheroni, mentre al di sotto dell’ultimo catino dei genietti in volo si avvicendano a teste mostruose dalle cui fauci veniva gettata l’acqua (fig.10). Al culmine della candelabra in marmo si eleva la statua di Venere come allegoria di una rinata Fiorenza, già teorizzata da Tribolo ma terminata solo nei decenni successivi da Giambologna. Secondo la critica una corretta lettura allegorica del labirinto e della fontana potrebbe riferirsi a un possibile parallelismo con le opere botticelliane, la Nascita di Venere e la Primavera, al tempo esposte nell’adiacente villa, come omaggio all’età d’oro laurenziana (fig.11-12). Lo stretto vincolo nel labirinto fra acqua e natura poteva riflettersi nei due capolavori, entrambi dedicati al culto della dea, nella celebrazione della sua nascita dalla schiuma del mare, e della natura, esplicata attraverso il trionfo della primavera, in una ripresa di ideali neoplatonici per cui la bellezza e l’amore divengono la forza spirituale dell’universo; questa corrispondenza incrociata con i dipinti di Botticelli sarebbe inoltre avvalorata dall’interpretazione della Nascita di Venere più correttamente letta come l’Approdo di Venere sull’isola di Cipro, intendendo cioè la struttura della stessa fontana insieme al suo bacino come un’allegoria dell’isola dove giunse la divinità appena nata.
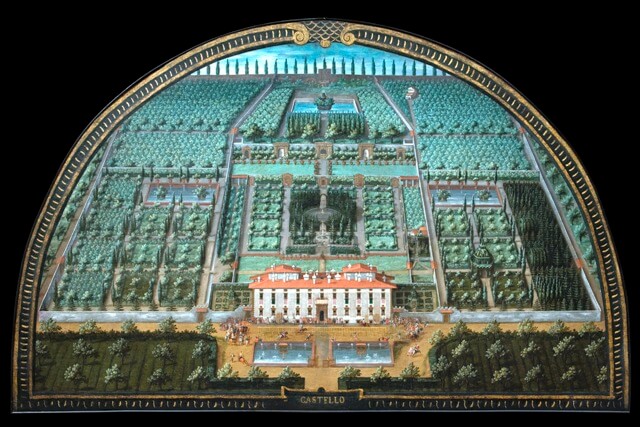



Per la candelabra della fontana maggiore dedicata a Ercole e Anteo (ancora collocata a Castello), Tribolo pensò invece a un tipo di decorazione plastica a tema ludico-fanciullesco, variando questo motivo su vari livelli del fusto, in relazione al rapporto giocoso dei putti con l’acqua (fig.13). Lo sviluppo della candelabra su tre bacini, il primo dei quali costituito da una bassa vasca ottagonale, è interrotto a più riprese da alcuni nodi dove prendono posto rilievi ornamentali e sculture. La prima articolazione che congiunge l’ottagono con il bacino maggiore, ospita intorno alla base una teoria di maschere in bassorilievo insieme ad una serie di allegri puttini a tutto tondo seduti sul bordo (fig.14). A tal proposito le parole di Vasari esprimono al meglio lo scopo piacevole che i giochi d’acqua e l’arredamento statuario dovevano provocare negli ospiti del giardino: “ […] traboccando del pari le acque di tutta la fonte, versa intorno una bellissima pioggia a uso di grondaia nel detto vaso a otto facce; onde i detti putti che sono in sul piede della tazza non si bagnano, e pare che mostrino con molta vaghezza quasi fanciullescamente essersi là entro per non bagnarsi scherzando ritirati intorno al labbro della tazza.” Nel secondo nodo è invece rappresentata una danza di ridenti fanciulli, restituiti (forse dallo stesso Tribolo) attraverso uno spiccato naturalismo che ne sottolinea il carattere giocoso; è ribadita inoltre l’intenzione burlesca presente nelle oche che gettano acqua dal becco mentre i pargoletti si divertono a strizzarli il collo (fig.15-16). L’ultima tazza presenta invece sul bordo esterno una sequenza di teste di capricorno, ascendente astrale di Cosimo, assunto come impresa di buon auspicio e tradizionalmente associato a vittoriosi condottieri (fig.17).



Il motivo esornativo degli spiritosi puttini viene dunque recuperato dall’arte antica e spesso abbinato nel Cinquecento a un contesto di delizia, in sintonia con i giochi d’acqua delle fontane, accostando il clima leggiadro dei giardini alla spensieratezza tipica dell’infanzia. Nella storia artistica fiorentina Verrocchio si era già confrontato con il tema della fanciullezza nella fontana raffigurante un Putto con delfino, commissionata in un primo momento per il giardino della villa di Careggi e poi trasferita al centro del cortile di Michelozzo in Palazzo Vecchio (oggi l’originale si trova nel percorso espositivo di Palazzo Vecchio). La scultura bronzea ritrae un amorino alato in leggera torsione, in equilibrio su una sola gamba, mentre cerca di trattenere uno sguizzante delfino dalla cui bocca usciva uno zampillo d’acqua (fig.18). Il recupero del soggetto antico è qui ravvivato da un moderno naturalismo, ulteriormente espresso dal dinamismo e la libertà di movimento della scultura a tutto tondo in relazione all’ambiente circostante.

Rappresentano un esempio analogo di concepire la tridimensionalità scultorea nello spazio i quattro fanciulli bronzei sull’orlo del bacino maggiore nella Fontana di Ercole e Anteo a Castello, sostituiti in loco da copie, mentre gli originali si trovano alla Petraia (fig.19-20-21-22-23): se Vasari assegnava totalmente il merito a Pierino da Vinci, la critica oggi è piuttosto propensa a riconoscervi la presenza di più mani che avrebbero eseguito i modelli su indicazione di Tribolo. Le pose assunte dalle sculture indagano l’aspetto motorio dei corpi portati al limite dell’equilibrismo che serve per mantenerli in bilico: di questi capricciosi fanciullini soltanto uno si presenta seduto, mentre gli altri giacciono sul bordo in spigliate attitudini, sgambettando fra gli sprizzi d’acqua.

Il moto dei corpi, insieme all’inclinazione naturalistica, ricorda le prime sperimentazioni tese a interpretare in maniera sempre più vera e autentica la tridimensionalità dei volumi nello spazio, a partire da alcuni esempi grafici: ne è una testimonianza l’esercizio attribuito al Verrocchio nel foglio raffigurante uno Studio di putti, (fine XV secolo, Parigi Louvre, Cabinet des dessins), in cui sono velocemente disegnati dei bambini in movimento, articolati in diverse pose e atteggiamenti (fig.24).

Un’indagine analoga è condotta da Leonardo da Vinci (1452-1519) nel Bambino della Madonna dei Fusi, eseguita in vari adattamenti, di cui qui si riporta la versione più celebre conservata in una collezione privata di New York (fig.25), databile agli inizi del primo Cinquecento e probabilmente commissionata da Florimond Robertet, funzionario del re francese Luigi XII. La tavola, considerata un lavoro di collaborazione tra il maestro e la bottega, conserva quelle peculiarità per cui Vasari riconosce nell’opera leonardiana la maniera moderna, in quanto “dette veramente alle sue figure il moto et il fiato”. Tali caratteristiche ritornano nell’aspetto del piccolo Gesù dalle guance paffute, il sorriso infante e nella rotazione del corpicino, carico di potenza plastica e slanciato verso la croce.
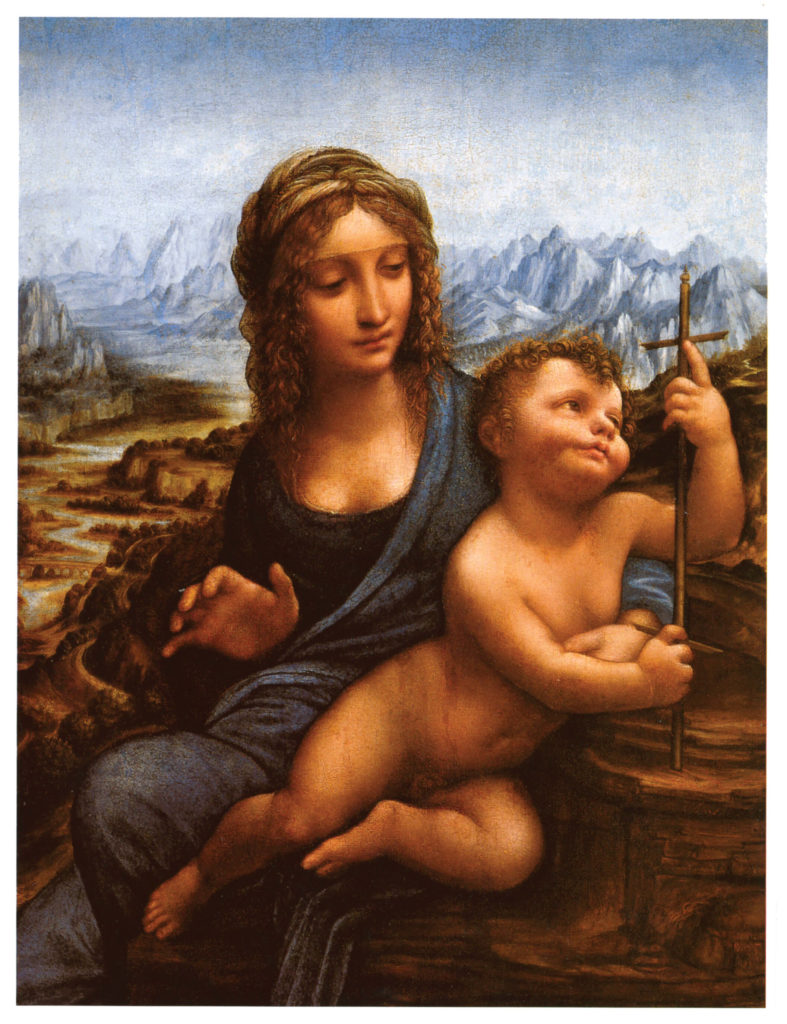
Sembrano intrattenere alcune affinità figurative con Castello gli affreschi per il salone della Villa di Poggio a Caiano, dove più tardi anche lo stesso Tribolo collaborò su richiesta di Cosimo I ad alcuni lavori progettuali per la tenuta. In merito alla decorazione parietale del salone, commissionato nel 1519 da Papa Leone X Medici ad Andrea del Sarto (1486 -1530), Franciabigio (1482 c.-1525) e Pontormo (1494-1557), vennero scelti episodi mitologici e della storia romana che elogiassero allegoricamente le glorie di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico. Nell’affresco di Andrea del Sarto, raffigurante il Tributo a Cesare (1521), l’impianto classicista si apre a certi guizzi protomanieristi riscontrabili in alcuni dettagli, quali il palpitante bambinello in primo piano (fig.26); potrebbero inoltre rappresentare un modello diretto per la fontana tribolesca i fanciulli affrescati da Pontormo nella lunetta dedicata a Vertumno e Pomona (1520-21) per lo stesso salone di Poggio a Caiano (fig.27). Nell’omaggiare il mito ovidiano in cui si celebra la rinascita primaverile della natura in chiave encomiastica, i fanciulli reggi-ghirlanda, seduti in modo smaliziato sul parapetto, diventano il simbolo di una libertà fresca e leggera, di cui si nutrirà proprio l’anticonvenzionale pittura pontormesca (fig.28-29).


Dopo la morte di Tribolo il progetto per il giardino Castello fu portato avanti da Davide Fortini e da Vasari, mentre la realizzazione di due importanti sculture venne assegnata a Bartolomeo Ammannati (1511-1592): al momento dei lavori granducali lo scultore aveva già alle spalle una rilevante formazione, iniziata nella bottega di Bandinelli e proseguita a Venezia, sotto la direzione di Jacopo Sansovino, e a Roma alle dipendenze di Papa Giulio III. Tra il 1555 e il 1563, rientrato a Firenze, l’artista si dedicò ai lavori per la Fontana di Giunone, anche detta Concerto di Statue (oggi ricomposta al Museo del Bargello), in origine commissionata da Cosimo I per essere posta nel Salone dei Cinquecento, addossata alla parete meridionale ed inquadrata da un magnificente prospetto architettonico (fig.30). Il gruppo scultoreo doveva mostrarsi come un “ninfeo a facciata” in uso nella Roma antica per decorare gli interni delle dimore patrizie e i complessi termali, con lo scopo di raffrescare l’ambiente e deliziare gli astanti; la lettura allegorica della fontana voleva inoltre sottintendere la prosperità del ducato mediceo e celebrare l’impegno civile del regnante per la realizzazione dei nuovi impianti idrici condotti fino in città. La struttura della fontana si articola in sei sculture disposte intorno all’arco, allusivo dell’arcobaleno su cui è seduta Giunone, divinità celeste, affiancata da una coppia di pavoni, animali a lei sacri: la dea secondo il mito si serviva di Iride (personificazione dell’arcobaleno) come sua ancella e messaggera. Al di sotto dell’arcata si trova Cerere, protettrice della terra e della fertilità, affiancata dalle statue dei fiumi Arno, nel consolidato aspetto di imponente divinità barbuta, accompagnato da un leone, e la Fonte di Parnaso, dalle sembianze di una donna, sostenuta da un cavallo alato identificato come Pegaso: dal seno di Cerere e dalle urne dei due fiumi doveva fluire l’acqua per congiungersi in un bacino (fig.31). La struttura è infine accompagnata ai lati esterni da due sculture, riconosciute dalla critica come le allegorie della Prudenza, nelle forme di un atletico giovinetto, e di Flora, immagine di Firenze. Il progetto della fontana non andò tuttavia a buon fine e le sculture subirono varie peregrinazioni, prima nel giardino di Pratolino, vicino Fiesole, ed in seguito a Boboli.
A partire dagli ultimi anni ‘50 Ammannati iniziò la sua attività per Castello, occupandosi in primis del gruppo bronzeo raffigurante Ercole e Anteo (1559-60) per la sommità della candelabra tribolesca (oggi l’originale bronzeo si trova esposto nel percorso museale di Villa la Petraia, sostituito a Castello con una copia). Il soggetto riproduce lo scontro corpo a corpo fra Ercole e il gigante Anteo, nel momento in cui l’eroe solleva l’avversario per privarlo della forza che traeva dalla madre Terra, stringendolo in un abbraccio mortale (fig.32). La vincita allegorica per cui il sovrano, identificato in Ercole, sconfigge i nemici incarnati da Anteo, irrorando con il suo sacrificio le terre toscane, segue inoltre il filo rosso della dinastia medicea in relazione diretta con il celebre bronzetto (esposto al Museo del Bargello) raffigurante lo stesso tema e commissionato da Lorenzo il Magnifico ad Antonio del Pollaiolo nel 1478 circa (fig.33): la fortuna di questo episodio mitico fu affrontata anche in pittura del medesimo artista in un quadretto ora agli Uffizi, in cui il motivo predominante della lotta è rimarcato da una spasmodica linea di contorno che segna convulsamente le sagome dei corpi e la drammaticità dei movimenti (fig.34). Mentre nelle opere del periodo laurenziano Pollaiolo evidenzia l’impeto nervoso e fremente che pervade le due figure, l’opera di Ammannati, pur riprendendo il medesimo schema d’insieme, si sofferma sulla potenza plastica dei volumi e della muscolatura.
Fra il 1563 e il 1565 Ammannati prosegue le commissioni per Castello, eseguendo il modello dell’Appennino, anche detto Gennaio (fig.35-36), per la vasca situata nell’originario vivaio (nella prima metà dell’Ottocento divenuto boschetto all’inglese) che sovrasta la Grotta degli animali: il bronzo costituisce il fulcro della fontana rustica montata su una roccia spugnosa, da dove spunta a mezza figura il bizzarro gigante infreddolito. L’immagine dell’Appennino, simbolo di protezione della natura selvaggia dei monti, è qui interpretata in maniera ironica nelle fattezze caricaturali di un grosso gigante barbuto, dalla cui testa esce uno spruzzo d’acqua.
Tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo Ammannati è invece impegnato sul cantiere per la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria (fig.37), il suo più celebre lavoro intrapreso dopo la scomparsa di Baccio Bandinelli (1560) che ne fu il primo incaricato: il significato di una fontana pubblica nel cuore del tessuto cittadino di Firenze, finalizzata a mettere in mostra la nuova rete idrica cittadina, assumeva un importante valore civico-politico, oltre che svelare platealmente le aspirazioni marittime di Cosimo I, in un ideale parallelismo con Nettuno. La celebre scultura del dio, anche rinominato dai fiorentini “Biancone” per il suo severo gigantismo che ricalca sterilmente i modi stanchi della scultura bandinelliana, si trova nel centro di un basso bacino, al comando di un cocchio su ruote “celesti” raffiguranti i segni zodiacali, e trainato da quattro scalpitanti cavalli: movimentano il perimetro della vasca sculture bronzee nelle forme di satiri, ninfe e tritoni, dallo stile vibrante e dinamico, spia della tarda maniera di cui Giambologna (1529 -1608) diverrà il più alto interprete.

Verrà affidato proprio all’artista fiammingo Jean de Boulogne il coronamento scultoreo della Fontana di Venere per il labirinto di Castello (fig.38), come già accennato in epoca lorenese integralmente spostata alla Petraia, nell’area del parco chiamato “Piano della figurina”: attualmente l’opera è stata sostituita da una copia, mentre l’originale si trova musealizzato negli ambienti della villa. Il soggetto interpretato da Giambologna era in linea con il piano iconografico originario che prevedeva sulla cima della candelabra la messa in opera di una statua raffigurante Venere anadiomene, appena nata dalle onde del mare, nell’atto di strizzarsi i capelli ancora bagnati, sgocciolanti d’acqua. Giambologna eseguì la scultura intorno al 1570-72 ed interpretò Venere-Fiorenza secondo i suoi sofisticati modelli muliebri, giocando sulla rotondità delle forme ed un’avvitata torsione del corpo; la dea alludeva inoltre alla personificazione di Firenze, come signora benevola, dispensatrice di linfa vitale per i territori del granducato, chiudendo così il cerchio iconografico del giardino, volto a magnificare il ruolo pacificatore e illuminato di Cosimo I.

Bibliografia
[1] Citazione tratta da G. Vasari, Introduzione-architettura, cap. V, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1550), Ed. Einaudi, Torino 2015, p. 38.
Vasari, Vita di Niccolò detto il Tribolo, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org
Vasari, Vita di Pierino da Vinci, in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, (Edizione 1568), Ed. Giunti 1997. Testo presente alla pagina online: www.it.wikisource.org
Pedretti, Il nipote scultore, in Pierino da Vinci, Atti della giornata di studio (Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26 maggio 1990), a cura di Marco Cianchi, Firenze 1995, pp. 13-15.
Giannotti, Niccolò Tribolo e l'invenzione della fontana e dell'isola negli spazi del giardino, in Idee di spazio, a cura di B. Garzelli; A. Giannotti; L. Spera; A. Villarini, Perugia 2010, pp. 101-112
Chapman, Disegno italiano del Quattrocento, “Art e dossier”, Dossier; 2 76.2011, Firenze 2011.
Ferretti, Bartolomeo Ammannati, la Fontana di Sala Grande e le trasformazioni del Salone dei Cinquecento da Cosimo I a Ferdinando I, in L’ acqua, la pietra, il fuoco - Bartolomeo Ammannati scultore, Catalogo della mostra a cura Beatrice Paolozzi Strozzi (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 11 maggio - 18 settembre 2011), Firenze 2011, pp. 136-155.
Ciseri, Scultura del Quattrocento a Firenze, “Art e dossier”, Dossier; 297.2013, Firenze 2013.
Giannotti, PERICOLI, Niccolò, detto il Tribolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 82 (2015), pp. 379-386.
A. Giannotti, PIER FRANCESCO di Bartolomeo, detto Pierino da Vinci, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 83 (2015), pp. 312-317.
OPERE E MODELLI PER CECCO BRAVO
Francesco Montelatici (1601-1661), più noto come Cecco Bravo, fu uno degli artisti più insoliti e rivoluzionari del Seicento fiorentino, ricordato soprattutto per gli apici di eccentricità raggiunti nelle opere pittoriche del suo periodo maturo. Tuttavia, la dirompente conversione anti-accademica, che gli valse tanta fama tardivamente, non ricevette al tempo i consensi sperati nel granducato, ma anzi contribuì probabilmente alla scelta ultima di trasferirsi presso la corte di Innsbruck, due anni prima della sua morte. Era probabilmente spia del suo carattere eclettico lo pseudonimo “Cecco Bravo”, secondo i rapidi cenni biografici ricavati dal testo di Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, da riferirsi alla presunzione dell’artista che amava autoproclamarsi molto “bravo” nel dipingere abilmente e con padronanza.
La formazione artistica del Montelatici iniziò nell’atelier di Giovanni Bilivert (1585-1644), rinomato pittore della tradizione accademica fiorentina a servizio dei Medici. Bilivert di origini olandesi e figlio d’arte, fu pittore di punta alla corte di Cosimo II, esponente di un retaggio stilistico ancora tardo cinquecentesco fondato sul disegno e la compostezza formale, a cui aggiunse brillanti effetti cromatici. Nello studio del maestro presso gli Uffizi, al giovane artista si prospettò l’opportunità di confrontarsi con i grandi protagonisti del passato e conoscere quelli contemporanei, fra cui ricordiamo il bizzarro incisore e illustratore Jacques Callot (1592-1635), residente per nove anni a Firenze in un locale limitrofe a quello di Bilivert, e da cui forse Cecco Bravo rimase persuaso; ritorneranno inoltre, come citazioni frequenti nella sua carriera, suggestioni cinquecentesche, in special modo esempi tratti dalle opere di Andrea del Sarto (1486-1530) e Pontormo (1494-1557).
Dopo i primi lavori indipendenti, fra il 1638-39 il Montelatici realizzò a Palazzo Pitti la decorazione ad affresco di due pareti per il Salone degli Argenti, raffigurando scene commemorative della casata dei Medici. Nel brano pittorico ritraente Lorenzo che accoglie Apollo e le Muse l’artista aderisce ai canoni imposti dall’ambiente granducale, adottando armoniose formule compositive e colori luminosi di derivazione cortonesca (fig.1). Nell’episodio che celebra il fiorire della cultura a Firenze grazie al Magnifico, il perno della scena è affidato alla fulgida figura di Apollo, mentre il corteo sfila e si presenta al cospetto del sovrano avvolto in un maestoso abito porpora: l’impeto di Cecco Bravo si avverte tuttavia in alcuni dettagli di secondo piano, come il putto alato sul cornicione, dallo sguardo basso, l’espressione inquieta e i capelli scomposti. Un motivo quello dei putti, che ritornerà assiduamente e che l’artista aveva già affrontato nel 1636 nel soffitto dello studio di casa Buonarroti raffigurante la Fama circondata da beffardi genietti (fig.2).


Come sottolineato dalla critica negli affreschi di Cecco Bravo per il Salone degli Argenti è stata riscontrata un’inclinazione particolarmente sentimentale riconducibile allo stile di Francesco Furini (1603-1646) che fra gli anni 1639-1642 fu impegnato proprio a fianco del collega nella parete opposta del vano: nella scena raffigurante Lorenzo il Magnifico fra i poeti e i filosofi dell'Accademia Platonica (fig.3) Furini inserisce in evidenza il corpo sinuoso di una donna ritratta da tergo, una delle immagini più ricorrenti nel repertorio dell’artista. I canoni sensuali della pittura furiniana sembrano condizionare anche Cecco Bravo che nel sopracitato affresco colloca in primo piano un elegante nudo femminile di spalle, forse un’allusione di rimando al collega. Grazie ad un soggiorno a Roma documentato nel 1619, Furini maturò uno stile ibrido, suggestionato dal caravaggismo appreso durante la frequentazione dell’atelier di Bartolomeo Manfredi (1582-1622) e gli studi classici. Una volta a Firenze l’artista limò gli insegnamenti romani, sintetizzando nelle sue opere il concetto di bellezza naturale con quello di bello ideale della tradizione fiorentina: il risultato fu un caravaggismo classico di forte impatto visivo ed emozionale, incentrato in prevalenza su candidi nudi avvolti in cupe atmosfere che ne esaltassero la sofficità dei volumi e l’incarnato. La predilezione per i corpi ritratti di spalle dalle lunghe schiene compare anche nel capolavoro di Furini (1632), tratto delle Argonautiche di Apollonio Rodio, Ila e le ninfe (fig.4, Galleria Palatina, Firenze). Il dipinto inscena il rapimento del giovane Ila, lo scudiero di Ercole, che venne sedotto e catturato dalle ninfe: l’ambientazione notturna e il mare, increspato da leggerissimi flutti simili a merletti, esaltano i malinconici nudi delle fanciulle, emergendo gradualmente dal buio alla luce. Le stesse percezioni “romantiche” si trovano anche nella grande tela dell’Hermitage raffigurante Le Tre grazie (fig.5), dipinta dall’artista intono al 1633. Dallo sfondo tenebroso affiorano i volumi perlacei dei corpi, mentre anche la testa dell’ultima dea a sinistra sembra essere inghiottita dall’ombra.
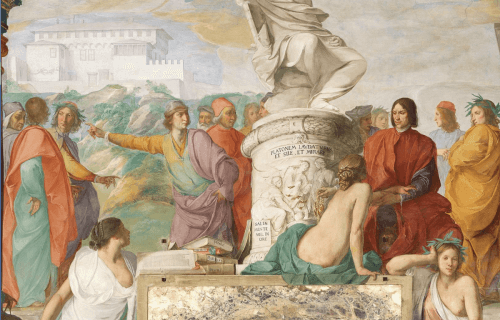


La separazione netta dal solco della tradizione fiorentina nell’opera di Cecco Bravo inizia a delinearsi più visibilmente a partire dagli anni ‘40 del Seicento, misurandosi con un tema affrontato nel 1624 anche da Bilivert: Angelica si cela a Ruggero (fig.6-7). L’episodio tratto dal poema cavalleresco di Ariosto è strutturato in entrambe le opere in maniera simile, con Ruggero intento a liberarsi dell’armatura ed Angelica che sta per scomparire dopo aver ingoiato l’anello magico che la renderà invisibile, mentre l’ippogrifo fugge in lontananza. Nella propria interpretazione (l’opera è conservata a Chicago, The University of Chicago, Smart Museum of art) Cecco Bravo scardina completamente la lezione del maestro, basata sulla perfezione formale e un uso smagliante dei colori, sostituendola con una pittura sfumata, dalle pennellate vibranti: anche il paesaggio assume dei connotati decisamente rarefatti, attraverso un evidente sfumato che offusca lo scenario. Questa tendenza verso una maniera “al naturale” con cui Cecco Bravo modella il nudo di Angelica richiama i canoni furiniani, mentre il progressivo disfacimento cromatico è dovuto, secondo la critica, ad un diretto contatto che l’artista avrebbe avuto con la pittura veneta, attraverso un viaggio al nord, dove in questo caso sarebbe stata determinante la conoscenza di Correggio (1489-1534).


La svolta coloristica di Cecco Bravo divenne inarrestabile alla metà del secolo, quando la sua attività si concentrò soprattutto in opere da cavalletto: tra gli esempi di questo periodo, si ricorda per la straordinaria forza espressiva l’Apollo e Dafne (fig.8-9, oggi alla Pinacoteca comunale di Ravenna), in cui affiora sempre più chiaramente una propensione per il colorismo veneto, in particolar modo proteso verso la maniera dell’ultimo Tiziano (1488/1490-1576). L’episodio mitologico che racconta il ratto di Dafne venne interpretato dall’artista con una veemenza pittorica senza eguali, carica di tensione e pathos, in cui il moto convulso dei due corpi è ulteriormente concitato dalle pennellate rapide e sfibrate: la scena assume i contorni di una visione sfuocata, dagli effetti visionari, immersa in un’ambientazione irreale, in cui prevalgono le tinte brune e qualche nota violacea. Cecco Bravo con questo lavoro si colloca su tutt’altro piano rispetto all’insegnamento di Bilivert che nel 1630 aveva realizzato una tela sul medesimo tema, all’insegna dell’ordine e della sontuosità, ostentata dagli sfarzosi e fagocitanti drappi che coprono i due protagonisti (fig.10 - Staatsgalerie, Stoccarda). Nell’Apollo e Dafne del Montelatici la tendenza stilistica è semmai paragonabile con quella di Tiziano nel suo ultimo periodo, per cui un’affinità nei movimenti drammatici della fuga e nell'uso materico del colore si riscontra nello Stupro di Lucrezia (fig.11), dipinto realizzato dal maestro intorno al 1570 (Vienna, Akademie der Bildenden Kunst).




L’unico freno capace di placare la libertà antiaccademica di Cecco Bravo sembra palesarsi dinanzi alle commissioni ufficiali, come dimostra la pala d’altare in onore della Madonna del Carmine fra Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria (fig.12-13), documentata nel 1655 per il santuario di San Romano (in provincia di Pisa). L’opera ancora nel luogo di origine, manifesta delle chiare influenze cinquecentesche ed in particolare sartesche, evidenti nella composizione piramidale della scena e nella caratterizzazione statuaria delle due Sante e la Vergine; sono infatti lampanti i richiami alla celeberrima Madonna delle Arpie (1517, Galleria degli Uffizi, Firenze) e alla Pala di Gambassi (1528 c., ora alla Galleria Palatina di Firenze), entrambe opere di Andrea del Sarto, artista di mezzo tra il classicismo rinascimentale e le prime tendenze manieristiche (fig.14-15). Il furore ceccobraviano emerge tuttavia nei toni cupi dell’ambientazione, rischiarata soltanto in concomitanza del vortice luminoso intorno all’apparizione di Maria, e nel bambino Gesù dal corpicino argenteo e i capelli scomposti: come abbiamo visto, anche gli eccentrici angioletti fanno parte del tipico repertorio dell’artista.




Sempre risalente agli anni ‘50 del Seicento è l’Armida (personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) una fra le opere più suggestive e singolari attribuite a Cecco Bravo, entrata a far parte della Galleria degli Uffizi nel 2017 (fig.16). Il formato della tela in origine più amplio, si presenta mancante sul lato sinistro di una parte a noi sconosciuta. L’opera ritrae Armida, principessa islamica abilissima nell’arte della magia, in preda alla collera dopo la fuga dell’amato Rinaldo, che in precedenza era riuscita a rapire grazie ai suoi sortilegi. Il momento rappresentato è proprio quello in cui Amida, divenendo oltremodo furiosa, alza lo scettro magico ed invoca gli spiriti con lo scopo di abbattere i nemici crociati ed ottenere così vendetta. Cecco Bravo interpreta la scena come un’apparizione onirica, in cui la principessa viene circondata da una massa informe ed inquietante di mostri serpentiformi dai tratti grotteschi, in un’ambientazione tenebrosa dominata da tinte scure che evocano gli effetti della magia: nel mezzo una luce tiepida svela il corpo seminudo di Armida, mostrando un’avvenente sensualità esotica. Come constatato dalla critica, punto di riferimento del Montelatici è ancora una volta il colorismo veneto dell’ultimo Tiziano, che anche a livello compositivo sembra ispirarsi ad alcune opere tarde del mastro, in particolare alle Poesie, un ciclo di dipinti dedicati alle Metamorfosi di Ovidio, destinate al re Filippo II di Spagna fra gli anni 1559-1575. In una delle tele del serie raffigurante la Morte di Atteone (oggi alla National Gallery di Londra), il passo incedente di Diana ricorda vagamente quello di Armida, insieme alla posizione delle braccia e delle vesti che scoprono in parte i corpi (fig.17).


L’Aurora circondata da geni, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig.18), è una delle ultime opere note di Cecco Bravo realizzate durante il soggiorno austriaco in concomitanza del suo trasferimento (1659 c.) alla corte dell’arciduca Ferdinando Carlo d’Austria e di Anna de’Medici a Innsbruck. La tela rappresenta il trionfo di Aurora, uno dei temi iconografici più diffusi nel Seicento, in cui solitamente la dea viene rappresentata insieme ad Apollo, ma talvolta anche distintamente, mentre attraversa la volta celeste che si rischiara. Anche in questo caso Cecco Bravo ha voluto conferire all’opera il suo estro bizzarro, raffigurando Aurora nel ruolo di una donna “autentica” e provocante, agghindata di perle e sontuosi gioielli, sospesa in aria fra una moltitudine di genietti alati: dal velo che tiene disteso con entrambe le mani ricadono dei fiori di molteplici specie e colori, mentre tutto intorno il cielo si accende di venature gialle, forse prefigurazione di una tempesta che sta per incombere, come suggerirebbero anche certe testine di putti che soffiano vento. Sullo sfondo fra un tumulto di colori rarefatti, si distingue una veduta marina, in cui compaiono alcune figure e dei vascelli in prossimità di una baia naturale. Un ipotetico modello per l’artista fiorentino si può rintracciare nel Perseo e Andromeda di Tiziano (fig.19), un dipinto delle sopracitate Poesie, ora nella Collezione Wallace di Londra. La tela mostra il condottiero mentre si slancia in combattimento per salvare Andromeda, incatenata a una rupe in attesa di essere divorata da un mostro marino, come sacrificio per ristabilire l’ordine del suo popolo dopo che la madre peccò di superbia nei confronti delle Nereidi. La scena pone in primo piano il corpo allungato della donna mentre si volta ad osservare l’eroe, che in un’ardita prospettiva si sta precipitando verso il mare: lo stesso volo “rovesciato” è rappresentato anche nell’Aurora di Cecco Bravo, in cui alla sinistra della tela, in penombra, si scorge un genietto che sta planando in maniera simile, verso un’alba che, contrariamente alla tradizione, non sembra essere di buon auspicio.


Bibliografia
Nesi, Cecco Bravo a San Romano, in “Arte”, Gennaio 1996-N. 186, pp. 16-17.
Barsanti, Alla scoperta di Cecco Bravo, in Cecco Bravo, pittore senza regola, Catalogo della mostra Firenze, Casa Buonarroti (Firenze, 23 Giugno-30 Settembre 1999), Firenze 1999, pp. 15-35.
Pinelli, Quei Ghiribizzi di Cecco Bravo, in “La Repubblica” (30.08.1999). www.ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/08/30/quei-ghiribizzi-di-cecco-bravo.html
Vagheggi, Francesco Furini, L' artista dei nudi languidi e sensuali, in “La Republica” (20.12.2007).
Da Gai, MONTELATICI, Francesco, detto Cecco Bravo, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 76, 2012.
Sitografia
Galleria degli Uffizi, Firenze:
www.uffizi.it/opere/ila-e-le-ninfe
www.uffizi.it/opere/angelica-ruggero-bilivert
www.uffizi.it/opere/cecco-bravo-armida
SEGUENDO GIAMBOLOGNA AL BARGELLO
Tra i grandi artisti che popolano con le loro sculture gli spazi espositivi del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, il fiammingo Jean de Boulogne, detto Giambologna (1529-1608), spicca come uno dei principali capisaldi del maturo Cinquecento toscano.
Dopo un primo soggiorno a Roma, la svolta decisiva per la carriera di Giambolgna ebbe inizio con il suo trasferimento a Firenze nel 1552, quando entrò sotto la protezione del mercante e intellettuale, Bernardo Vecchietti, che divenne anche suo mecenate: l’amicizia con il nobile fiorentino fu decisiva per introdurre l’artista alla corte medicea che vide nello stile virtuosistico delle sue opere la chiave di rappresentazione ideale per la celebrazione della casata.
È proprio al Bargello che è confluita una collezione considerevole di sculture in marmo e bronzo realizzate da Giambologna e bottega per la committenza medicea.
Iniziando dal cortile di quello era anticamente il Palazzo del Podestà di Firenze, si trova il grandioso Oceano (1570 circa), signore delle acque, uno dei personaggi mitici più raffigurati del XVI secolo, solitamente al centro di magnifiche fontane da giardino.
Anche l’opera di Giambologna fu infatti realizzata per la fontana dell’Isolotto di Boboli, detta appunto dell’Oceano, dove oggi per motivi conservativi è stata trasferita al Bargello e sostituita da una copia.
Il corpo della divinità, segnato da una poderosa muscolatura, restituisce un’impressione di grandiosa forza in potenza, congiunta all’intensa espressione dello sguardo catturato altrove. È invece ancora conservato a Boboli il piedistallo originale della statua, dove sono rappresentate le allegorie dei fiumi Nilo, Gange ed Eufrate, metaforicamente interpretate come le tre età dell’uomo e ispirate agli ignudi michelangioleschi, a cui si intervallano alcuni rilievi a tema marino raffiguranti la Nascita di Venere, il Trionfo di Nettuno e il Ratto d’Europa.
Procedendo sulle tracce del Giambologna al Bargello, nella prima sala al piano terra dell’edificio, fra una selva di gambe e braccia articolate in equilibristiche pose, troviamo il gruppo marmoreo raffigurante Firenze trionfante su Pisa.
Commissionato allo scultore nel 1565 in occasione del matrimonio tra Francesco de’ Medici e Giovanna d’Austria, fu immaginato per fare da pendant alla statua michelangiolesca della Vittoria nel salone dei Cinquecento. Al tempo della realizzazione di quest’opera era già attivo insieme al maestro, uno dei suoi allievi più promettenti, Pierre de Francqueville o Pietro Francavilla (1548-1615 c.), qui in veste di assistente.
Si trova in questo’operala cifra stilistica di Giambologna nel tipico movimento “serpentinato” dell’allegoria femminile di Firenze, nuda e sinuosa, nell’atto di soggiogare Pisa, rappresentata invece come un uomo barbuto in catene, sotto cui giace a sua volta una volpe, simbolo di astuzia e inganno per eccellenza.
Nelle caratteristiche fisiche del corpo pingue della donna e nel movimento tortile del bacino si ritrovano i modelli celebri della Venere al bagno reinterpretati dalla classicità in chiave manieristica dallo stesso artista: un esempio su tutti si conserva nella fontana della Grotta Grande di Boboli detta anche del Buontalenti (1531-1608), dove nella terza stanza sopra la vasca si erge il nudo armonioso della dea.
Anche nell’impianto strutturale l’opera ripropone lo schema dinamico-spiraliforme che negli stessi anni sarà portato al massimo del virtuosismo tecnico nel Ratto della Sabina, gruppo scultoreo realizzato nel 1582 e scelto da Francesco I per dimorare nella Loggia della Signoria: qui le tre figure, tratte da un unico blocco in marmo, si alzano in maniera ascensionale ruotando su loro stesse come in un vortice, dove ogni punto di osservazione si presta a uno scorcio suggestivo della scena.
Oltre alla lavorazione del marmo Giambologna fu anche un bronzista, sia di grandiose sculture che di bronzetti, oggetti preziosissimi di piccolo formato e da collezione che si ispiravano alla tradizione classica: una raccolta di questi è conservata anche al Bargello, dove si riscontrano principalmente soggetti mitici “all’antica”, figure femminili e di genere bucolico.
Poco distante dalla Firenze trionfante su Pisa, si conserva il Bacco ebbro, uno dei primi bronzi monumentali realizzati dallo scultore fiammingo per il nobile Lattanzio Cortesi, in seguito utilizzato come fontana nella nicchia alla base della Torre dei Rossi Cerchi, vicino a Ponte Vecchio, in borgo San Iacopo, dove oggi si trova una copia.
Bacco, notoriamente famoso per essere la divinità dell’ebbrezza e dell’estasi, è raffigurato in un momento di festosità, mentre incede con passo tentennante provocato dagli effetti inebrianti del vino,di cui giocosamente si compiace mostrando la coppetta vuota.
La figura elastica e longilinea del dio deriva chiaramente dal Perseo di Benvenuto Cellini (1554), con cui Giambologna si confronta abilmente nella resa perfetta dei dettagli plastici-anatomici, così come nella lavorazione del bronzo minuziosamente cesellata.
A fianco del Baccosi libra quasi come sospeso il Mercurio volante.
E’ l’opera forse più famosa e rappresentativa del repertorio artistico giambolognesco. Il corpo snello e atletico del messaggero degli dei è colto in equilibro su uno sbuffo di vento soffiato da Zefiro, l’attimo prima di spiccare il volo: la scultura divenne un vero e proprio archetipo da cui trarre copie e reinterpretazioni, riscuotendo un enorme successo anche nelle epoche successive. La commissione avvenne per Villa Medici a Roma, la residenza del cardinale Ferdinando de Medici, come ornamento della fontana all’ingresso del giardino.
Leggera e lieve è la sensazione che permea quest’opera dove la divinità si eleva con graziosa destrezza rimanendo in equilibrio su una gamba mentre tutto il corpo è già proteso verso l’alto, indicato dal gesto della mano e lo sguardo alzato.
Caratterizza Mercurio,in qualità di messo dell’Olimpo, l’attributo delle ali come mezzo fondamentale per volare e spostarsi celermente: anche nel suo bronzo Giambologna ha voluto riconoscere le qualità distintive del dio secondo l’immaginario collettivo, con le ali ai piedi e sul petaso, il copricapo diffuso nella Grecia antica tipico dei viaggiatori: due ali spiegate si trovano anche alla sommità del caduceo, il bastone della pace con i due serpenti incrociati, che divenne attributo del dio come domatore di discordie.
Attraversando la loggia esterna al primo piano dell’edificio incontriamo l’Architettura.
Riferita alla produzione di Giambologna intorno al 1565 circa, l’opera fu realizzata presumibilmente per la villa Medicea di Pratolino e poi spostata a Boboliper volontà di Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII secolo, quando vennero portati a termine numerosi interventi di riqualificazione intorno all’Isolotto e al Prato delle Colonne.
La tipologia di figura femminile seduta, che trae ispirazione dalle allegorie delle Arti realizzate per la Tomba di Michelangelo a Santa Croce, riporta i tratti distintivi della maniera giambolognesca nella modellazione soave del nudo accompagnata dalla squisita finitezza del marmo.
Dipendente da prototipi greci e reinterpretati modernamente, la donna coronata da un diadema, è identificata con la personificazione dell’Architettura o Geometria, ed è contraddistinta da una serie di attributi tipici del mestiere, come il regolo, il compasso a punte fisse, la tavoletta da disegno tenuta dietro la schiena e il piombo (impiegato per stabilire la direttrice di una linea perfettamente verticale), qui usato come ciondolo della collana.
A fianco si trova la statua di Giasone e il Vello d’oro
commissionata a Pietro Francavilla nel 1589 circa, da Giuseppe Zanchini, priore dei Cavalieri di Santo Stefano, braccio operativo della marineria granducale a Livorno, molto attivo sotto il regno di Ferdinando I contro le infiltrazioni nel Mediterraneo di Ottomani e pirati.
Giasone, condottiero mitologico noto per essere stato a capo della spedizione degli Argonauti,è qui assunto come archetipo e prefigurazione delle fortune nautiche intraprese dai Cavalieri di Santo Stefano: l’eroe si presenta in atteggiamento vittorioso mostrando fieramente il vello d’oro (il manto di ariete prodigioso obiettivo delle peripezie di Giasone e qui omaggio al segno astrale di Cosimo I, il capricorno), mentre la mano sinistra, posata sul fianco, tiene le erbe soporifere procurategli dalla moglie Medea, servite per rubare il vello alla custodia del drago.
La vicinanza fra le opere di Giambologna e Francavilla porta a rintracciare l’influenza artistica esercitata dal maestro sull’allievo e dell’altro lato induce a una riflessione sull’evoluzione stilistica del più giovane scultore.
Rimangono dell’insegnamento giambolognesco le linee morbide e flessuose del corpo, così come la ponderatezza dei movimenti e la lavorazione minuziosa della superficie marmorea: nella posa c’è un recupero delle forme quattrocentesche di Donatello, evidenti nella posa del braccio appoggiato al fianco come nei due David, e la fisicità atletica e asciutta del Perseo di Cellini.
Nel Giasone lo scultore appare inoltre particolarmente virtuoso nella realizzazione della testa, con una attenzione particolare al dettaglio nei capelli e in certe sottigliezze come i sottilissimi baffi e il manto arricciato del vello.
Sebbene la ripresa di alcuni topoi figurativi passati, l’opera di Francavilla abbandona gli ideali eroici del rinascimento e diventa esempio di riflessione e consapevolezza in un’ottica più tipicamente moderna.
Nel 1587, al vertice del successo e quando ormai la sua maniera stava facendo scuola fra i più giovani artisti, Giambologna acquistò dall’Ospedale degli Innocenti un palazzo in Borgo Pinti (all’attuale n. 26), dove realizzò la sua personale bottega.
Il palazzo venne suddiviso in diversi spazi fra cui la “bottega”, coincidente con gli ambienti di lavoro veri e propri (come lo stanzone destinato alle grandi sculture e la fornace), e lo studio del maestro, adibito invece a luogo di riflessione, dove disegnare, creare bozzetti, e accogliere gli ospiti.
Prerogativa dell’atelier del Giamblogna fu la fornace personale, progettata appositamente per la fusione di grandi opere d’arte e finanziata dagli stessi Medici, che beneficiarono in questi anni di molte creazioni dell’artista. Sebbene la potenziale pericolosità di tali strutture fra le abitazioni (famoso è l’incendio del tetto della casa di Cellini durante la fusione del Perseo), l’esigenza di avere una fornace consentiva al maestro un controllo personale e diretto di tutte le fasi del lavoro.
Perché la bottega funzionasse al meglio e speditamente, Giambologna si affiancò di validi aiuti locali e stranieri, fra i quali scelse in base alla specializzazione del materiale lavorato, il già citato Pietro Francavilla, come primo assistente ai marmi, e Antonio Susini (1558-1624), primo assistente ai bronzi.
Alla morte del Giambologna, un altro valente allievo, Pietro Tacca (1577-1640) ne ereditò la bottega continuando a vivere e lavorare in Borgo Pinti, sotto l’autorità medicea: la grande richiesta di committenti internazionali sollecitò le nuove generazioni a riprodurre assiduamente le opere più note del maestro che nel frattempo avevano assunto il ruolo di modelli universali.
Bibliografia
- Pizzorusso, Il Ratto del secolo. Da Bandinelli a Giambologna, in La storia delle arti in toscana: il Cinquecento, a cura di Mina Gregori e Roberto Paolo Ciardi, Firenze 2000, pp. 211-230.
- Ferretti, La casa studio di Giambologna in Borgo Pinti, in Giambologna: gli dei, gli eroi, a cura di B. Paolozzi Strozzi e DimitriosZicos, Firenze2006, pp. 315-318.
- Francini-F Vassilla, Il Giambologna, pubblicato dal Comune di Firenze, 2015.
SACRO E PROFANO A MONTEFOSCOLI
Un borgo ai margini: Montefoscoli
Gigi Salvagnini nel ripercorrerne le cronache dal Mille al Duemila introduce Montefoscoli come un “lungo agglomerato di case fuori d’ogni logico itinerario”, un territorio immerso nel cuore toscano, poco lontano da Palaia (di cui è infatti una frazione del comune), sebbene già nella giurisdizione diocesana di Volterra, da cui dista circa una trentina di chilometri.
Effettivamente fuori dai percorsi turistici più frequentati e dalle vie di comunicazione che portano verso i grandi centri storici della regione, questo delizioso borgo rischia di rimanere ai margini degli interessi culturali anche dei più curiosi, pur nascondendo invece tra i suoi boschi uno dei monumenti maggiormente insoliti della zona.
Procedendo con ordine, la fondazione del paese si fa risalire convenzionalmente al 1102 quando, secondo le fonti storiche, alcuni feudi vicino Peccioli, fra cui il castello di Montefoscolo, passarono nelle proprietà di un certo Foscolo Scarpetta di Pisa. La chiesa duecentesca di Santa Maria Assunta (fig.1), che si trova nella parte più alta del paese, costituisce una fra le poche superstiti testimonianze del passato medievale di Montefoscoli, in quanto centro di aggregazione sociale e cristiano della comunità contadina-agreste che ha animato e sostenuto la vita del borgo fin dagli albori.

La chiesa di Santa Maria Assunta
L’aspetto odierno della facciata è stato in gran parte rimaneggiato nel 1947, quando avvenne un radicale restauro “in stile” a cura del genio civile, che mise in opera elementi ornamentali “romanici”, come le decorazioni della ghiera attorno l’oculo e i finti bacini policromi a ornamento della lunetta: il campanile, coronato con un terrazzino balaustrato che andò a sostituire una precedente guglia distrutta durante il terremoto del 1846, è unito al corpo della chiesa e unificato in facciata da un paramento murario continuo in mattoni. Anche l’interno ad aula unica presenta un assetto sette-ottocentesco, concluso nella zona presbiteriale da un ampio catino absidale che venne affrescato nei primi decenni del Settecento da Anton Domenico Bamberini (1666-1741) con una scena ritraente l’Assunzione di Maria, in linea con l’intitolazione della chiesa. L’opera, di cui oggi rimangono solo le carte d’archivio che attestano il pagamento al Bamberini, col passare dei secoli andò perduta, e lo stesso spazio venne nuovamente decorato nel 1991 dal pittore Stefano Ghezzani (allievo del maestro Pietro Annigoni) che vi rappresentò le Nozze di Caanan, nel momento in cui Gesù dispone di portare al banchetto le giare contenenti l’acqua tramutata in vino (fig.2). L’episodio, dai caldi colori e dalla immediatezza comunicativa dei personaggi, si apre sullo sfondo a un paesaggio collinare che sembra dialogare con gli scenari naturali intorno a Montefoscoli.

Ai lati dell’arco trionfale trovano posto due statue lignee raffiguranti Maria annunciata e l’Angelo, attribuite dai primi studi alla mano di Nino Pisano (1315-1370) e oggi assegnate all'anonimo Maestro di Montefoscoli (fig.3). Secondo la critica l’autore del gruppo scultoreo sarebbe da collocare nel contesto pisano, fortemente influenzato dai modelli del sopracitato Nino ma anche dalla maniera più addolcita sviluppata dal giovane senese Francesco Valdambrino (1363-1435), che fra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento è documentato proprio nei territori di Lucca e Pisa. L’Annunciazione di Montefoscoli si presenta infatti conforme ai topoi nineschi, nell'organicità della struttura, pur esibendo nelle capigliature e nei panneggi un aggiornamento verso i modi naturali e cortesi di Valdambrino.

Nella stessa chiesa è conservato inoltre un Crocifisso ligneo policromo, simbolo dell’ardente religiosità dei montefoscolesi che secondo la leggenda contesero il simulacro con gli abitanti di Legoli: la croce trovata in aperta campagna nella zona di confine fra le due parrocchie sarebbe stata di nuovo innalzata nel punto del ritrovo per poi cadere spontaneamente dalla parte di Montefoscoli.
L'obelisco ai caduti
Usciti dalla chiesa nella piazza antistante si trova l’obelisco dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, in seguito arricchito dai bassorilievi bronzei dello scultore genovese Silvio Oreste Minaglia (1886-1971), a cui i Donati di Montefoscoli avevano già commissionato la monumentale Pietà bronzea posta trent'anni prima sul sepolcreto della famiglia del locale cimitero. Minaglia fu attivo in area genovese e in diverse regioni d’Italia per cui realizzò una serie di numerose lapidi e monumenti nella riconoscenza che la patria offriva ai suoi caduti. Proprio per Montefoscoli nel 1964, grazie al contributo della famiglia Donati e della popolazione, lo scultore forgiò il rilievo bronzeo raffigurante l’Angelo della morte che sostiene il fante caduto, una raffigurazione in linea con la koinè nazionale di quegli anni che univa realismo e allegoria (fig.4); il soldato semplice è infatti rappresentato con i pantaloni dell’uniforme ma a torso nudo, riferendosi al modello del guerriero classico, sebbene qui la magrezza scavata del costato voglia alludere concretamente alle tragiche e dolorose conseguenze della guerra piuttosto che al vano eroismo a cui la propaganda aveva istigato. Alle spalle un angelo dalle grandi ali a sciabola sorregge e accompagna il fante verso la serenità della morte, a cui la stessa figura sottintende, combinando nella medesima scena “contingenza storica e dimensione immaginaria ultraterrena”.

Le edicole votive
Lasciando questa parte del paese e girando per le strade di Montefoscoli e nelle località vicine, potrà capitare di osservare sulle mura delle case e negli angoli delle vie un gran numero di tabernacoli, nicchie, marginette, contenenti figure e immagini sacre prevalentemente mariane, a riprova della spiccata religiosità cristiana che animava gli abitanti della zona, che vedevano in queste piccole raffigurazioni dei simboli protettivi. Il testo di Pietro Calloni dal titolo La pietà popolare nel territorio di Montefoscoli raccoglie con fotografie e commenti tutte le edicole votive del luogo, ponendo a confronto le diverse tipologie, alcune classiche ancora oggi in uso ed altre più insolite o architettonicamente complesse. Questa ampia varietà di croci, nicchie, tempietti e talvolta cappelle, emblema della devozione e delle tradizioni popolari-locali, si riscontra principalmente nelle comunità rurali, dove il culto si legava intrinsecamente alla natura e alla terra, nei luoghi di lavoro della campagna. Gli spazi dove tali segni di fede venivano posti erano solitamente crocevia stradali, impiegati per definire le zone di confine e i limiti, a protezione della casa o del podere: talvolta le marginette più spaziose servivano per offrire riparo al viandante e ricovero temporaneo degli attrezzi contadini. La costruzione di edicole sacre poteva nascere anche in seguito a un ex voto, in omaggio alla grazia ricevuta o per uno scampato pericolo, diventando così strumento di aggregazione della comunità cristiana che presso di esse si riuniva in preghiera. Fra gli esempi più curiosi ricordiamo il caratteristico segnacolo chiamato “La figuretta”, posto al centro di una ramificazione stradale (trivio), lungo il tragitto che conduce da Palaia a Montefoscoli: già documentato nel 1656, la copertura triangolare (sulla cui sommità è rappresentato il monte Golgota con le tre croci) che costituisce una sorta di tempietto intorno al tabernacolo centrale, nacque probabilmente come zona di riparo, sebbene una leggenda popolare riferisca invece che un tempo questo luogo fosse abitato da un eremita preposto a guidare i viandanti smarriti. Nelle strade del borgo di Montefoscoli, fra il Vicolo Meoli e Via A. Vaccà, incorniciata da un’edicola rosata, è collocata una deliziosa immagine della Madonna col Bambino e un devoto in adorazione, a cui fa da sfondo un cielo azzurro stellato, mentre in aperta campagna nella località di Vignale, esattamente in Via della Rimessa, si trova un raffinato tabernacolo di gusto neogotico, dalle forme sottili e slanciate, costruito nel 1935 in occasione delle Missioni Giubilari (fig.5-6-7).
Fra il 1821 e il 1823 l’animo della collettività di Montefoscoli venne per così dire “scosso”, dalle bizzarre idee illuminate del medico pisano Andra Vaccà (1772-1826), che nella località di Torricchio, alle porte del castello, volle edificare una costruzione nelle forme di un tempio pagano in memoria del padre. La storia dei Vaccà, ben nota e ripercorsa da diverse pubblicazioni che ne restituiscono un quadro completo e a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si intreccia alle vicende di Montefoscoli quando nel 1730 avvenne il matrimonio fra il dottore Giovanni Andrea Vaccà e Costanza Berlinghieri, la cui famiglia era proprietaria di diversi possedimenti nel territorio montefoscolese. La dinastia Vaccà Berlinghieri portò avanti con successo la professione medica, tanto che Francesco (figlio di Andrea e Costanza) e il suo secondogenito Andrea divennero famosi dottori a livello internazionale, entrambi docenti dell’Ateneo pisano.
La casa-museo Vaccà-Berlinghieri
Nella casa-museo Vaccà Berlinghieri a Montefoscoli, in alcuni eleganti ambienti del palazzo appartenuto alla famiglia ed oggi agli eredi, si conservano diversi oggetti che furono di proprietà di Francesco e Andrea, fra cui una biblioteca molto amplia di volumi sulla medicina e una serie di strumenti operatori: soprattutto Andrea appassionato di studi anatomici, divenne noto proprio per la sperimentazione di nuove tecniche operatorie e di moderni strumenti chirurgici. Nella prima sala del palazzo sono esposti i busti ritratto della famiglia Vaccà Berlighieri, opere di importanti artisti come il classicissimo fiammingo Michele Van Lint che scolpì il ritratto di Francesco, e Paolo Folini (1805-1890), autore del ritratto di Andrea: se il primo fu fortemente influenzato dal rigore neoclassico che determinò la scelta di rappresentare Francesco come un dotto “all'antica”, Paolo Folini, a contatto con le idee puriste di Lorenzo Bartolini, improntò il ritratto di Andrea secondo un’idealizzazione della forma più naturale, convogliando maggiore interesse sull'espressione decisa e fiera (fig.8).

Fu proprio Andrea che nel 1820 incaricò il giovane architetto Ridolfo Castinelli (1791-1859) di progettare un tempio dedicato a Minerva Medica, dea protettrice della medicina e della sapienza, per onorare la memoria del compianto padre. La struttura realizzata in stile neoclassico, che Castinelli aveva avuto modo di approfondire durante i suoi studi in Francia, è costernata da un universo di simboli, che oltre alludere al mondo classico si riferirebbero anche al linguaggio segreto massonico, con cui Andrea probabilmente entrò in contatto durante i suoi viaggi di formazione a Parigi e Londra.
Il tempio dedicato a Minerva medica
Immerso in un boschetto all'inglese evocativo di una natura libera e selvaggia, il tempio si presenta esternamente rivestito in cotto, con un pronao octastilo di ordine ionico, mentre la parte posteriore è conclusa da una copertura semicircolare (fig.9): sopra il portone d’ingresso una lapide dedicatoria in marmo affiancata da due civette su rami d’ulivo ricorda la memoria di Francesco Vaccà. Le decorazioni esterne del tempio furono realizzate in terracotta, presso la vicina fornace di Montefoscoli, mentre i pezzi più pregevoli vennero prodotti a Firenze dai fratelli Zini, scultori statuari e ornatisti. All'interno del tempio due colonne con capitello corinzio introducono nella camera semicircolare chiusa da una semi-cupola e affrescata con un cielo stellato: il pavimento è realizzato alla veneziana, con frammenti di marmo e pietre policrome, mentre sulle pareti spiccano decorazioni floreali e pannelli color verde lorenese (fig.10). Il decoratore che si è occupato degli ornati pittorici (forse un artista locale), ha restituito un’immagine graziosa e delicata di quella cultura figurativa settecentesca che interessava le grandi dimore patrizie a Pisa, dove anche i Vaccà possedevano in Palazzo Lanfranchi la loro residenza cittadina. A tal proposito sono noti i rapporti di discepolato fra Antonio Niccolini (1772-1850) e il Castinelli, architetto del tempio, che aveva trascorso al seguito del maestro un periodo di apprendistato durante gli anni del suo grand tour a Roma e a Napoli. Il Niccolini fu "frescante" e scenografo, molto attivo come decoratore a Pisa, dove fu il più alto esponente della pittura ornamentale a lambris, una moda che dalla fine del Settecento si estese fino agli inizi del nuovo secolo, contraddistinta dalla riproduzione in pittura di eleganti velari e tendaggi. Anche nell'orchestra, al piano superiore del tempio, si trova un drappeggio bianco vicino allo stile di Niccolini, rappresentato illusionisticamente in modo da coprire una finta galleria a cassettoni: sebbene l’affinità con i velari decorativi delle dimore pisane, a Montefoscoli lo scopo di questa soluzione sarebbe da ricercare piuttosto nella simbologia massonica, per cui il Maestro durante gli incontri si sarebbe celato alla vista degli adepti proclamando i suoi insegnamenti dall'alto dell’orchestra.
Quello che a una prima impressione potrebbe sembrare un capriccio architettonico, frutto delle disquisizioni intellettuali dei salotti mondani che i Vaccà ospitavano frequentemente a Pisa, è stato più volte messo in discussione dagli studi recenti a favore di altre ipotesi più complesse. Come abbiamo visto, oltre la probabilità che nel tempio si tenessero effettivamente incontri massonici, la passione che animava Andrea Vaccà per l’anatomia ha portato a leggere nella conformazione della cella semicircolare la stessa tipologia architettonica propria dei teatri anatomici, un’occasione di studio più volte bramata dal medico per poter condurre autopsie sui cadaveri, secondo un modus operandi che invece in ambiente universitario veniva spesso ostacolato.
Fra la serie veramente ampia di immagini e segni metaforici allusivi alla massoneria, vogliamo qui soffermarci su due simboli di origine classica che ricorrono nel repertorio iconografico del tempio e che riguardano il tema della morte e della ciclicità della vita: la farfalla e l’uroboro, entrambi metafore frequenti nel linguaggio neoclassico. Come la farfalla nel mondo antico è sinonimo dell’anima che si libra leggera una volta abbandonato il corpo, assumendo il significato di morte e rinascita dopo lo stadio della crisalide, ugualmente l’uroboro, che rappresenta un serpente nell'atto di mordersi la coda, esprime il ripetersi ciclico della vita in un continuo vortice di rinascita. Nel tempio di Montefoscoli entrambi questi simboli sono più volte evocati, come nei battiporta del portone principale a forma di uroboro, o negli anelli per i tendaggi sui quali sono posate delle farfalle (fig.11-12).
Spostandoci al Camposanto monumentale di Pisa, fra le numerose sepolture di uomini illustri, si trova custodito anche il sepolcro di Andrea Vaccà, scolpito da Berthel Thorvaldsen (1770-1844) nel 1830 e raffigurante Tobia miracolosamente guarito dal figlio Tobiolo (fig.13).

L’episodio, tratto dall'Antico Testamento, descrive la scena conclusiva del racconto, quando Tobiolo dopo un lungo peregrinare torna a casa e guarisce la cecità del padre grazie alle proprietà terapeutiche contenute nel fiele del pesce catturato con l’aiuto dell’arcangelo Raffaele, presenza protettrice e salvifica. Questo omaggio alla medicina, espresso grazie alle cure di un figlio premuroso nei confronti del padre, rimanda metaforicamente alle straordinarie capacità mediche quasi miracolose di Andrea, apprese grazie alla guida attenta di Francesco, oltre che alludere in chiave cristiana alla volontà divina, qui rivelata tramite l’intervento dell’angelo. La lastra in rilievo scolpita da Thorvaldsen, che vede al centro della scena Tobiolo intensamente concentrato nell'atto esatto della cura medica, è concepita secondo gli stilemi neoclassici di perfezione e armonia che l’artista aveva avuto modo di apprendere e raffinare grazie alla conoscenza di Antonio Canova (1757-1822). Nella parte alta del sepolcro il simbolo dell’uroboro, già incontrato nel tempio a Montefoscoli, fa da cornice al clipeo che racchiude il profilo di Andrea, di buon auspicio per la vita eterna e molto frequente nella cultura figurativa neoclassica; un altro uroboro si trova scolpito infatti da Lorenzo Bartolini (1777-1850) nello stesso Camposanto pisano per il monumento al funzionario napoleonico Giovan Francesco Mastiani (1758-1839), in un rilievo finissimo su un lato dello scanno dove siede l’Inconsolabile (fig.14), allegoria della vedova Elena Amati.

Una fortuna iconografica ancor maggiore aveva riscontrato l’immagine della farfalla, spesso rappresentata sotto forma umana nel bellissimo corpo di Psiche, portata al massimo del successo artistico dal mito reinterpretato da Antonio Canova nel gruppo del Louvre, Amore e Psiche (1787-1793). Il doppio significato in greco della parola “psiche”, che indicava sia la farfalla che il concetto di anima, portò a assimilare quest’ultima con le forme delicate dell’insetto, secondo un leitmotiv che si ritrova fin dall'antichità e che nello stile neoclassico si esplicò principalmente nella figurazione del racconto mitico. Lo stesso Canova regalò diverse letture della favola, come nel gruppo di Amore e Psiche stanti conservato all’Ermitage (fig.15), in cui i giovani amanti colti in un tenero avvicinamento osservano la farfalla che Psiche posa sulla mano di Amore come simbolo dell’anima che la fanciulla dona al suo amato, ma anche rappresentazione fragile dell’esistenza.
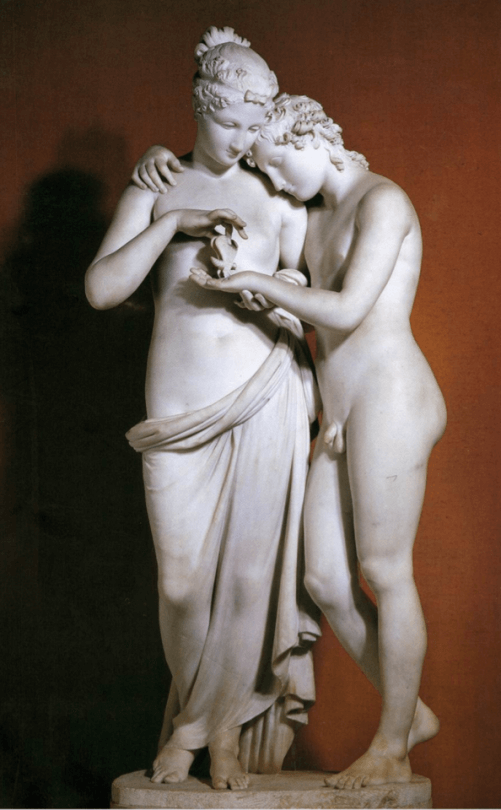
Anche Thorvaldsen fu molto legato all'immagine di Psiche che raffigurò in molteplici sfaccettature, affascinato dalla serie di combinazioni formali e introspettive che il mito permetteva di analizzare, come nella scultura dal titolo Psiche e l’urna (fig.16), eseguita in più copie: nel corpo della fanciulla dalle minute ali di farfalla si manifesta tutta la curiosità dell’anima umana, volubile e desiderosa di scoprire il contenuto dell’urna che le è intenzionalmente celato, qui resa dallo scultore attraverso la pacata espressione ignara di Psiche, nell'attimo in cui sta per compiere il gesto.

Bibliografia
Burresi, Una folla pensosa e cortese: Sculture note e inedite di Francesco di Valdambrino, Maestro di Montefoscoli e di altri, in Sacre passioni: scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo, Catalogo della mostra a cura di Mariagiulia Burresi, Pisa, Museo Nazionale e Civico di San Matteo (08-11-2000-11/ 08-04-2001), Milano 2000, pp. 196-227.
Salvagnini, Montefoscoli dal Mille al Duemila, Bagno a Ripoli 2000.
Lazzereschi, Il tempio di Minerva Medica: Montefoscoli, Pisa 2005.
Panattoni, Il Tempio e Minerva Medica: un tempio alla scienza, in “Antologia Vieusseux”, NS 14.2008, 40, pp. 5-32.
Del Vivo, Andrea Vaccà e Ridolfi Castinelli: La costruzione del tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, Pisa 2009.
Burresi, “Venti giorni…bastevoli mi furono per divenire uno scenografo”. La vita a Pisa di Antonio Niccolini, in Il Settecento. Affreschi nel territorio sanminiatese e pisano, serie La musica degli occhi, Ospedaletto 2011, Vol. I, pp. 63-73.
Blanco, L’anima-farfalla: studio sul tempio di Minerva Medica a Montefoscoli e analisi della simbologia, Pisa 2012.
Calloni, La pietà popolare nel territorio di Montefoscoli, San Gimignano 2016.Olcese Spingardi, Memorie nel marmo e nel bronzo: i monumenti ai caduti della Grande guerra in Liguria, in Memorie di pietra: testimonianze della Grande Guerra in Liguria, 2018, pp. 77-124.
Sitografia
SANTA CROCE SULL'ARNO E LE SUE CHIESE
L'ORIGINE DI UN NOME
Santa Croce sull’Arno è una cittadina del pisano che si trova nella zona del Valdarno inferiore, in età contemporanea particolarmente nota per far parte del distretto industriale conciario denominato “comprensorio del cuoio”, un centro economico-lavorativo di grande rilievo per la Toscana. Sebbene il fiorente sviluppo possa far pensare a Santa Croce come un paese nato in seguito all'industrializzazione, si rimarrà sorpresi nello scoprire che invece le sue origini sono antichissime e anche il suo toponimo, non a caso,nasconde delle ragioni storiche e religiose.
Il territorio dove nacquero i primi insediamenti sulle rive dell’Arno (già testimoniati a partire dal VIII secolo), apparteneva al tempo alla diocesi di Lucca, in cui era diffusa la venerazione del Volto Santo, il celeberrimo crocifisso ligneo raffigurante il corpo di Cristo vivo sulla croce, vestito con una lunga tunica. Sono molteplici le leggende riguardanti questa immagine divina, secondo alcuni scolpita da Nicodemo dopo la resurrezione per ricordare ai fedeli la fisionomia umana del figlio di Dio.
La leggenda racconta il ritrovamento della croce in Palestina da parte del vescovo Gualfredo, che spedì il simulacro su un’imbarcazione via mare con la speranza che potesse raggiungere una terra cristiana, scongiurando così la sua distruzione.Nel 782 la nave si avvicinò a Luni, approdando spontaneamente solo quando il vescovo Giovanni I giunse nella zona dopo essere stato avvisato in sogno da un angelo. Da qui la croce venne trasferita a Lucca (ancora oggi conservata nella Cattedrale di San Martino) e la devozione all'immagine sacra fu inarrestabile, crescendo a dismisura in Europa come meta di pellegrinaggio di potenti e semplici fedeli, e arrecando alla città legittimazione divina, prestigio, ricchezza.
È proprio grazie al modello votivo lucchese che nasce Santa Croce nel Valdarno, quando nella seconda metà del XIII secolo è attestato per la prima volta il toponimo di questo luogo, fiorito intorno ad un medesimo Volto Santo custodito nell'antico oratorio di Santa Croce sul Poggetto, e dove confluirono le piccole realtà territoriali che popolavano queste rive dell’Arno. Il culto della croce,esteso nell'intera circoscrizione vescovile, fu uno dei più venerati in età medievale e moderna, ed è quindi legittimo presupporre che fu proprio la progressiva importanza acquisita da tale fede popolare che portò anche nelle zone limitrofe l’emulazione di una croce analoga, servendo inoltre come legittimazione dell’autorità lucchese sul territorio.
L’oggetto di culto legato alle vicende di fondazione del paese oggi si trova nella collegiata di San Lorenzo, costruita nel XVI secolo sulla preesistente chiesa intitolata proprio alla santa croce.
L’imponente statua policroma, che secondo la critica è da datare al XIII secolo per mano di un anonimo artista lucchese, è costituita da più parti assemblate con gesso e colla, dipinte con pittura a tempera, e ritrae l’immagine viva di Cristo,caratterizzato da una fisionomia del volto severa e solenne,con la testa leggermente sporgente per la propensione del collo in avanti: i connotati somatici s’ispirano al Volto Santo di Lucca ma non sono completamente identici, in quanto appaiono più sintetici, così come anche la resa plastica della tunica orientale è ridotta ai minimi termini, appena accennata in fondo alla veste e nelle maniche, mentre è del tutto assente nella parte alta del torace. Il fascino arcaico che sprigionano le croci ispirate al modello lucchese, in Toscana presenti in vari esemplari, deriva dalla tradizione del Christus Triumphans, che unisce nella rappresentazione la morte di Gesù e il momento della resurrezione, oltre alla particolarità della tunica sacerdotale che li copre.
Nella collegiata è esposta un’altra notevole opera statuaria, raffigurante un Angelo annunziante in terracotta parzialmente invetriata, datato ai primi decenni del XVI secolo. Secondo le ricostruzioni storiche recenti, l’opera non faceva parte dell’arredo originario della chiesa ma vi giunse in seguito da un luogo di culto imprecisato, dove forse era collocata a lato di un altare, accompagnata da un suo ignoto pendant raffigurante la Vergine annunciata. Per l’inclinazione sentimentale con cui è modellato questo giovane angelo, la critica ha assegnato la statua a Andrea della Robbia (1435-1525), nome sostenuto anche dall'utilizzo dalla lavorazione della terracotta solo in parte invetriata: la tecnica di cui l’artista si servì spesso nella sua produzione tarda, fu ideata per rifinire alcune zone con colore a secco, conferendo all'opera un’impronta più naturale, come avviene per la statua santacrocese, policroma nell'incarnato del viso e delle mani, oltre che nella stola in origine di colore rosso (colorazione non era realizzabile con tale metodo). Oggi la pittura stesa a secco si è quasi del tutto persa, mentre permangono intatti i colori della tunica fissati dall’invetriatura, a riprova della straordinaria resistenza della tecnica robbiana.
Guardando nella zona presbiteriale, la parete di fondo dietro l’altare maggiore è occupata da un’edicola pensile di gusto settecentesco (1709-1716) in marmi misti, attribuita a Bartolomeo di Moisé, la cui attività è ancora tutta da ripercorrere.
Il dossale si compone dell’unione di diversi elementi architettonici e decorativi, quali volute, ghirlande di frutta, cornucopie e angeli, che ne fanno un monumento complesso ma nell'insieme armonioso: al centro una nicchia contiene la statua del santo titolare della chiesa, San Lorenzo, affiancata ai lati da alcune raffinate lesene disposte gradualmente e che determinano il focus dell’altare.
Spostandoci nella navata destra della collegiata, incorniciato da una monumentale edicola, si trova un quadro raffigurante la Pietà, dipinto dal pittore fiorentino Anton Domenico Bamberini (1666-1741), molto attivo nella diocesi di San Miniato. Oltre la fama di buon frescante, Bamberini da qui prova di sé in un’opera su tela dove colloca al centro della scena il fulgido corpo di Cristo sostenuto da Maria, sotto un cono di luce etera e celestiale che rischiara entrambi, lasciando il resto dei partecipanti in penombra. Il dipinto proveniente dal monastero di Santa Cristiana e realizzato probabilmente tra il secondo e terzo decennio del XVIII secolo, ci offre il pretesto per raccontare un’altra storia religiosa e attuale al tempo stesso,appartenuta a Santa Croce sull'Arno e che si lega al nome di Oringa Menabuoi.
Oringa nacque a Santa Croce(1237/1240-1310) da un’umile famiglia, coltivando fin da piccola la fede e i valori cristiani: poiché fu obbligata dai fratelli a sposarsi contro la sua volontà, decise di allontanarsi da casa rifugiandosi a Lucca, dove ebbe inizio il suo percorso spirituale che la condusse in molti viaggi fra cui a Roma e Assisi. Nel 1277 tornata nuovamente a Santa Croce, insieme ad altre giovani donne fondò nel suo paese natale il monastero intitolato ai Santi Maria Novella e Michele,affermando così la sua volontà consacrata alla fede e alla generosità, e vestendo gli abiti dell’ordine agostiniano. Tanto fu il suo impegno sociale e il suo intenso credo, per cui si ricordano anche fatti miracolosi e divini, che gli abitanti del posto la denominarono “Cristiana”, oggi patrona di Santa Croce, festeggiata dalla comunità ogni 4 gennaio,nella ricorrenza della sua morte.
La chiesa di Santa Cristiana nelle forme in cui la vediamo oggi, adiacente al monastero ancora attivo, venne ricostruita su un originario impianto duecentesco andato distrutto in un incendio nel 1515, dove andò perduto anche il corpo incorrotto della Santa. L’assetto odierno è frutto di un ennesimo restauro settecentesco, insieme all'affresco dipinto dal già citato Bamberini fra il 1716 e il 1717,che nella volta presbiteriale vi raffigurò Santa Cristiana in gloria accolta in cielo da un tripudio di angeli e putti in festa, che ritroviamo anche nei pennacchi come allegorie delle virtù di Cristiana.
L’interno ad aula unica, voltato con una copertura a botte con decori ottocenteschi, è arricchito dalle vetrate realizzate dalla ditta Polloni di Firenze nel 1945, che illustrano con vivaci colori gli episodi più significativi della vita della Santa.
Sull'altare maggiore è esposta una pala cinquecentesca raffigurante la Resurrezione di Cristo e Santi (fra cui Cristiana),attribuita alla scuola pittorica di Fra’ Bartolomeo, tra i cui seguaci la critica ha riconosciuto nell'opera la mano di Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561), ipotesi avvalorata anche da una tarda memoria scritta. Dietro la zona presbiteriale si trova la cappella consacrata alla Santa, dove in una sfarzosa urna dorata è rappresentato il simulacro del corpo di Cristiana insieme ad alcune reliquie.
Fra i luoghi di culto storici di Santa Croce sull'Arno ricordiamo anche la chiesa di San Rocco, che spicca subito nell'abitato cittadino per il curioso color arancio che ricopre esternamente l’edificio. Già nota nel Cinquecento come piccolo oratorio nei pressi del quale si trovava un ricovero per gli appestati, l’importanza di San Rocco aumentò considerevolmente dopo che vi fu trasferita un’immagine miracolosa della Madonna, tanto che fra il 1792 e il 1796 furono necessari dei lavori di ampliamento che portarono all'aspetto odierno della struttura: il portico che copre l’entrata principale della chiesa è invece una ricostruzione fedele e recente dell’originale settecentesco che crollò negli anni ‘30 del Novecento.
L’interno si presenta ad aula unica ampliato sui lati da due cappelle laterali che conservano rispettivamente una Crocifissione e l’Adorazione del simulacro della Vergine di Loreto da parte dei Santi Bartolomeo, Caterina, Apollonia e Rocco, entrambi dipinti collocabili alla metà del XVII secolo e attribuiti al pittore ancora poco noto Giovanni Gargiolli, appartenente al clima artistico del seicento fiorentino.
L’altare maggiore è coronato da un’edicola a forma di grande nuvola che allude al Sacro Cuore, e che custodisce al centro la santa immagine della Madonna col Bambino.
In conclusione si ricorda un’opera ottocentesca che si trova nella parete destra appena precedente alla zona presbiteriale della chiesa, realizzata dal santacrocese Cristiano Banti(1824-1904), pittore celebre per aver aderito al movimento artistico dei macchiaioli, in stretta amicizia con i grandi esponenti del gruppo, come Telemaco Signorini e Vincenzo Cabianca. Il dipinto devozionale che raffigura San Rocco pellegrino, realizzato per l’omonima chiesa, si colloca a metà fra i lavori giovanili eseguiti da Banti, dopo la frequentazione dell’Accademia artistica di Siena, quando ancora lo stile del pittore era fortemente influenzato dall'insegnamento neoclassico dei suoi maestri, e appena prima del suo trasferimento a Firenze nel 1854 che lo convertì definitivamente alla macchia. L’opera rappresenta San Rocco al centro di una nicchia lunata, vestito in abiti da pellegrino, mentre con lo sguardo rivolto in alto indica la piaga sulla coscia (simbolo della peste che lo afflisse), accompagnato dal cane, che secondo la leggenda sfamò San Rocco durante la malattia,portandogli quotidianamente un pezzo di pane rubato alla mensa del padrone.
Dietro l’immagine del Santo si apre un vasto paesaggio agreste e uno scorcio molto ampio di cielo azzurro limpidissimo, che occupa più di metà dello sfondo. Stilisticamente l’opera è in linea con i principi neoclassici di simmetria e ricerca armonica della composizione, dove i contorni nitidi delle forme si accompagnano ad una stesura del colore in campiture uniformi e omogenee.
Bibliografia
- Matteucci,Cristiano Banti, Firenze 1982.
- Marchetti, Settecento anni di vita del Monastero di Santa Maria Novella e San Michele Arcangelo in Santa Croce sull'Arno comunemente detto Monastero di Santa Cristiana, Ospedaletto 1994.
- Bitossi, Scheda n.108 (Andrea della Robbia-Angelo annunziante), Scheda n.116 (Bartolomeo di Moisé (?)-Dossale di San Lorenzo), Scheda n.117 (Antonio Domenico Bamberini-Pietà), Scheden.122-123 (Giovanni Gargiolli (?)-Crocifissione-Santi in adorazione del simulacro della Vergine di Loreto), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di R.P. Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol I, pp. 228-229,233-234, 241-242, 243-244, 250-253.
- Parri, Scheda n. 105 (Ignoto scultore toscano, Volto Santo), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di R.P. Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol I, pp.228-229.
M.G. Burresi, Il simulacro ligneo del Volto Santo nella Collegiata di Santa Croce sull’Arno, in La Santa croce-il culto del Volto Santo, a cura di G. Parrini, San Miniato 2006, pp. 7-12.
- Gagliardi, La Santa Croce. La continuità del culto nella differenziazione delle forme, in La Santa croce-il culto del Volto Santo, a cura di G. Parrini, San Miniato 2006, pp.14-39.
- Giannoni, Una storia da riscoprire-Il monastero di Santa Cristiana, San Miniato 2007.
- Gagliardi, OringaMenabuoi - santa Cristiana da Santa Croce nella tradizione agiografica (sec. XIV-XVIII), in Santa Cristiana e il castello di Santa Croce tra Medioevo e prima Età moderna, a cura di A. Malvolti, Ospedaletto 2009, pp. 31-46.
- Marcori, Con la croce e il giglio, luoghi di preghiera e devozione di una comunità, in Santa Cristiana e il castello di Santa Croce tra Medioevo e prima Età moderna, a cura di A. Malvolti, Ospedaletto 2009, pp. 101-116.
Sitografia
Il monastero di Santa Cristiana: www.agostiniani.it
*Le foto n.6-7-8 sono tratte dal libro Santa Cristiana e il castello di Santa Croce tra Medioevo e prima Età moderna (Ospedaletto 2009).[/vc_column_text][/vc_column]
SANTA MARIA NOVELLA A MARTI
Marti: il paese, la chiesa
La chiesa di Santa Maria Novella si trova a Marti, una frazione del comune di Montopoli, in provincia di Pisa. La storia di questo paese ricalca quella di molti centri abitati toscani, contesi dalle mire espansionistiche di Firenze, a cui anche Marti si arrese nel 1406: il perdurare della condotta filo-pisana da parte dei martigiani comportò lo smantellamento e la distruzione di questo castello, insieme al saccheggio della chiesa che era stata costruita nel 1332.
Dopo questo periodo bellicoso le fonti parlano di un primo restauro di Santa Maria Novella avvenuto nel 1470, per poi essere definitivamente rinnovata nel XVIII secolo, grazie a un programma decorativo che comportò la totale copertura pittorica dell’aula interna, e che rese la chiesa di Marti “uno dei luoghi più affascinanti e riccamente decorati della diocesi di San Miniato”. Esternamente Santa Maria Novella presenta un corpo di fabbrica in stile tardo romanico toscano, coperto da un paramento murario in mattoni: la facciata a capanna mostra una decorazione ad archetti pensili ed è ripartita da due lesene che spartiscono la zona superiore da quella inferiore, in cui si apre il portone centrale affiancato da due portali ciechi (fig.1).

Superata la soglia della chiesa ci troviamo immersi in uno spazio scenografico magnifico ed avvolgente (fig.2), catturati dalla sfarzosa decorazione ad affresco della tribuna: questo assetto settecentesco fu promosso dal pievano Giuseppe Panzani, che nel 1719 si rivolse a Antonio Domenico Bamberini (1666-1741) per l’esecuzione del ciclo pittorico nella zona presbiteriale. Allo stesso artista fu commissionata anche la Pala del Rosario (1722), pensata per un altare laterale, raffigurante due santi adoranti in abito religioso (San Domenico e Santa Maria Maddalena dei Pazzi?) e i quindici medaglioni, contenenti i misteri del culto mariano del Rosario (fig.3).
Il Bamberini fu un pittore-frescante molto attivo nel circondario della diocesi sanminiatese, specializzato nella decorazione quadraturista di gusto tardo barocco, un genere pittorico improntato sulla resa illusionistica e prospettica di fondali architettonici, che a Firenze fu ampliamente sviluppato dalla scuola di Jacopo Chiavistelli (1621-1698). Anche il Bamberini di formazione fiorentina fu indirizzato verso il quadraturismo, facendo suo un repertorio decorativo molto vasto di elementi architettonici che ne accentuassero la resa trompe-l'œil: a Marti il fronte della tribuna imita un tempio nella rappresentazione delle due grandi colonne corinzie che sorreggono il timpano, arricchito da capitelli, cornici e mensole in monocromo, mentre i tre fornici, che ne caratterizzano l’impianto, ricordano la forma di un arco trionfale romano. Due figure muliebri (probabilmente le donne alludono alle virtù teologali della Fede e della Speranza), siedono sull'archivolto centrale a presenziare un cartiglio in cui si legge parte di un’iscrizione che allude alla chiesa come casa di Dio: “Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae”, ovvero “Signore, amo la bellezza della tua casa, il luogo che hai scelto per abitazione della tua gloria”. La parte culminante del frontone termina con una cornice mistilinea in cui è rappresentato in monocromo il Miracolo di San Martino, a imitazione di un rilievo.
Nei tre ambienti voltati della tribuna continua la decorazione ad affresco: nella zona centrale dietro l’altare è rappresentata l’Assunzione della Vergine, mentre nei fornici laterali la pittura riproduce illusionisticamente degli ambienti classicheggianti voltati a lacunari, in cui sono rappresentati trionfanti San Giovanni Battista e Cristo Risorto, accompagnati nelle pareti laterali rispettivamente dagli episodi del Banchetto di Erode e la Cena di Emmaus. Nelle volte e nell'intradosso degli archi la decorazione pittorica riempie ogni spazio con l’imitazione di specchiature marmoree e stucchi, nelle forme di cornici, volute, cartigli e medaglioni (fig.4-5-6).

Nel 1805 il pittore Filippo Lenzi venne incaricato di affrescare i rimanenti spazi della chiesa con partiture architettoniche quali finestre e balaustre, determinando così un vero e proprio horror vacui.
Tra le tele seicentesche che si trovano sugli altari laterali di Santa Maria Novella ricordiamo la commissione della famiglia fiorentina dei Baldovinetti (tenutaria nel Valdarno di diversi possedimenti), raffigurante il Miracolo di San Pietro che risana l’infermo (fig.7), del pittore Matteo Rosselli (1578-1650): la lastra ovale sotto la mensa dell’altare riporta le iniziali dell’artista insieme all'anno di esecuzione (1622). Rispetto allo stile più comunemente adottato dal Rosselli, vicino ai modi del Cigoli, qui la critica ha ravvisato piuttosto l’influenza di Domenico Crespi, detto il Passignano (1559-1638), in linea per la sobrietà cromatica e l’impianto scenico (l’ipotesi è avvalorata dalla conoscenza dei due artisti, come attesta la notizia di un viaggio che Rosselli intraprese al seguito di Passignano). È invece assegnata a Taddeo Baldini (attivo 1642-1677) la Sacra conversazione di Santi adoranti (Santa Caterina d’Alessandria, Giuseppe, Lucia, un santo carmelitano e Sant’Antonio da Padova con le anime del purgatorio in adorazione dello Spirito Santo), vicino nelle forme all'appassionato sentimentalismo di Lorenzo Lippi (1606-1665).

Riveste un importante valore artistico oltre che devozionale il Crocifisso in cartapesta policroma attribuito a Ferdinando Tacca (1619-1686) e arrivato a Marti nel 1673 (fig.8).

I committenti della croce sono da rintracciarsi nei componenti della sopracitata famiglia Baldovinetti, di cui Vincenzo di Giovanni in particolare, cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano, fu protagonista di una leggenda marinaresca: il racconto tramandato nel borgo riguardava la cattura da parte di Vincenzo del pirata Ciriffo Moro, e il conseguente rinvenimento sulla sua imbarcazione del crocifisso, in seguito donato alla chiesa di Santa Maria Novella. La leggenda si era probabilmente affermata nell'ambito della stessa famiglia Baldovinetti, per incrementare il prestigio sociale della casata tramite il riconoscimento di gesta militari e atti di benevolenza, rimanendo per lungo tempo nella memoria collettiva della comunità.
L’attribuzione dell’opera a Ferdinando Tacca nasce dall'identificazione del modello originario realizzato dal padre, Pietro Tacca (1577-1640), per il crocifisso bronzeo donato al re di Spagna Filippo III nel 1616, oggi conservato nella Sacrestia della Santa Forma all'Escorial (fig.9), e da cui derivano numerose copie in materiali diversi (bronzo, cartapesta e stucco).

Dopo la morte di Pietro Tacca, fedele collaboratore del Giambologna, la bottega fiorentina fu portata avanti dal figlio Ferdinando, a cui probabilmente spetta anche l’esecuzione del Crocifisso di Marti: a livello formale l’opera presenta, rispetto all'esemplare dell’Escorial, alcune caratteristiche più esasperate che la critica ha rintracciato come segni distintivi dello stile di Ferdinando. La scelta di realizzare la figura morente di Cristo in cartapesta rivela la committenza per un contesto devozionale, affinché fosse facilmente trasportabile durante le processioni, insieme ad una compartecipazione emotiva maggiormente intensa da parte dei fedeli, resa grazie a una malleabilità del materiale più consona a esprimere il dolore fisico: la carne lacerata dai chiodi nelle mani ed in particolare nei piedi contrasta con la flessuosità con cui è plasmato il corpo esile e affusolato di Cristo, di una bellezza struggente. Il restauro avvenuto nel 2001 ha permesso il ripristino di alcuni raffinati quanto delicati particolari, come il fiocco del perizoma (realizzato ad applique-parti eseguite separatamente e aggiunte in seguito alla struttura) e il recupero della policromia originale: in particolare è stata rivalorizzata la presenza di alcune gocce di sangue lumeggiate sulle braccia e le gambe, oltre alla ferita sul costato, che versa rivoli di sangue e acqua. Questo dettaglio è una citazione puntuale di un passo del Vangelo in cui Giovanni rammenta che dopo la morte di Cristo “Uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua” (Giovanni 19,34). In una valenza simbolica tale avvenimento attesta tramite il sangue, il sacrificio e il sacramento dell’eucarestia, mentre l’acqua allude allo Spirito e alla rinascita nel battesimo. Anche la croce lignea, che si credeva non originale, ha restituito durante il restauro diverse tracce pittoriche raffiguranti sanguinamenti in concomitanza delle braccia e dei piedi.
Il dipinto che incornicia l’opera venne invece appositamente realizzato nel 1821 dal pittore originario della vicina Cascina, Giuseppe Bacchini (attivo 1806-1845), collocando il crocifisso al centro di quattro Dolenti, Maria, San Giovanni, Maria Maddalena e Maria di Cleofa, quest’ultima menzionata proprio nello stesso Vangelo di Giovanni durante la passione di Gesù (fig.10). La bidimensionalità della pittura d’impostazione neoclassica è qui evidenziata da una resa quasi sagomata delle figure, trattenute in un composto e imperturbabile dolore.
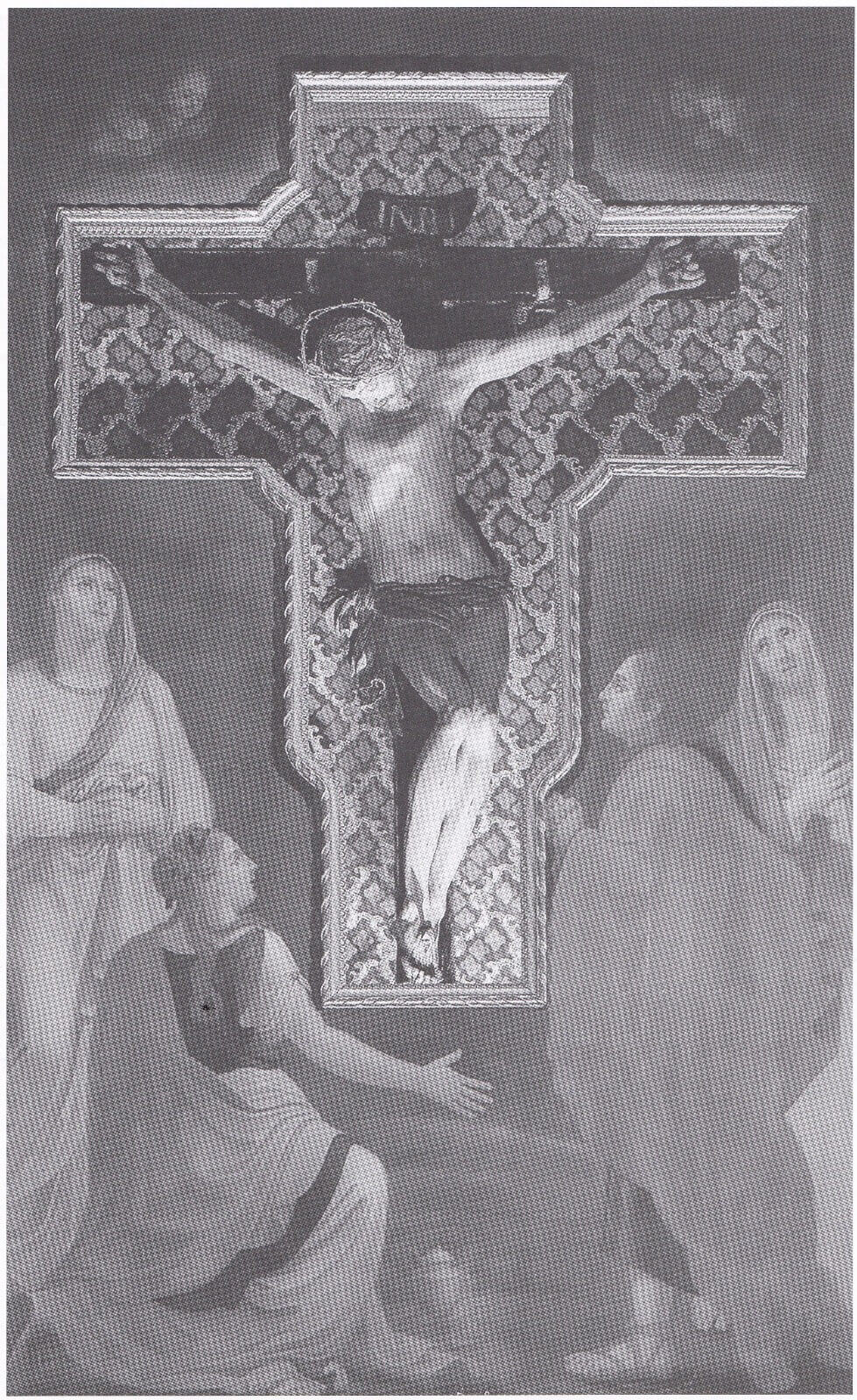
Bibliografia
- Bitossi, Scheda n.74 (Matteo Rosselli, San Pietro risana l’infermo), Scheda n.75 (Taddeo Baldini, Pala d’altare con Santi), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, pp. 170-173.
- Campigli, Scheda n.76 (Ferdinando Tacca, Crocifisso), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, p. 175.
- Parri, Scheda n.83 (Giuseppe Bacchini, I dolenti), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, p. 181.
- Boldrini, Il cavaliere, il pirata e il Crocifisso di Marti tra leggenda e devozione, in Restauri nella Pieve di Marti- Il Crocifisso di Ferdinando Tacca e tre ovali dipinti del Seicento fiorentino, a cura di B. Bitossi e M. Campigli, Firenze 2003, pp. 10-26.
- Campigli, Sul crocifisso di Marti, in Restauri nella Pieve di Marti- Il Crocifisso di Ferdinando Tacca e tre ovali dipinti del Seicento fiorentino, a cura di B. Bitossi e M. Campigli, Firenze 2003, pp. 27-43.
- Granchi, Il restauro del Crocifisso in cartapesta policroma di Marti attribuito a Ferdinando Tacca, in Restauri nella Pieve di Marti- Il Crocifisso di Ferdinando Tacca e tre ovali dipinti del Seicento fiorentino, a cura di B. Bitossi e M. Campigli, Firenze 2003, pp. 46-74.
*Le figure n.2-7-10 sono tratte dal volume Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2000, Vol. I, pp. 167,171,182.
PALAIA. ESSENZA ED ARTE TOSCANA
A cura di Luisa Generali
Per chi volesse assaporare la tranquillità di un tipico borgo toscano incontaminato, deve inevitabilmente concedersi una sosta a Palaia. Questo piccolo paese in piena campagna, isolato rispetto ai centri cittadini più vicini, si trova in Valdera, circondato da numerose e incantevoli frazioni che ne costituiscono il territorio. La storia antica di Palaia è evocata da importanti architetture religiose e civili di epoca medievale, come le mura e la porta di Santa Maria, che tutt'oggi introduce nel castello arrivando dal versante fiorentino. Addentrandosi nel nucleo più interno del paese, una serie di vicoli salgono fra gli orti e le abitazioni verso la sommità del colle su cui si ergeva la roccaforte: oggi qui è possibile salire fin sulla cima e godere della splendida visuale sopra i tetti dell’abitato, che in lontananza lasciano spazio al paesaggio. Terra di confine sia per questioni politiche che religiose, Palaia è stata un comune autonomo legato a Pisa fino al 1406 ed in seguito passato sotto la dominazione fiorentina, così come è avvenuto per la giurisdizione diocesana, prima legata al territorio lucchese (fino al 1622), ed in seguito confluita sotto il controllo di San Miniato: proprio a causa di queste motivazioni storiche è possibile spiegare il passaggio a Palaia di artisti provenienti da varie zone della Toscana. Fa parte integrante della storia del borgo anche il celebre modo di dire “Peggio Palaia”: legato ad eventi storici spiacevoli del passato, oggi questa espressione ha assunto per contro parte, una connotazione simpatica e spiritosa, per esprimere una situazione che va di male in peggio, o che proprio peggio di così non può andare.
La ricchezza artistica del borgo si unisce inevitabilmente a quella paesaggistica, creando un piacevole commistione di colori, fra il verde della natura e il rosso intenso del laterizio, molto impiegato nelle costruzioni storiche del territorio: il concreto legame fra ambiente e architettura si realizza nella pieve di San Martino, fuori le mura del paese (fig.1).

La struttura si trova nell'elenco ufficiale dei Monumenti Nazionali d’Italia già dal 1874, dopo la conclusione di importanti lavori di restauro che salvarono la pieve dal suo progressivo decadimento. Oggi la fabbrica si presenta esternamente rivestita lungo i fianchi di un paramento murario in laterizi, mentre la facciata è composta in prevalenza da pietra calcarea. L’unitarietà e la compostezza del mattone e delle pietre è dovuta ai restauri ottocenteschi che hanno uniformato il rivestimento dell’antico impianto. L’anno di fondazione è attestato nel 1279, quando il vescovo di Lucca, Paganello, concesse di spostare la pieve battesimale da San Gervasio a Palaia per rispondere alla richiesta dei paesani: si dette così avvio alla ricostruzione di una precedente chiesa già intitolata a San Martino di Tours, nelle forme monumentali del romanico toscano che ammiriamo oggi. I lavori continuati fino all'inizio del XIV secolo, hanno apportato delle modifiche in itinere che risentono anche di influenze goticizzanti: la tradizione vuole che la fabbrica sia stata ultimata da Andrea da Pontedera, più noto come Andrea Pisano (1290 c.-1348 c.), identificato con l’Andrea operaius che ha lasciato la sua firma incisa ben due volte insieme alla datazione, in alcuni elementi strutturali all'interno dell’edificio (precisamente sul bordo superiore del capitello della seconda colonna della navata sinistra con data 1283 e sulla chiave di volta della cappella terminale della stessa navata sinistra datata 1300). Tuttavia, l’intervento di Andrea Pisano oggi si tende a screditare, in quanto la cronologia delle due iscrizioni non coincide con l’operatività dell’artista, che ancora non era nato in questi anni. Piuttosto Andrea sarebbe da identificare con un altro costruttore, forse il capocantiere o l’architetto, che con orgoglio volle ricordare qui il suo intervento.
All'interno l’aula è divisa in tre navate terminanti nelle rispettive absidi, di cui quella centrale, più alta rispetto alle due laterali minori, è scandita da costoloni che ne accentuano lo slancio verticale (fig.2).

Si rimane colpiti dalla severità disadorna che evoca i tempi di un antico passato, frutto in parte, del restauro diretto dall'ingegnere Luigi Filippeschi fra il 1873 il 1874: soprattutto l’interno fu oggetto di un importante rimaneggiamento, spogliando la chiesa di tutte le decorazioni che si erano stratificate nei secoli, a favore di un ritorno integro alle origini romaniche. Filippeschi collocò nella parte absidale tre altari in stile arcaico, insieme a un fonte battesimale a pianta esagonale e il pulpito, in linea con la sobrietà della struttura. Queste imitazioni in stile si affiancano ad alcuni elementi originali, come il monolite battesimale (proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Ripezzano, andata distrutta) e una piccola vasca marmorea oggi usata come acquasantiera, creando quindi un effetto complessivo di uniformità pur non essendo completamente veritiero. A proposito della vasca in pietra di piccole dimensioni, un’iscrizione indica come il bacile in origine fosse usato per la misura del vino che gli abitanti dovevano pagare al pievano (qui è ricordato il primo pievano di San Martino, Ubaldo), responsabile non solo delle funzioni religiose, ma anche di pratiche civili e amministrative (fig.3).

È invece originale e conservato ottimamente lo scheletro della struttura nei suoi elementi portanti, come le colonne che dividono l’interno, con i rispettivi capitelli scultorei e le decorazioni perimetrali ad archetti pensili che scandiscono la sommità della chiesa. I laterizi vengono utilizzati per disegnare la sagoma dei portali laterali, creando degli archivolti in cui si alternano ornamenti ad incisioni geometriche di vario tipo per movimentarne la superficie: inoltre l’alternanza fra il mattone e la pietra viene utilizzata a scopo decorativo per enfatizzare alcuni elementi strutturali come i capitelli, gli architravi e i peducci pensili. Proprio sulle fiancate laterali una serie di peducci compositi, conclusi da un cono in laterizio, accolgono delle protomi scolpite nella pietra, dalle forme umane e zoomorfe (fig.4).

Gli elementi scultorei sono realizzati in modo sommario e veloce, senza un vero intento programmatico, ma piuttosto attingendo a un repertorio figurativo ormai consolidato, in cui diverse commistioni classiche e rurali si uniscono a formare un universo di immagini eterogeneo: a queste figure spesso ferine e dai connotati primitivi, sono attribuite diverse peculiarità, come custodi del luogo sacro, con intento apotropaico, ma anche simboli di riconoscimento della popolazione nella cultura agreste. La posizione di sospensione in cui spesso venivano disposti tali dettagli plastici (come nel nostro caso a San Martino), “a mezz'aria” fra la sfera del divino e il mondo terreno, era la sede migliore per collocare quelle creature fantastiche, animalesche e ibride, di cui ancora la tradizione si nutriva e che rientravano nell'ambito dell’occulto.
Prima di lasciare questo paragrafo dedicato a San Martino, vogliamo riportare l’attenzione sul pericolo che minaccia la pieve di Palaia e che recentemente è stata oggetto anche di un articolo da parte del quotidiano “Il Tirreno”, ovvero le condizioni critiche del crinale su cui è costruito il monumento; l’azione erosiva dell’acqua ha infatti da tempo reso instabile il terreno tufaceo del colle, provocando frane e indebolendo l’area circostante la pieve. Pur sottolineando che la struttura non è al momento a rischio, ci uniamo qui alla richiesta del parroco affinché le autorità preposte si mobilitino in tempo per tutelare e difendere questa autentica opera architettonica.
Proseguendo verso la strada che porta dentro le mura di Palaia, s’incontra la chiesa di Santa Maria da cui prende il nome la stessa porta. La fabbrica di dimensioni modeste, ricordata fin dal XIII secolo, presenta un tetto a capanna e un corredo decorativo esterno molto essenziale, movimentato ritmicamente da lesene. Fa parte della chiesa anche il campanile costruito sopra l’entrata della porta, in quanto riadattato sulle forme di una originaria torre di guardia (fig.5).

Lungo la direttrice principale, oltrepassando un edificio coperto, sormontato dalla torre civica dell’orologio, (in precedenza torre campanaria a uso civico), si trova la chiesa duecentesca di Sant'Andrea, capolavoro del romanico e contenitore di altrettanti capolavori di arte sacra (fig.6).

Nel paramento murario della chiesa ritroviamo lo stesso leitmotiv del rivestimento in laterizi che contraddistingue San Martino e Santa Maria, decorato lungo il perimetro del tetto da archetti pensili terminanti con motivi ornamentali riferibili a simboli ed emblemi araldici: questa componente laica che differenzia Sant'Andrea dalla pieve, denota l’importanza rivestita dalla chiesa situata nel cuore del castello, polo di riferimento per la vita comunale e mostra di prestigio per le nobili famiglie.
La chiesa presenta una rarità nella costruzione del campanile “pensile”, alzato sopra il corpo della fabbrica, per metà sostenuto dalla costruzione stessa e all'interno sorretto da una grande colonna, che costituisce uno spazio coperto percorribile: l’unica campata all'interno dell’edificio ad aula unica (fig.7).

L’eccezionalità di questo progetto è stata evidenziata dalla critica, che lega il campanile di Sant'Andrea all'esempio duecentesco della chiesa conventuale di San Francesco a Pisa, in cui si trova una torre campanaria pensile, affine a quella di Palaia per l’audacia del progetto (il campanile di San Francesco a Pisa, realizzato nel XIII secolo e considerato capolavoro dell’ingegneria medievale, è assegnato all’opera di Giovanni di Simone).
Entrando in Sant'Andrea, ai lati dell’altare maggiore, sono collocati due gruppi statuari, entrambi raffiguranti la Madonna col Bambino: nell'edicola di destra si trova la scultura in legno policromo, firmata e datata da Francesco Valdambrino (1363-1435) nel 1403 (fig.8): il restauro del 1982 riportò alla luce sul basamento della statua l’iscrizione col nome dell’artista e quello della committenza, la compagnia di Santa Maria dei Bianchi.

L’inconsueta veste candida che copre la Vergine e la raffinata tunica del medesimo colore che indossa il Bambino, sono da ricollegare agli abiti distintivi della congregazione dei Bianchi, che in Sant'Andrea possedeva un altare. L’accuratezza nei dettagli dell’opera, come la distesa di stelle dorate sul manto di Maria, e i drappeggi delle vesti che ricadono naturalmente, rivelano una grande qualità artistica pur essendo questa un’opera giovanile del Valdambrino: secondo la critica lo scultore di provenienza senese si fermò a Palaia e nei dintorni di Pisa, negli anni precedenti al suo soggiorno a Lucca, documentato nel 1406, confermando un’influenza stilistica vicina ai modi gotici di Nino Pisano (1315 c.-1370), sebbene mitigata da una morbidezza dei volumi che trova la sua origine a Siena.
Nell'edicola sinistra si trova un’altra statua di medesimo soggetto, in terracotta dipinta e conferita per via stilistica a Luca della Robbia, datata al 1435 circa (fig.9).
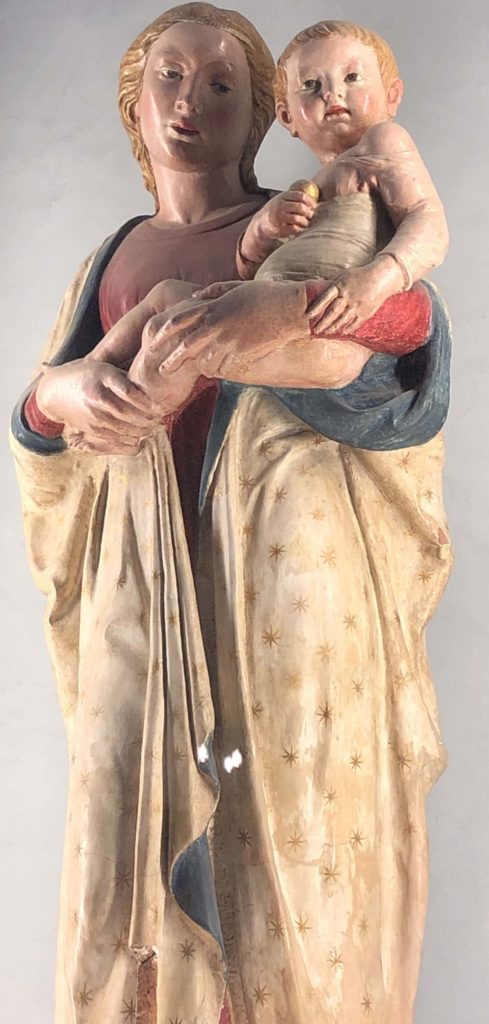
L’opera proveniente dall'altare della compagnia dei Bianchi nella chiesa di Santa Maria è stata spostata in un’epoca imprecisata nella chiesa di Sant’Andrea: la committenza da parte della medesima confraternita che affidò l’incarico al Valdambrino spiega i punti in comune che contraddistinguono le due sculture, a partire dall'iconografia e il medesimo manto bianco cosparso di stelle dorate che copre Maria. L’assegnazione della scultura a Luca della Robbia deriva dal confronto della Vergine con alcune figure femminili scolpite dallo stesso Luca negli anni ’30 del Quattrocento, per la cantoria del Duomo fiorentino, in cui si riscontra la stessa cifra stilistica dell’opera palaiese, improntata su un calibrato classicismo: l’uso vivido del colore, conservato perfettamente, restituisce soprattutto nella resa degli incarnati e nei volti rosei un’intensa vitalità al gruppo scultoreo, già presente nell'atteggiamento spontaneo e giocondo del Bambino.
Fra le due edicole dietro l’altare maggiore si trova un Crocifisso ligneo, attribuito alla bottega di Andrea Pisano, da datare intorno agli anni ‘30 del Trecento. Proveniente probabilmente dalla pieve di San Martino, dove la confraternita dei Neri (altra compagnia laicale presente a Palaia) possedeva un altare dedicato al crocifisso, l’opera è realizzata sulla scia della tradizione duecentesca raffigurante Christus patiens, in cui il lato drammatico della sofferenza è esaltato da alcune caratteristiche fisiche del corpo, come avviene per la resa naturalistica del costato (fig.10).

Un altro Crocifisso probabilmente commissionato dalla stessa compagnia dei Neri e fin dall'origine pensato per essere collocato in Sant'Andrea, si trova nella cappella laterale della navata sinistra (fig.11).

Per la similitudine con alcune croci di ambito senese, la critica recente sostiene che l’opera sia da collocare in questo contesto, per mano di un anonimo intagliatore negli anni fra il 1335 e il 1340. La figura emaciata di Gesù, con la testa inclinata e contornata da un rivolo di sangue, suscita nel fedele un intenso impatto emotivo.
Nella stessa parete sinistra dell’aula si trovano anche dodici formelle in terracotta invetriata, assegnate ad Andrea della Robbia (1435-1525) e datate al 1490 circa. Anche queste provengono dalla pieve di San Martino, forse appartenute al rivestimento di un ciborio in seguito smembrato e in parte perduto. Oggi le formelle a sfondo blu e figure bianche si presentano collocate orizzontalmente, divise su due registri: quello inferiore è il più esteso e presenta una serie di nove personaggi che ritraggono a partire da sinistra, Santa Caterina e San Francesco, al centro Cristo porta croce affiancato da quattro virtù, Carità, Speranza, Fede (virtù teologali) e Prudenza (virtù cardinale), ed infine San Martino e Santa Maria Maddalena. Nel registro superiore sono rappresentati San Sebastiano, Sant'Antonio da Padova, e Santa Lucia. Fra le formelle notiamo che quelle centrali del registro inferiore presentano delle nicchie che inquadrano i cinque personaggi a figura intera, mentre i rimanenti Santi sono tagliati poco sopra il ginocchio. Cristo e le Virtù sono collocati in nicchie rifinite ai lati da piccoli clipei colorati: parti policrome sono visibili anche in alcuni attributi che caratterizzano le figure, come la cornucopia esibita dalla Carità e il serpente, simbolo della Prudenza (fig.12).

L’opera è riferita per via stilistica ad Andrea della Robbia, nipote di Luca, che si differenzierà da quest’ultimo per conferire ai suoi soggetti un’inclinazione affettuosa e sentimentale più spiccata, guardando anche alle novità apportate della pittura contemporanea.
Concludendo questo itinerario in Sant'Andrea, ci spostiamo sulla parte destra dell’aula, dove si trova un monumentale altare che incornicia una tela settecentesca, uniche testimonianze degli arredi barocchi della chiesa, già dipendente in questo periodo dalla diocesi di San Miniato (fig.13).

I lavori per la cappella furono voluti dalla compagnia della Concezione e documentati a partire dal 1728, quando il maestro ticinese Ridolfo Frullani, venne pagato per la realizzazione dell’altare in stucco. L’artista, che si inserisce in quel filone molto prolifico di stuccatori ticinesi presenti in Toscana nel Settecento, realizzò un’edicola sorretta da colonne tortili (dipinte imitando le venature del marmo e impreziosite da tralci di vite dorate), culminante in un architrave spezzato e una cornice mistilinea, dove è modellato in stucco il Peccato originale, di rimandano all'iconografia del dipinto raffigurante l’Immacolata Concezione. Anton Domenico Bamberini (1666-1740) pittore di formazione fiorentina e molto attivo nella diocesi di San Miniato, fu chiamato a realizzare la tela nel 1730, ritraendo Maria Immacolata stante con i piedi sul globo terracqueo (sembra appena percettibile anche una mezza luna nascosta per metà dalla Terra), affiancata dai Santi Pietro e Agostino, mentre schiaccia il serpente, simbolo del peccato originale che opprime gli uomini e da cui la Vergine è immune: l’iconografia dell’Immacolata fa anche riferimento alla “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”, descritta nell’Apocalisse. Nell'opera palaiese il cielo dorato e rischiarato dalle nubi contrasta con le intense ombre proiettate sui personaggi, creando un’atmosfera mistica, conforme alla bellezza solenne di Maria.
Bibliografia
- Ducci, L. Badalassi, I Tesori medievali nel territorio di San Miniato, Ospedaletto 1998.
- Malacarne, La pieve di San Martino a Palaia, in Palaia e il suo territorio fra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi (9 gennaio 1999) a cura di Paolo Morelli, Pontedera 1999, pp. 181-198.
- Padoa Rizzo, “Due statue per una Confraternita di Palaia: Francesco di Valdambrino e Luca della Robbia”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 79.2000, 67, pp. 55-68.
- Tigler, Scheda n.63 (Intagliatore senese, Crocifisso), Scheda n.65 (Bottega di Andrea Pisano, Crocifisso), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 160-161, 163-165.
- Campigli, Scheda n.67 (Francesco Valdambrino, Madonna col Bambino), Scheda n.68 (Luca della Robbia, Madonna col Bambino), Scheda n.69 (Andrea della Robbia, Madonna col Bambino) in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 165-173.
- Bitossi, Scheda n.70 (Anton Domenico Bamberini, Immacolata concezione con i Santi Pietro e Paolo), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 174-176.
Michele Gotti, “Scultura architettonica medievale in Valdera: i capitelli delle pievi di San Gervasio, Montignoso, Palaia e Peccioli”, in Erba d’Arno, N. 155/156, 2019, pp. 58-79.
- Falconi, “Lo strapiombo fa sempre più paura: la frana minaccia la pieve di San Martino”, Il Tirreno- Pontedera, 10 maggio 2019.
SAN MINIATO AL TEDESCO: IL BORGO
A cura di Luisa Generali
Introduzione
Descrittada Maurice Howlett come “la città che è impossibile nascondere”, San Miniato è nota per il suo simbolo, la rocca federiciana, che domina svettante sulla sommità del colle su cui si estende il borgo. Circondato da una visuale panoramica che verso nord si affaccia sulla piana della Valdarno inferiore, mentre a sud si apre alle verdi colline tipiche della Toscana, San Miniato non può sfuggire alla curiosità dei turisti per la sua ricchezza paesaggistica e storico-artistica oltre che gastronomica, già nota grazie alla Mostra Nazionale del tartufo bianco che si svolge ogni anno nel mese di novembre,giunta alla sua 49° edizione.Si ricordano inoltre le importanti iniziative teatrali promosse dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato attiva dal 1947, che ogni anno nel mese di luglio propone una prima assoluta riguardo a tematiche moralmente impegnate, d’ispirazione spirituale-cristiana,messe in scena nei luoghi più suggestivi del paese (si rimanda al sito: www.drammapopolare.it).
Storia di San Miniato
Fin dall'epoca etrusco-romana, la posizione strategica dell’altura favorì lo sviluppo del primo nucleo fortificato, che col passare dei secoli divenne sede dei vicari imperiali ottoniani (X-XI secolo), tra cui in particolare si ricorda Bonifacio, marchese di Toscana e padre di Matilde da Canossa: da qui la dedica del nome di un antico torrione del castello detto appunto “di Matilde”, in seguito divenuto l’attuale campanile del duomo.
È proprio a causa della prolungata presenza dei vicari del regno germanico in questa terra che sarebbe nato l’appellativo di San Miniato “al Tedesco”, per distinguere il paese dalla zona fiorentina di San Miniato al Monte. Con la reggenza di Federico II di Svevia, più volte dimorante a San Miniato, la prima fortificazione si arricchì ulteriormente grazie alla costruzione della rocca (fra il 1217 e il 1223), innalzata sul vertice del colle, in modo da sfruttare l’ampia visuale sul territorio toscano, in una posizione centrale, equidistante da importanti centri cittadini quali Pisa, Firenze,Lucca e Volterra. La rocca divenne un ottimo strumento militare-difensivo e una prigione politica, dove probabilmente fu detenuto anche il segretario imperiale Pier delle Vigne,accusato di tradimento, che Dante rese celebre nel canto XII dell’Inferno. La torre, così come la possiamo ammirare oggi, fu fedelmente ricostruita e inaugurata nella primavera del 1958, dopo che il passaggio della guerra nel ’44 distrusse l’originaria struttura duecentesca.
Tra i complessi religiosi più antichi risalenti al XIII secolo, si annoverano due importanti monasteri:il Convento di San Francesco,ben distinguibile sul declivio del colle grazie alla sua imponente mole rossastra simile a una fortezza,e il Convento di Santa Chiara, oggi sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, che ospita un importante spazio espositivo inserito nel sistema museale del paese.
Dopo la dominazione sveva la storia di San Miniato continuò nei secoli a venire prima come libero comune di ordinamenti guelfi, ed in seguito sottomesso al potere centrale di Firenze: di questo lungo periodo si segnalano gli affreschi trecenteschi per la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale e l’Oratorio del Loretino, al piano terra dello stesso palazzo,contraddistinto dalla presenza di un grande altare in legno dorato, gioiello d’arte cinquecentesca, a cui lavorarono nei comparti pittorici artisti come Francesco d’Agnolo Lanfranchi, detto lo Spillo, fratello di Andrea del Sarto e Giovanni Larciani, identificato con il misterioso Maestro dei Paesaggi Kress.
Il passaggio nel dispiegarsi della storia si legge ancora oggi nel volto architettonico del borgo, esplicito nei monumenti, nelle chiese e nelle abitazioni, oltre che nelle opere pittoriche e in quelle scultoree: è proprio grazie alle storie raccontate da alcune testimonianze in marmo che proveremo a dare una lettura storico-artistica del trascorso illustre di San Miniato, a cominciare dal lato occidentale del borgo, nella chiesa sconsacrata di San Martino, oggi auditorium e spazio polivalente per eventi prevalentemente culturali.
La chiesa di San Martino
Con un paramento in mattoni di tonalità rossastra, peculiarità che accomuna diversi edifici sanminiatesi, al suo interno la chiesa si presenta ad aula unica, impreziosita da altari votivi e pitture: dando le spalle alla porta d’ingresso, dietro l’altare laterale destro trova posto un tabernacolo murario quattrocentesco a forma di edicola (fig.1). Questo oggetto, di primaria importanza, costituisce l’unico esempio di tabernacolo marmoreo presente a San Miniato, oltre che una testimonianza di valore rispetto alle influenze artistiche rinascimentali fiorentine nel contado. Costruito su più livelli, la parte alta è terminata da un frontone in cui Dio Padre Benedicente (nella mano mutila) si stacca in forte aggetto, sorreggendo un libro su cui un tempo erano rappresentate le lettere greche alfa e omega, simboli dell’Eterno. Il corpo centrale si struttura intorno allo sportello del tabernacolo, creando un ambiente profondo, in cui le linee di fuga si riflettono nella volta decorata a rosette: ai lati dello sportello due angeli reggi-candelabro sono inseriti entro due nicchie, anche queste rese di scorcio. L’intento dello scultore era quello di ricreare uno spazio illusoriamente profondo, giocando con le possibilità scultoree del rilievo e alternando parti in schiacciato ad altre più aggettanti, con lo scopo di imitare le novità prospettiche pittoriche: qui in particolare la citazione diretta si rifà all'ambiente voltato in cui è ambientata la Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella. La parte conclusiva del tabernacolo presenta delle volute di raccordo decorate a fiori e girali, mentre al centro un grazioso angelo, con un'acconciatura a cuffia sulle tempie, è intento nella lettura di un sacro libro. L’opera marmorea è attribuita dalla critica alla bottega di Bernardo e Antonio Rossellino, attivi a Firenze nella metà del ‘400, di cui restano testimonianze anche nella vicina Empoli. L’impianto compositivo dell’opera sanminiatese è quello tipico delle edicole a muro di scuola post-donatelliana, esattamente a metà strada fra il Tabernacolo di Sant’Egidio, realizzato dalla bottega dei Rossellino intorno al 1450 e il celebre Tabernacolo del Sacramento attribuito a Desiderio da Settignano nel 1461 per la Basilica di San Lorenzo, oggi collocato nella navata destra. Entrambi questi esempi conservano caratteri comuni con il tabernacolo sanminiatese e condividono un tipo di impostazione simile nella resa dello spazio e negli elementi decorativi. L’attribuzione alla bottega dei Rossellino, e in particolare ad Antonio, acquista credibilità alla luce dalla conoscenza degli scultori fiorentini con Giovanni Antonio Chellini, medico e umanista sanminiatese che volle essere sepolto nella chiesa domenicana dei Santi Iacopo e Lucia in Piazza del Popolo: qui oltre a una innumerevole serie di pregevoli pitture, fra cui si ricorda il bellissimo mare quattrocentesco, popolato da fantasiosi mostri marini, si trova anche il sepolcro marmoreo del Chellini. L’opera si trova nella prima cappella della navata destra, vicino all'altare maggiore, e si presenta come un tipico sepolcro murario quattrocentesco, composto su più livelli (fig.2). La lavorazione del monumento si prolungò dal 1462 fino agli anni ‘80 del Quattrocento, benché l’assetto che vediamo oggi sia frutto di un ulteriore rimaneggiamento settecentesco, che andò a modificarne la parte superiore. L’attribuzione alla mano di Antonio Rossellino nasce dal busto ritratto raffigurante fedelmente il Chellini, oggi al Victoria &Albert Museum di Londra, e firmato proprio come opera di Antonio (fig.3). La stessa accortezza interpretativa si ritrova nel ritratto del Chellini sul letto di morte, mentre ai lati due lesene decorate segnano i confini strutturali del sepolcro,terminante con un frontone. Le differenze stilistiche rispetto alle decorazioni a candelabro nelle lesene superiori con motivi a girali, e in quelle inferiori, ornate con vasi e bacili sovrapposti, indicano la presenza di maestranze diverse, forse attive a distanza di tempo.
Il Museo Diocesano di Arte Sacra
Salendo nella parte dell’antica cittadella di San Miniato, nei locali della vecchia sagrestia accanto al Duomo, si trova il Museo Diocesano di Arte Sacra, che raccoglie un’importante collezione di opere provenienti dal territorio. Due lastre marmoree musealizzate nella prima stanza costituivano un antico pulpito, firmato dal lapicida lombardo Giroldo da Como: entrambe scolpite in bassorilievo, la lastra più grande rappresenta l’Annunciazione, mentre quella più piccola esibisce un’iscrizione su fondo liscio, in cui compare la dedica del committente con il relativo stemma gentilizio, la firma dell’artista e l’anno di esecuzione, risalente al 1274 (fig.4). Nell’Annunciazione lo stile di Giroldo scava in maniera arcaizzante le due figure, unite nella stessa lastra ma separate da due riquadri circoscritti: mentre l’arcangelo si trova in uno spazio indefinito, reso attraverso lo sfondo neutro della lastra, l’ambiente che avvolge Maria diventa invece reale e architettonico, consolidato dalla presenza dell’arco trilobato sostenuto da colonne, insieme alla piccola figura di un’ancella che assiste in disparte all'evento. Anche le due frasi che illustrano la scena acquisiscono un senso fisico, come si deduce dalle parole pronunciate da Maria, scritte nel verso contrario: questa scelta volutamente eseguita dall'artista aveva forse lo scopo di richiamare concretamente il mistero dell’Incarnazione, del Verbo che si fece Carne.
Spostandosi verso il Duomo, intitolato a Santa Maria Assunta e San Genesio, si nota il tipico paramento murario in laterizio, arricchito in facciata da vari bacini ceramici raffiguranti animali, che avevano lo scopo di animare cromaticamente la superficie dell’edificio. All'interno, fra le opere in marmo di notevole interesse,nella prima cappella sul lato sinistro della chiesa si trova la Fonte battesimale di Giovan Battista Sandrini (terminata nel 1637), l’unica opera nota di questo artista poco conosciuto, nato a Fiesole e attivo a Pisa nella prima metà del XVII secolo (fig.5). La fonte è costituita da un grande bacino semisferico, scolpito con motivi decorativi graziosi, quali teste di cherubino, motivi foliacei, fiori e ghirlande.
Fa invece parte del ri-allestimento ottocentesco la scelta di rinnovare l’interno del duomo celebrando le glorie cittadine sanminiatesi in un significato civile e cristiano, come dimostrazione concreta dei progetti divini realizzati grazie all'intelletto umano: per dare nuovo lustro alla chiesa con un rinnovamento in stile purista,fra il 1862 e il 1864 vennero realizzati quattro monumenti alla memoria di illustri concittadini, richiamando idealmente i Sepolcri foscoliani: così vennero ricordati il poeta Pietro Bagnoli, lo storico Iacopo Buonaparte, il vescovo Giovanni Francesco Maria Poggi, e il chimico Gioacchino Taddei, rappresentati dall'allegoria delle loro discipline e dai rispettivi busti-ritratto, su progetto dello scultore Giovanni Dupré e della figlia Amalia (fig. 6). I quattro bassorilievi allegorici, incassati in una spessa cornice di marmo grigio e illustrati da una dedica, si trovano simmetricamente a gruppi di due, nelle navate laterali del duomo: le figure allegoriche rappresentate (la Poesia, la Storia, la Religione e la Chimica), sono contraddistinte da uno stile calligrafico, in linea con i modi scultorei della giovane Amalia Dupré, mentre i tre busti (escluso quello del Bagnoli, scolpito da Tommaso Masi) sono assegnati dalla critica alla mano impeccabile di Giovanni. Le allegorie si stagliano di profilo sullo sfondo liscio, drappeggiati all'antica in una ambientazione indefinita, scevra di qualsiasi forma di decorativismo, che le connota di un’impronta nobile e solenne: gli unici dettagli sono quelli funzionali al riconoscimento delle discipline, identificati con precisi oggetti, come la lira, simbolo della poesia, la storia intenta nella scrittura, il messale, e gli apparecchi del chimico.
Per la medesima chiesa, Amalia eseguì anche i rilievi del nuovo pulpito marmoreo, di forma poligonale su base a calice, in sostituzione di quello di Giroldo da Como (rimosso nel 1860), e collocato in mezzo alla navata centrale (fig.7): i compartimenti neutri del pulpito sono occupati da sacri personaggi a figura intera, fra cui si riconoscono al centro Maria e Cristo Risorto, contraddistinti da un algido rigore.
Scendendo le scale che dal Duomo riportano nel borgo, si apre Piazza della Repubblica o del Seminario, così chiamata per la presenza del palazzo seminariale, ottenuto dalla fusione di più case che seguivano l’andamento delle vecchie mura preesistenti, e per questo di andamento leggermente semicircolare.La facciata dell’edificio venne dipinta dal pittore fucecchiese Francesco Chimenti nei primi anni del XVIII secolo, con figure allegoriche incorniciate da finti prospetti architettonici, motti e medaglioni, su un fondale aranciato in sintonia con il colore rossastro dei vicini edifici. Fino al 1799, prima dell’assalto dei giacobini, al centro di questa piazza, era collocata la statua di Maria Maddalena d’Austria (moglie del Granduca Cosimo II de’Medici), per omaggiare la regnante che nel 1622 aveva elevato San Miniato a diocesi e città. L’unica testimonianza di questa monumentale statua, realizzata dalla bottega di Antonio Susini, valente scultore fiorentino della scuola del Giambologna, si trova oggi nel cosiddetto Canto di Sant'Andrea in via Rondoni, contraddistinto dalla presenza di un edificio ad angolo, su cui si trova un crocifisso in ceramica realizzato dal pittore sanminiatese Dilvo Lotti. Ai piedi del crocifisso un blocco di marmo identifica quella che fu un frammento della scultura (fig.8): secondo le fonti storiche l’opera doveva essere composta dalla figura intera della regnante con in pugno uno scettro, e la presenza di un leone (simbolo di San Miniato), accompagnato dal blasone dei Medici e degli Asburgo.
Proseguendo lungo Via Vittime del Duomo, sulla sinistra davanti al palazzo comunale, si apre una scenografica scalinata che conduce al Santuario del SS. Crocifisso, progettato da Antonio Maria Ferri nel 1718. Fra le statue che animano le rampe, nella nicchia centrale si trova il Cristo Risorto, scolpito da Francesco Baratta nel 1723. L’immagine di Cristo trionfante, è colta nell'attimo appena successivo alla resurrezione,ancora avvolto per metà dal sudario, mentre il volto leggermente ruotato e incorniciato dai capelli emana un’austera sacralità. La scultura richiama influenze stilistiche tipicamente berniniane, che continuarono ad essere reinterpretate anche a distanza di tempo e che tradiscono una formazione romana dell’artista, proveniente da una celebre famiglia di scultori carraresi, i cui avi si formarono proprio a stretto contatto con Gian Lorenzo Bernini. Il manto che si espande nello spazio, avvolgendosi su sé stesso, è tipico del gusto barocco, così come il fascio di raggi che indica l’avvenuta resurrezione. Oggi snaturalizzata dal suo contesto di appartenenza, in origine la scultura venne eseguita per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco, ideata per essere avvolta dalla luce naturale da retro, e favorire quindi quell'effetto di bagliore miracoloso reso ancor più evidente dalla corona di raggi e dallo splendore del marmo. (La scalinata con le relative statue è attualmente in restauro. Per le fotografie si rimanda alla pagina web in sitografia)
Concludiamo questo viaggio attraverso il marmo proseguendo per Via Rondoni e Via de’ Mangiadori che si apre su Piazza Buonaparte (denominata così per la presenza del palazzo di famiglia dei Buonaparte, parenti di Napoleone che si fermò in visita a San Miniato nel 1796). Al centro della piazza (fig.9),delimitata da un’elegante ringhiera, si trova la statua di Leopoldo II, detto il “Canapone” (così chiamato per il colore dei suoi capelli), scolpito dal Luigi Pampaloni nel 1843 (sono di Pampaloni anche i Quattro evangelisti nelle nicchie sotto la cupola del SS. Crocifisso e gli Angeli Tubicini in terracotta sulla relativa scalinata). L’omaggio marmoreo venne creato per celebrare il governo granducale, che con la restaurazione dei Lorena dette un impulso positivo alla vita socio-economica della città. La scelta dell’artista ricadde su Pampaloni,scultore d’impostazione purista, che nel ritrarre il Granduca seppe giustamente calibrare caratteristiche ideali e reali. La figura marmorea di Leopoldo si mostra in piedi,coperto da un'abbondante toga, richiamando i ritratti imperiali della statuaria romana, mentre il volto, con un’espressione pacifica e al contempo autorevole, acquisisce veridicità per l’acconciatura alla moda e le caratteristiche basette. L’atteggiamento dignitoso della statua è finalizzato anche a sottolineare le virtù morali del regnante, qui riferite specificatamente nel cartiglio esibito nella mano destra “motu proprio 2 agosto 1838”, riferito alla riforma del sistema giudiziario voluta da Leopoldo; l’opera venne infatti posta davanti alla sede del Tribunale Collegiale di Prima Istanza che trovò collocazione proprio nell'antico palazzo Buonaparte.
Bibliografia
- H. Hewlett, The Road in Tuscany, Londra - New York 1904.
- Scappini, La chiesa di San Martino alle carceri, in San Miniato: immagini e documenti del patrimonio civico della città, a cura di Roberta Roani Villani e Luigi Latini, Ospedaletto 1998, pp. 129-145.
- Roani,Episodi d’arte e di restauro nella chiesa di San Francesco e nella Cattedrale di San Miniato, in San Miniato nel Settecento: economia, società, arte, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2003, pp. 199-240.
- Bitossi, M. Campigli, Per frammenti rimasti. Pittura e scultura in cattedrale dalle origini al XVII secolo, in La cattedrale di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2004, pp. 81-124.
S.Renzoni,La ristrutturazione della cattedrale tra Ottocento e Novecento, in La cattedrale di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2004, pp. 187-238.
- Roani Villani,“Sotto gli occhi del padre Giovanni: Sculture di Amalia Dupré nel duomo di San Miniato al Tedesco”, in Paragone, 55.2004, Ser. 3, 58, pp. 52-68.
- Nanni, I. Regoli, San Miniato. Guida Storico Artistica, Ospedaletto 2007.
- Marconi, “La statua di Leopoldo II a San Miniato ed altri monumenti di Luigi Pampaloni: spunti di riflessione per l'iconografia degli uomini illustri nell'800”, in Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 86.2008, 75, pp. 129-152.
- Campigli, Monumento funebre di Giovanni Chellini (Scheda n.21), in Visibile pregare. Arte sacra nella diocesi di San Miniato, vol.3, Ospedaletto 2013, pp. 109-112.
- Pasqualetti, “La chiesa della SS Annunziata di San Miniato (San Martino alle Carceri)”, in Bollettino dell'Accademia degli Euteleti di Città di San Miniato, 92.2014, 81, pp. 413-427.
- Del Rosso, Il primo cinquecento a San Miniato: Bernardo di Niccolò Checchi architetto e l'ornamento del SS.Crocifisso. Con una nota su Giovanni di Lorenzo Larciani, Fucecchio 2017.
Sitografia
- Fiumalbi,Basettone (prima parte) – La celebrazione di Canapone, 2012:
www. smartarc.blogspot.com
- Fiumalbi,Basettone (seconda parte) – Canapone per San Miniato, 2012:
www. smartarc.blogspot.com
- Fiumalbi,La “restaurazione” di Maria Maddalena d’Austria, 2013:
www.smartarc.blogspot.com
F.Fiumalbi, Il Cristo Risorto di Francesco Baratta il Giovane nella scalinata del Santuario del SS. Crocifisso-a San Miniato, 2016:
<h3><strong>GALLERIA FOTOGRAFICA</strong></h3>
[nggallery id=144]