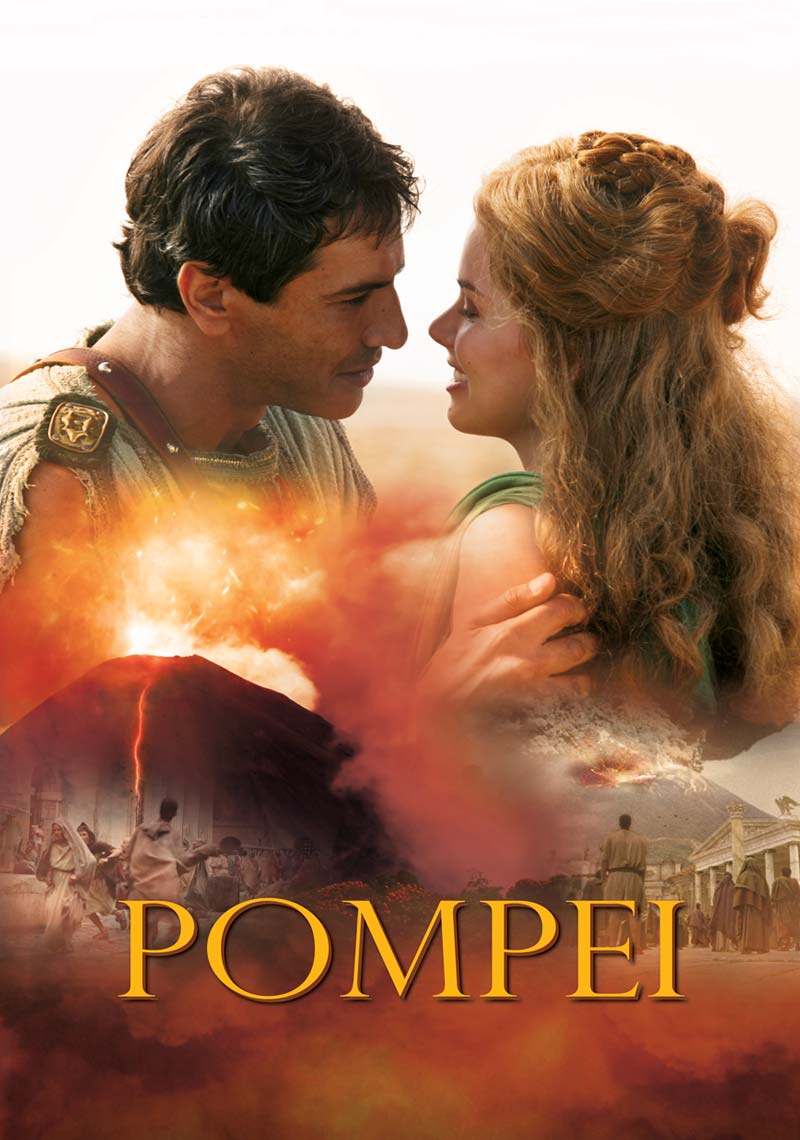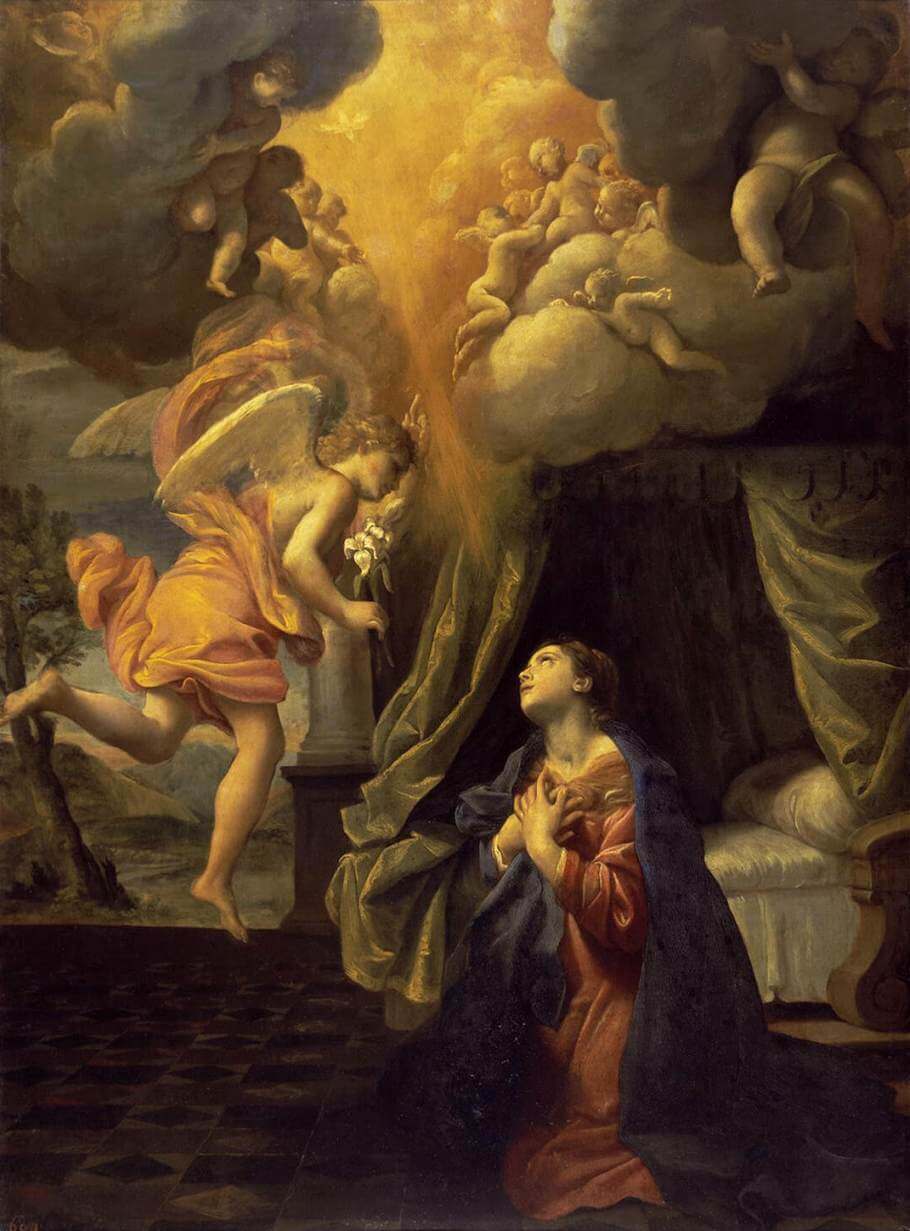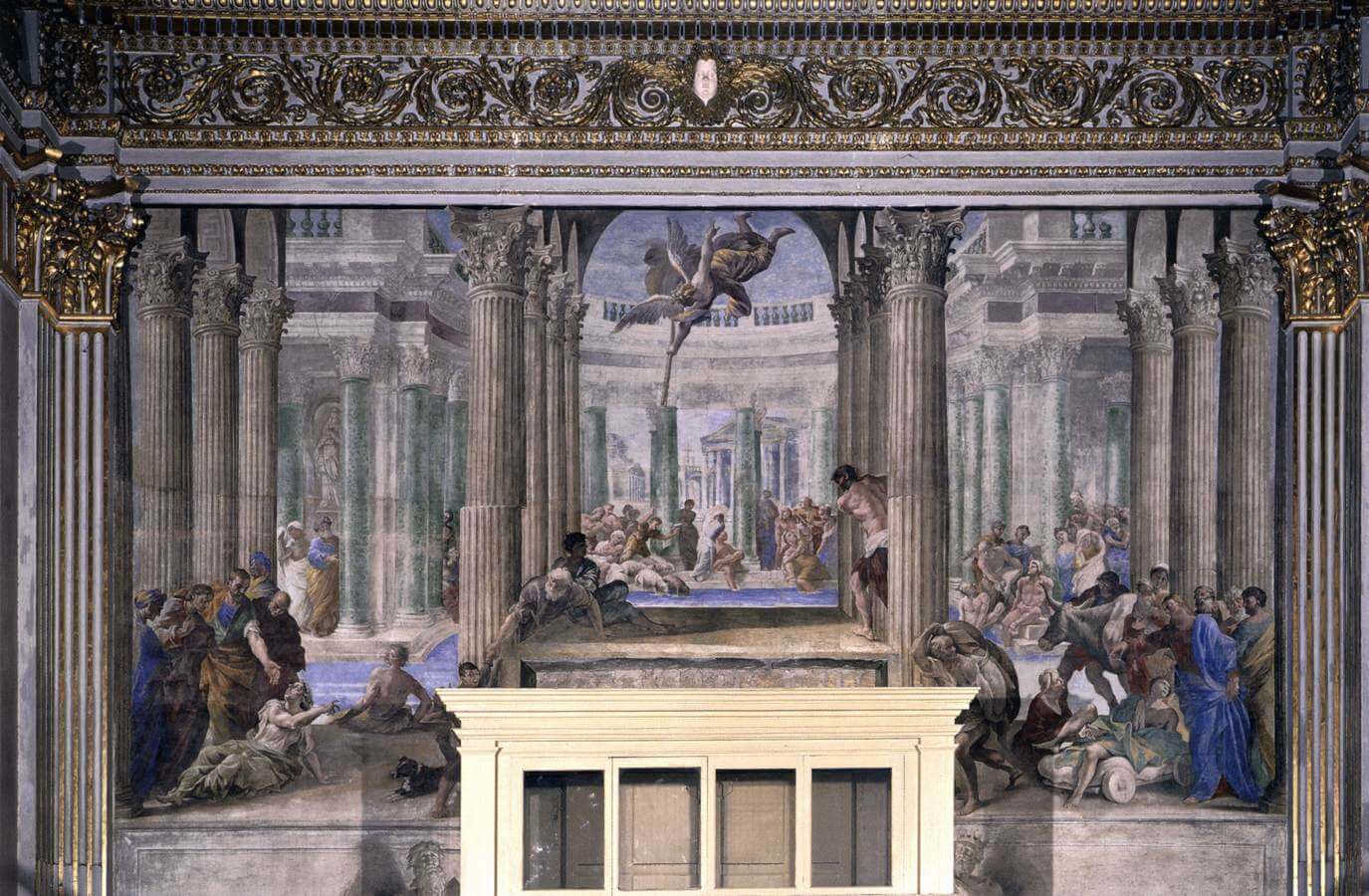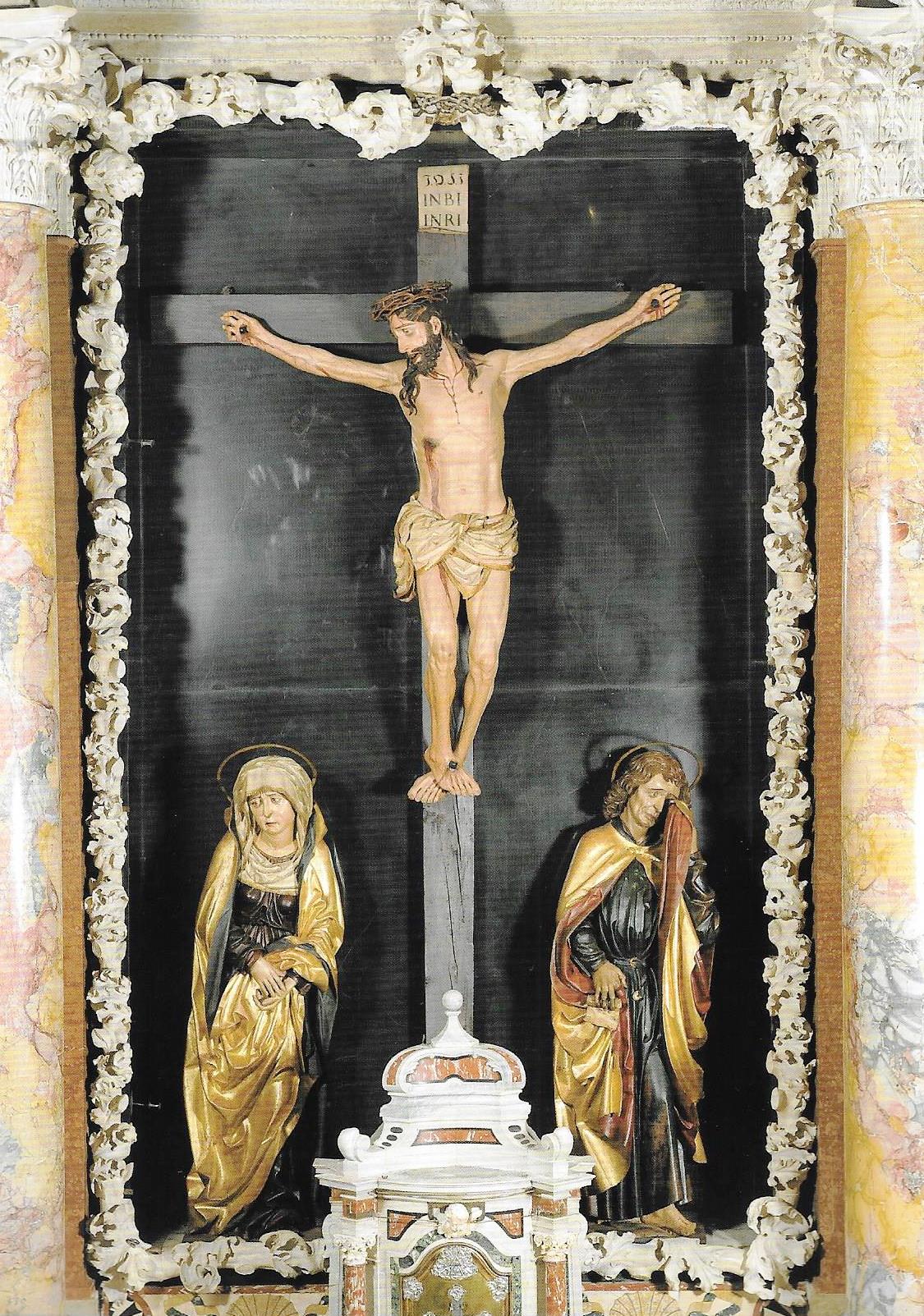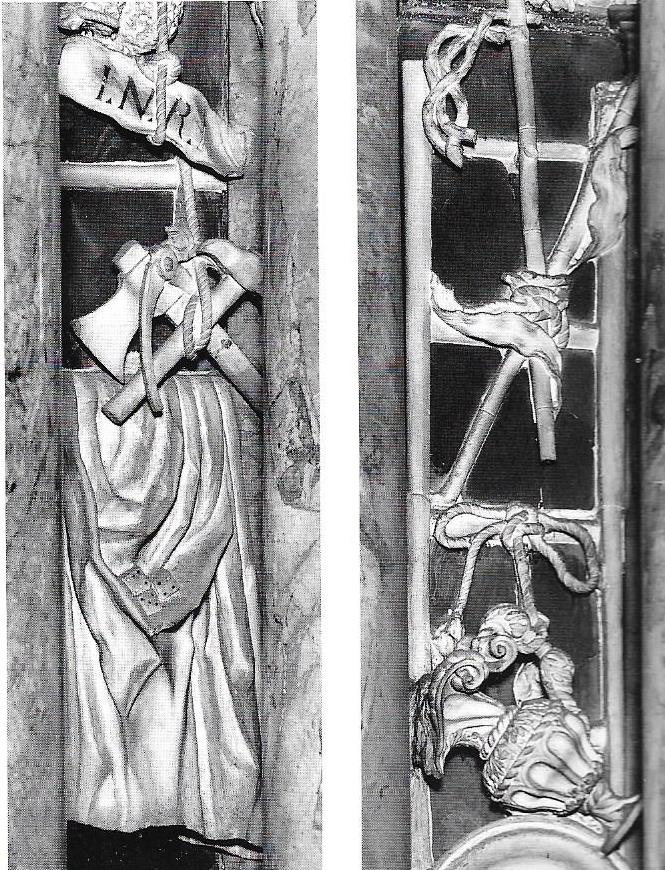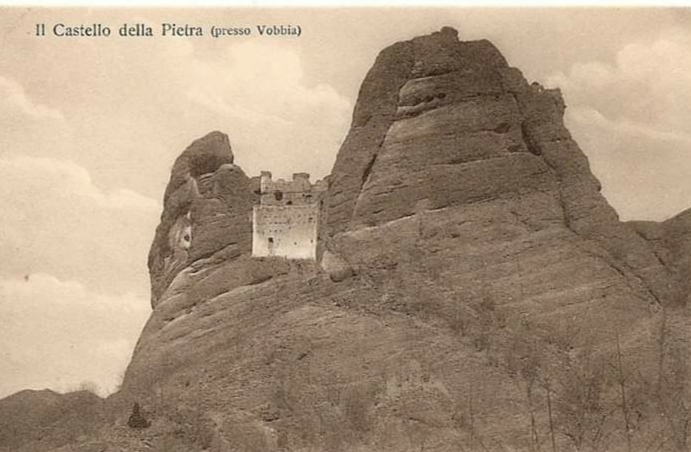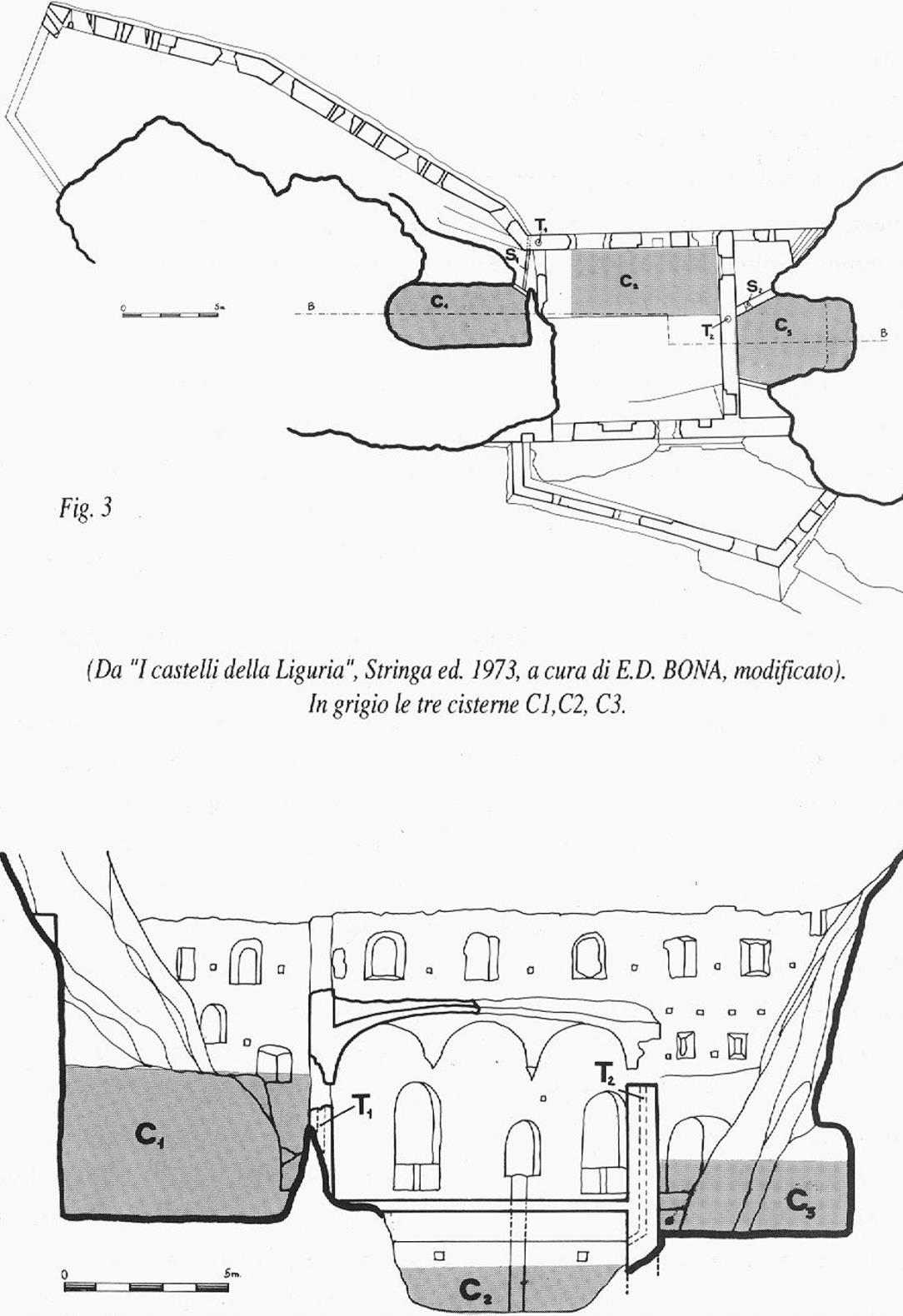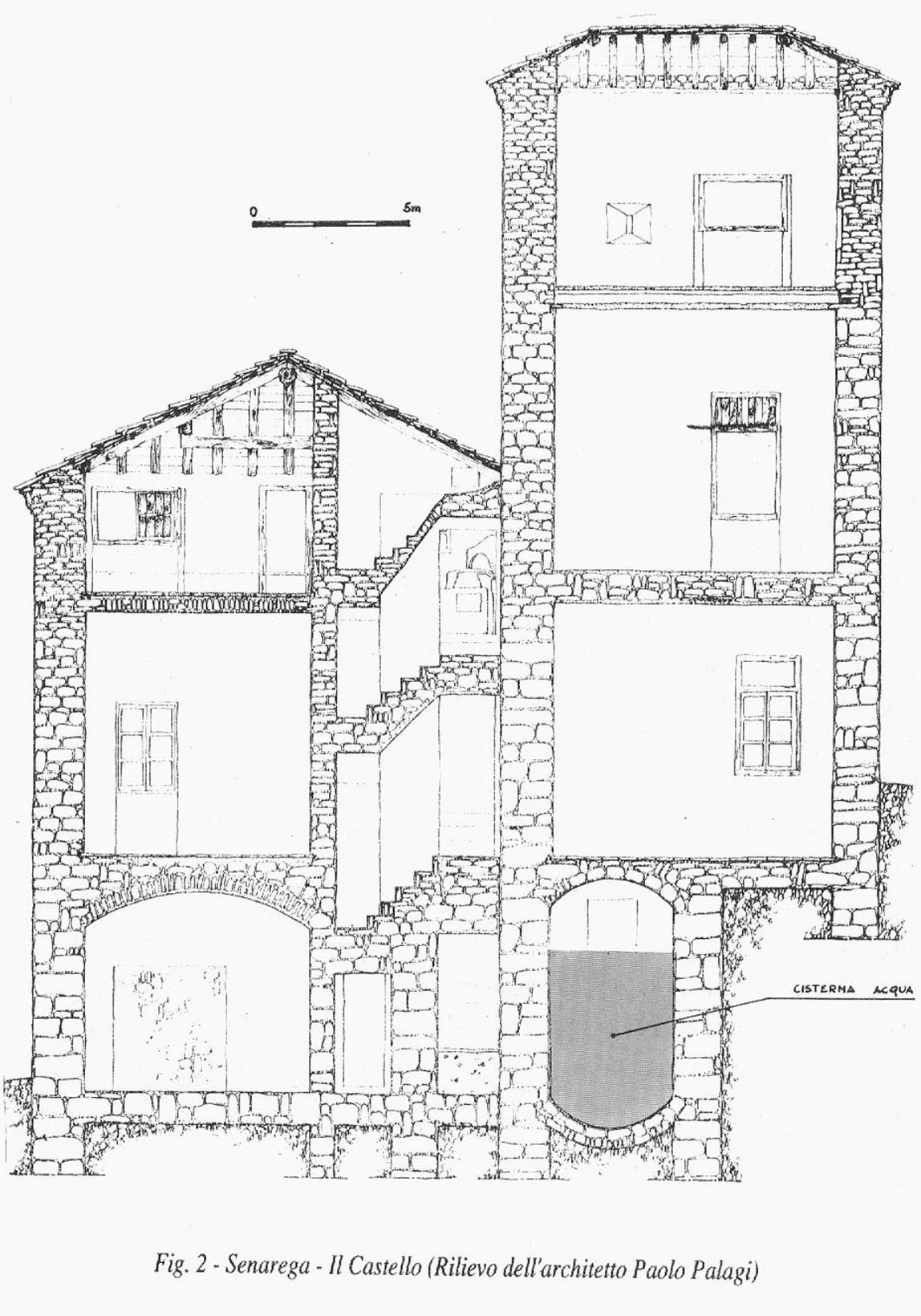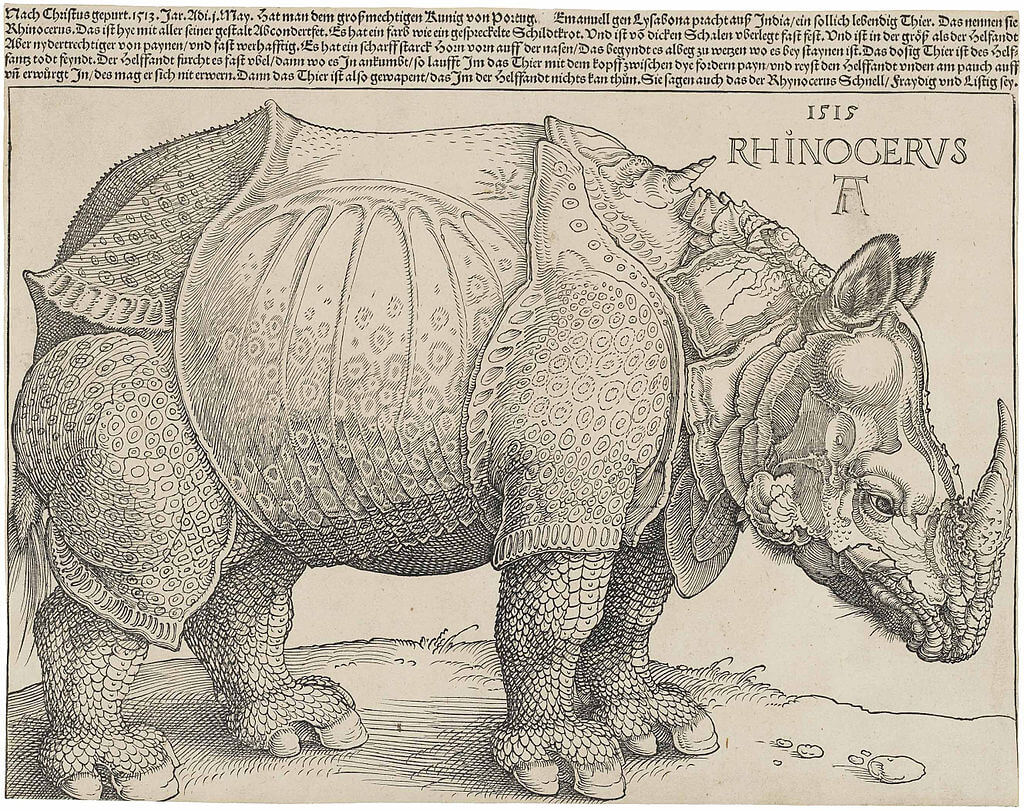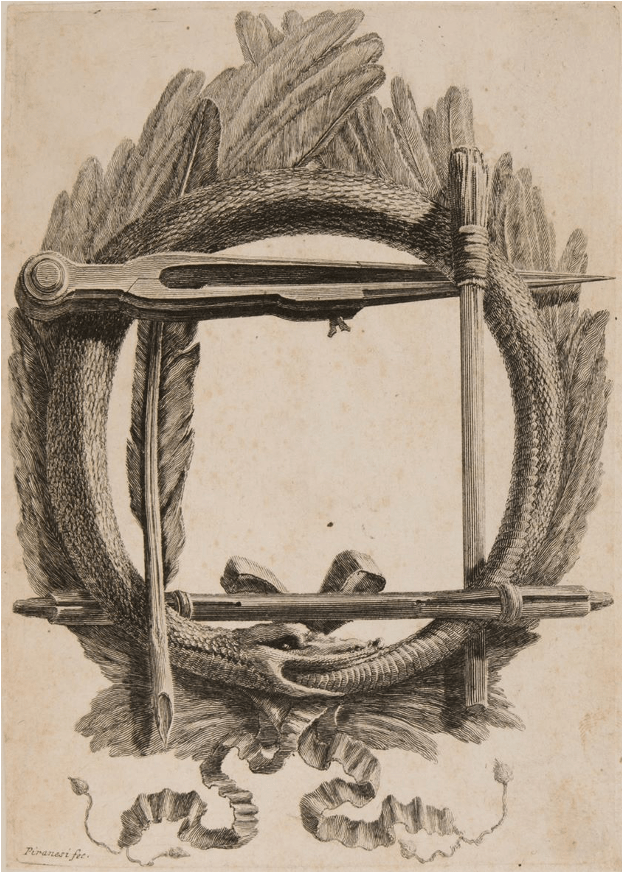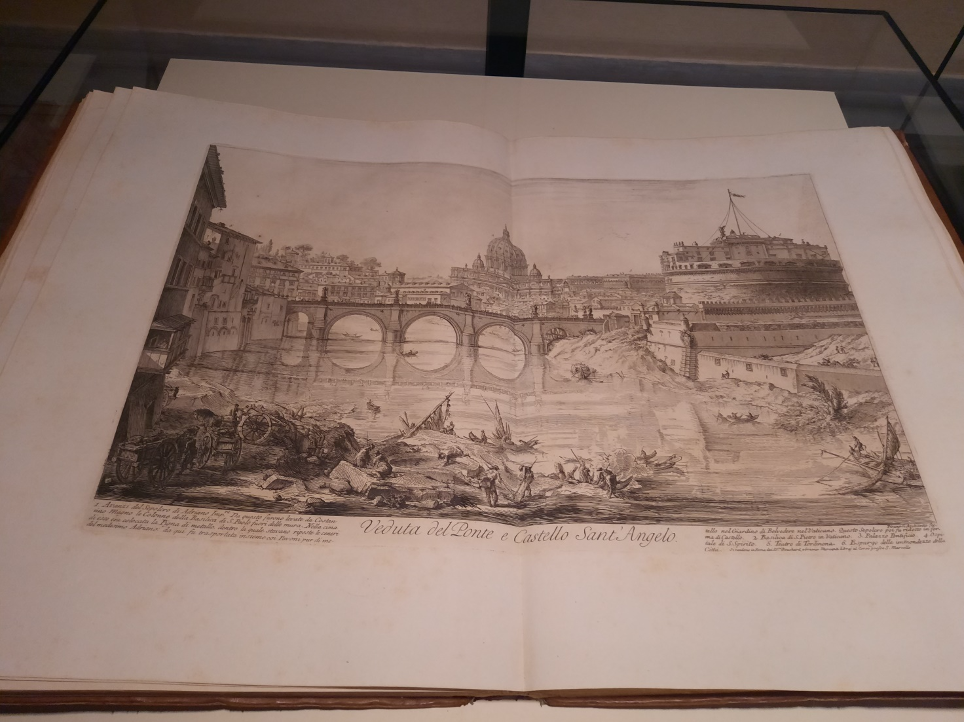LE 25 ORE DI POMPEI: STORIE DI UN’ERUZIONE
A cura di Dennis Zammarchi
Introduzione
Sulla città romana di Pompei e sull’eruzione del Vesuvio (avvenuta durante il regno di Tito nel 79 d.C.) che ne ha causato la distruzione prima e il seppellimento poi sono stati versati nel corso dei secoli fiumi d’inchiostro.
Si può ormai consciamente dire che le vicende riguardanti la celeberrima città romana siano entrate a far parte della cultura mondiale grazie ai risultati di decenni di studi storici e archeologici e alla conseguente divulgazione al pubblico.

Si è arrivati persino ad avvolgere gli avvenimenti con un alone di mistero e leggenda utili a renderli gradevoli e accattivanti per delle trasposizioni realizzate attraverso media come la tv ed il cinema, non sempre rispettando la veridicità storica dei fatti, in nome della spendibilità del prodotto.
Nel corso degli anni ne sono state tratte decine di trasposizioni bibliografiche, da romanzi storici fedeli alla realtà, per esempio “I tre giorni di Pompei” di Alberto Angela, a fumetti per grandi e piccini, sia di stampo occidentale che dal più tipico stile orientale (i manga giapponesi, che frequentemente prendono come spunto eventi storici avvenuti nel Bel Paese).
Come detto in precedenza, sono state realizzate anche moltissime trasposizioni cinematografiche e televisive: considerando solo le opere del XXI secolo, si possono citare la recente pellicola “Pompei” diretta nel 2014 da Paul W.S. Anderson, con protagonista Kit Harington (il Jon Snow del Trono di Spade) e la miniserie tutta italiana del 2007 chiamata “Pompei”.
Tuttavia, se il nostro scopo fosse quello di far luce sui motivi che attraggono ogni anno più di due milioni di visitatori da tutto il mondo a Pompei dovremmo partire dal principio.
La particolarità di questo sito archeologico, uno tra i più grandi del mondo e tra i meglio conservati, è quella di restituire un momento di una vita passata svoltasi durante l’Impero Romano sorretto dalla famiglia Flavia. Mutuando dall'antropologia culturale il termine potremmo parlare di “cristallizzazione”.
Questo è dovuto al fatto che oltre all'architettura della città, con i suoi monumenti e le sue numerose e splendide ville arredate, piene di splendidi affreschi (da cui prende il nome la celebre pittura pompeiana) e mosaici, ciò che differenzia Pompei dagli altri siti archeologici è la possibilità (parziale e influenzata dallo stato di conservazione del sito e dall'avanzamento degli scavi nei secoli) di rivedere lo stile di vita dei suoi abitanti, ma soprattutto è possibile “osservare” i cittadini pompeiani nei loro ultimi attimi di vita, talvolta distinguendone persino l’espressione.

Nella città i turisti possono vedere ancora le loro attività in corso per mezzo dei pochi arnesi e utensili sopravvissuti, i luoghi frequentati per piacere e per diletto come l’anfiteatro e il lupanare, ma ciò che affascina di più sono gli stessi abitanti.
Cittadini e forestieri che non sono riusciti ad evitare di essere coinvolti in questo disastro di proporzioni immani avvenuto il 79 d.C. che ha causato migliaia di vittime nell'area vesuviana.
Oggi chiamati comunemente fuggiaschi, queste bianche sagome, quasi eteree, non sono altro che i calchi delle vittime, realizzati nel corso dei decenni per mezzo di tecniche sempre più avanzate. Semplificando, si può dire che essi sono ottenuti riempiendo con il gesso i vuoti lasciati dai corpi nel deposito vulcanico.
Nel corso dei decenni e degli studi è stato sfatato “il mito” in cui Pompei viene descritta come la fotografia fedele di un momento di quotidianità sconvolta da un disastro naturale.
Questo è stato visto grazie agli scavi, ma anche per mezzo delle importantissime lettere, scritte a scopo letterario (Epist. VI,16) e dirette all'imperatore Traiano, che Plinio il Giovane (governatore in Bitinia, un’antica provincia romana situata in Asia Minore) avrebbe scritto come testimone oculare dell’eruzione del Vesuvio. All'interno di questa corrispondenza è riportata anche la morte dello zio di Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio, che come comandante della flotta imperiale di Miseno, tentò di portare soccorso ai pompeiani e che forse proprio a causa della sua passione per la scienza e la natura (di Plinio il Vecchio è celebre la De Naturalis Historia, una sorta di enciclopedia del sapere) si attardò nell'osservazione dell’evento e perciò perse la vita.
Dalle lettere sappiamo che il vulcano lanciò delle avvisaglie prima di eruttare per più giorni, che permisero a molte persone di raccogliere i propri beni personali e di fuggire dalla città.
Inoltre, già prima dell’eruzione di Pompei molte strutture erano pericolanti; numerose case ed edifici pubblici erano infatti in attesa di opere di ristrutturazione, resesi necessarie per sanare i danni causati da terremoti precedenti, il principale dei quali, sembra essere secondo le fonti quello del 62 d.C.
Ciò fece sì che molte delle abitazioni al tempo dell’eruzione non potevano essere abitate, almeno come non lo erano usualmente in quella regione della penisola.

Le numerose tracce di attività di cantiere e materiale da lavoro rinvenute negli scavi, oltre che la presenza di contenitori per provviste e suppellettili di uso domestico, rinvenuti in alcuni spazi che solitamente avevano una funzione abitativa o da sala di ricevimento chiariscono in che modo si cercò di trovare una soluzione ai problemi.
Inoltre Pompei, con i grandi edifici al tempo riconoscibili anche sotto gli strati di cenere, venne depredata, nel corso del tempo, da saccheggiatori pratici del posto, che andarono alla ricerca di oggetti di valore soprattutto all'interno delle case dei più abbienti.

In aggiunta, ulteriore elemento inficiante la quantità e qualità delle informazioni provenienti dagli scavi è il fatto che al momento dello sterro ottocentesco il materiale scavato è stato distribuito in aree adiacenti esplorate solo in un momento successivo.
Al tempo in più non si annotava né l’esatta posizione, né la quota del ritrovamento, ma l’obbiettivo era solo il mero recupero dell’oggetto intatto, soprattutto se di valore.
Una breve storia della città
Dal percorso irregolare delle mura cittadine ora visibili è evidenziata la volontà di adattarsi alle condizioni geografiche del luogo. Il passaggio da un terreno leggermente in salita verso nord in direzione del Vesuvio ad uno che dolcemente degrada verso est, avviene senza particolari interruzioni. Il percorso spigoloso del muro ad ovest segue invece il brusco declivio di un plateau di lava su cui la città era stata fondata verso la fine del VII secolo a.C.
Anche se è difficoltoso ricostruire l’andamento della costa antica e si rilevano certe differenze nelle ipotesi degli studiosi, attualmente è quasi certo che in epoca romana la città si trovasse molto più vicina al mare rispetto ad oggi.
La foce del Sarno, navigabile, sembra trovare nelle lagune prospicienti una difesa naturale e per questo un ottimo punto di attracco per le navi. Questa caratteristica fa di Pompei un luogo molto interessante per lo scambio di merci, tra cui il sale che proveniva dalle non lontane saline.
Scavi molto recenti evidenziano come gli insediamenti sorti agli inizi del I millennio a.C. siano stati spostati, verso la fine del VII secolo a.C., nelle vicinanze della foce del fiume.

Stando a quanto emerso dagli scavi archeologici il settore nord della città sembrerebbe essere stato tracciato e in parte edificato già nel VI secolo a.C., mentre l’ampliamento verso est sembra essere avvenuto solo durante il IV secolo a.C.
Nell'arco di alcune generazioni il primo insediamento sembra essere quindi cresciuto molto rapidamente e questo portò alla realizzazione di un primo muro di difesa, seppure di moderate dimensioni.
Ben presto però, forse già nel V secolo a.C. al modesto muro si sostituirà una prima fortificazione di dimensioni maggiori. Non è ancora noto se questa decisione fu presa per difendersi da un’effettiva minaccia da parte degli abitati vicini o delle tribù dell’entroterra.
Il V e il IV secolo a.C. restituiscono grazie alle evidenze archeologiche l’immagine di un periodo buio per la città; questi secoli corrispondono, infatti, con la fase del dominio sannitico, durante il quale non vennero create nuove opere urbanistiche, ma corrispose ad una fase di stagnazione.
Questa situazione cambiò solo con l’arrivo dei romani che nel corso delle guerre latine dal 343 a.C. espansero la loro sfera di influenza verso sud, oltre i confini del Lazio.
Grazie all'opera dello storico romano Livio (59 a.C.-17 d.C.) sappiamo che un distaccamento romano approdò alle foci del Sannio attorno al 310 a.C.
Solo nel III secolo la città assunse l’assetto urbanistico che determinò l’approvvigionamento e il traffico della successiva età imperiale, contraddistinta dalle sue 7 porte e dalla suddivisione nelle Regio.
L’eruzione
L’eruzione che coinvolse le città vesuviane è storicamente datata al 24 agosto del 79 d.C., ma oggigiorno questa datazione è messa in dubbio sia dalla documentazione letteraria che dai ritrovamenti archeologici.
Plinio il Giovane scrisse che suo zio, Plinio il Vecchio, morì nei pressi di Stabia (una delle coinvolte dal disastro, vicina a Pompei) durante l’eruzione arrivando dal porto di Miseno (essendo ammiraglio di una delle maggiori flotte dell’Impero) per andare in soccorso alla popolazione ed a un amico.
Dalle lettere si evince che l’eruzione fu “Nonum Kal. Sept.”, ossia nove giorni prima delle calende di settembre, il primo giorno del mese per il calendario romano.
Oltre a questo, sono stati trovati numerosi dolii, dei grandi vasi per contenere le derrate, pieni di mosto, quindi in un periodo in cui la vendemmia era quasi finita.
Inoltre, fondamentale testimonianza fu il rinvenimento di una moneta, coniata successivamente al 24 agosto per gli studiosi: un aureo con al diritto il volto di Tito e come legenda riporta la XV acclamazione imperatoria.

Tra le altre testimonianze che mettono in dubbio l’eruzione in agosto vi è la presenza di alcuni bracieri utilizzati al momento del disastro, il loro uso agli studiosi appare quantomeno inusuale durante un mese estivo.
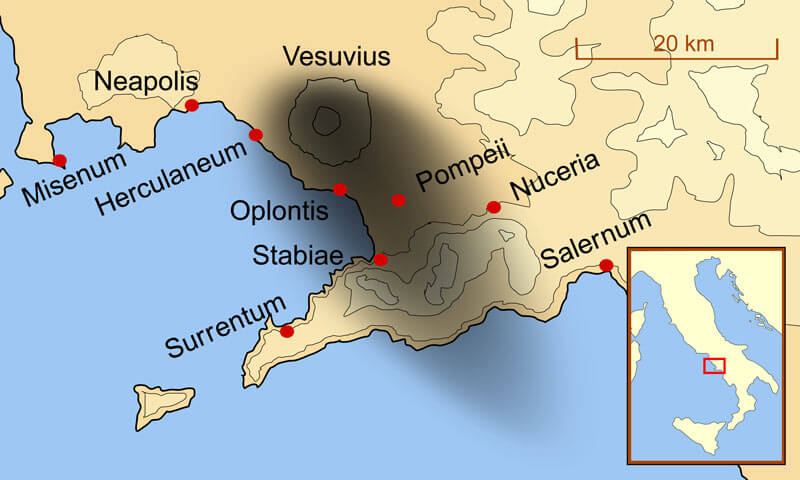
La città di Pompei, si trova nelle vicinanze di Napoli, a sud-est del cono del Vesuvio, non direttamente sul mare al tempo dell’eruzione, a differenza di Ercolano a soli 7 km dal cono del Vesuvio.
L’eruzione dura circa 25 ore, ma ad un certo punto si interrompe permettendo ai fuggitivi di ritornare in città. Pompei, Stabia, Ercolano e Oplonti sono le più colpite dall'eruzione; dal Vesuvio sono eruttati circa 1000000 di metri cubi di materiale.
Solitamente alle eruzioni vulcaniche, così come vediamo spesso nelle trasposizioni cinematografiche di questi disastri, sono associate le colate laviche, l’evento più semplice, ma soprattutto scenografico; ma sia nel caso di Pompei che Ercolano non si ha a che fare con della lava.
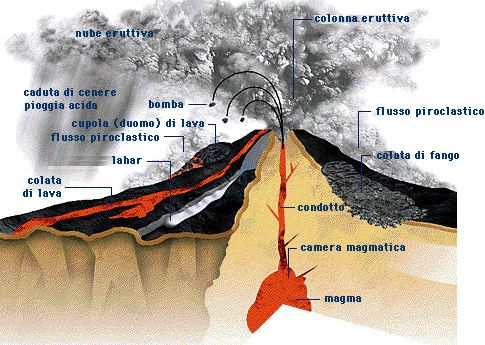
In realtà ciò che ha colpito la famosissima città romana sono dei tephra, ossia dei depositi di caduta lanciati in aria assieme alla colonna eruttiva anche a velocità supersonica fino a raggiungere quote elevatissime (come 30 km nei casi dell’eruzione del Vesuvio) per poi ricadere sotto forma di detriti di caduta, giungendo anche a distanze notevoli dalla colonna eruttiva per mezzo dei venti prevalenti.
Altri fenomeni, ben più distruttivi, che coinvolsero l’area vesuviana dopo l’eruzione sono stati i flussi piroclastici, dei flussi di materiale eruttato dal vulcano che ad un certo punto dopo essere stato lanciato in aria dalla colonna eruttiva ricade (poiché la spinta dei gas diminuisce) fino a formare delle enormi nubi di materiale incandescente comprendenti ceneri e materiali con dimensioni maggiore, come i lapilli, che durante la loro corsa distruggeranno tutto ciò che incontrano. Questi flussi possono spostarsi a velocità notevoli, tra i 20 m/s e i 100 m/s.
Il fenomeno peggiore però, ed il più pericoloso, sono sicuramente i “base surge” legati all’attività esplosiva e non al collasso della colonna; essi sono letali perché si tratti di gas ad altissima temperatura (tra 200 e 700 gradi Celsius) e rocce che possono provocare la combustione di moltissimi materiali, tra cui il legno, la vegetazione e i vestiti delle persone.
Questi gas incandescenti sono composti da materiali di dimensioni minime, che creano depositi spessi solamente qualche cm per ogni loro ondata.
Tutto si è svolse in due giornate, tenendo per buona la datazione classica, tra il 24 e il 25 agosto del 79 d.C.
Le fasi iniziali furono caratterizzate dalla formazione della colonna eruttiva alta fino a 30 km, con la caduta del materiale che colpì direttamente la città di Pompei risparmiando però Ercolano che si trovava sottovento durante l’eruzione.
Successivamente l’energia della colonna diminuì portando a creare i primi flussi piroclastici che iniziarono la loro corsa distruttiva.
Poi, dopo aver eruttato molti metri cubi di materiale la pressione nella camera magmatica diminuì facendo entrare in questo modo l’acqua all'interno, questo evento portò all'inizio dell’attività esplosiva e alla conseguente formazione dei base surge che uccideranno la maggior parte delle persone coinvolte nel disastro.
Queste tre tipologie di fenomeni (materiali di caduta dalla nube, flussi piroclastici e base surge) sono distinguibili tra loro nei depositi archeologici per mezzo della differente granulometria dei materiali che li compongono. Questa caratteristica è fondamentale perché permette di ricostruire le diverse fasi dell’eruzione e di evidenziare come le città siano state colpite in modo differente.
Ad esempio, a Pompei sono caduti circa 2,5 m di lapilli, mentre Ercolano trovandosi sottovento non ne è quasi stata colpita.
Differentemente, al momento del collasso della nube con la conseguente partenza prima dei gas e poi dei flussi piroclastici è stata Ercolano la prima ad essere colpita e di conseguenza gli abitanti della città sono stati i primi a morire.
I fuggiaschi
I defunti di Pompei, come abbiamo detto in precedenza vengono chiamati, dalla letteratura di settore e dagli specialisti, fuggiaschi; essi sono allo stesso tempo probabilmente “l’attrazione” più famosa e sconvolgente del sito archeologico, un aspetto tanto inquietante quanto surreale che riporta ad un momento immutabile del passato e che, forse, permette di riuscire a comprendere, almeno in parte, cos’hanno provato i cittadini di Pompei al momento del disastro.
In questo aspetto così triste e affascinante allo stesso tempo ci viene incontro la ricerca scientifica che ha visto come a Pompei vi risiedessero all'incirca dodicimila abitanti; data la dimensione del sito, alcune zone non sono ancora state scavate e sono state fatte quindi delle ipotesi statistiche grazie ai dati finora ottenuti.
Sono stati trovati i resti di circa 1047 persone, e per 103 di esse stati ottenuti i calchi (dati aggiornati al 2018).

L’ottenimento dei famosi calchi dei fuggiaschi è stato possibile grazie ai depositi dei base surge (quelli derivati dai gas incandescenti ad altissima velocità) e dei flussi piroclastici che si sono induriti e cementati dopo aver colpito la città e gli abitanti; successivamente a ciò, le parti molli dei corpi (come tessuti e muscoli) si sono decomposte e dei defunti non è sopravvissuto altro che lo scheletro.
A causa di questo evento è rimasta un’intercapedine che si riferisce ai tessuti molli, dovuta al fatto che la cenere ha aderito al volume del corpo prima che esso si decomponesse. Queste intercapedini preannunciano quindi la presenza dei corpi per mezzo di una cavità visibile nei depositi vulcanici.
I primi esperimenti per l’ottenimento dei calchi sono stati fatti nell’800, fase in cui veniva colato del gesso liquido per ottenere il riempimento della cavità per poi scavare attorno; ora, invece, si utilizzano delle resine plastiche più avanzate tecnologicamente che hanno un grado di restituzione e di precisione dei dettagli anatomici molto più elevato.
In definitiva, se non è presente l’intercapedine non vi è alcuna possibilità di ottenere il calco del corpo.
Siccome il materiale depositato a Pompei era soprattutto a grana fine (cenere fino a 2 mm di diametro e lapilli fino a 64 mm), in molti casi sono rimaste impresse anche la fisionomia del volto e le espressioni dei cittadini, oltre che i dettagli dei vestiti e delle calzature.
Inoltre, come detto in precedenza, le ossa si sono conservate nel vuoto lasciato dai corpi e rimanendo così all'interno dei calchi, per questo motivo nella maggior parte di essi si evidenziano le ossa del cranio e i denti.
La maggior parte di questi corpi si trovava a 2,5 m di altezza, all'interno del deposito formato dai gas incandescenti e dalla cenere, poiché al momento del loro arrivo (la vera causa dello sterminio) erano caduti sulla città già più di 2 metri di materiali eruttato dal Vesuvio che hanno iniziato a far crollare le prime strutture (le pomici, il materiale eruttivo preso singolarmente è piuttosto leggero in realtà).
Uno dei ritrovamenti più spettacolari per la ricerca scientifica è un gruppo di persone ritrovate nei pressi della casa del Criptoportico: essi visibilmente disorientati e in fuga, camminavano sopra lo strato di lapilli fino all'arrivo delle prime nubi incandescenti che li hanno tragicamente uccisi e così sepolti. I corpi sono stati trovati all'interno delle pomici, il materiale dalla granulometria maggiore, per cui non è stato possibile ricavarne il calco.
A differenza di Pompei, a Ercolano durante gli anni ’80 è stata scavata una zona che si affacciava alla spiaggia dove sono stati trovati una grande quantità di scheletri e un rinvenimento eccezionale: un grande pezzo di imbarcazione capovolto.
A Ercolano è impossibile ottenere dei calchi perché i depositi di cenere sono a contatto diretto con le ossa e non vi sono le intercapedini.
La particolarità di tutto questo, e la sua drammaticità, è legata intrinsecamente alle posture dei fuggiaschi, esse evidenziano una morte immediata legata al calore, le persone sono come sospese durante un’azione (circa il 70% dei calchi di Pompei) oppure sembra che dormano (più del 25%).

Altre persone, invece, hanno subito l’impatto dei flussi piroclastici, morendo quindi per cause “meccaniche” come il crollo degli edifici, ma queste ultime sono veramente in numero esiguo (circa il 2%).
La postura più rilevante per la ricerca (il 64% di quelli che presentano una posizione simile ad un’azione di vita cristallizzata, a cui è stato assegnato un nome, è quella del pugile poiché ne ricorda le movenze sul ring, in cui le braccia e i gomiti sono piegati verso l’alto.

In precedenza, si riteneva che questa posa fosse assunta per difesa, mentre ora, grazie alle ricerche bio-archeologiche si è visto che questa posizione è dovuta al fatto che nel caso il nostro corpo subisca l’esposizione a temperature di 200-300 gradi centigradi (o superiori) i tendini si contraggono violentemente e le braccia assumono una postura simile alla guardia dei pugili.
Con temperature al di sopra dei 200 gradi il rilassamento dei tendini e muscoli non avviene, per cui è impossibile spostare le persone da quella posizione, per far ciò bisognerebbe tagliarne i tendini, è per questo motivo che ancora dopo 2000 anni le ritroviamo in quella postura.
Anche le ossa evidenziano dei segni di termo-alterazione dovuti all'esposizione a temperature elevate, esse infatti mostrano delle differenze di colorazione a causa dell’esposizione a temperature elevatissime, passando dalla classica cromia delle ossa ad una colorazione tendente al giallo.
Grazie a questi studi in cui la biologia e la fisiologia sono state applicate alle analisi più prettamente archeologiche si è potuto far luce alle cause che hanno portato alla distruzione della città di Pompei e al suo seppellimento riuscendo finalmente a districarsi tra le innumerevoli versioni della vicenda che circolano sin dall'antichità, sia tra i documenti di chi ha assistito dal vivo all'eruzione e ne è sopravvissuto, che tra i testi e le note redatte dagli storiografi e dai biografi antichi.
Bibliografia
A. Dickmann, Pompei, 2007, il Mulino, Bologna, pp. 127.
Mastrolorenzo, P. Petrone, L. Pappalardo, F.M. Guarino, Lethal Thermal Impact at periphery of Pyroclastic Surges: Evidences at Pompeii, Plos One, 5, 2010, pp. 1-12.
Savio, Monete romane, 2014, Jouvence, Milano, pp. 337.
Cremaschi, Manuale di Geoarcheologia, 2000, Laterza, Bari, pp. 386.
Sitografia
Pompei, enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pompei/
https://www.pompei.it
CONCATTEDRALE DI RUVO DI PUGLIA
A cura di Michele Leuce
Oggi, come nel mio precedente articolo andrò a parlare di una cattedrale pugliese dedicata a Santa Maria Assunta. Come da titolo, parlo della Concattedrale collocata nella località Ruvo di Puglia.
Storia
L’edificio fu costruito tra il XII e il XIII secolo ed è uno dei più importanti esempi di romanico pugliese per via delle sue caratteristiche.
La chiesa è il fulcro del centro storico di Ruvo, inoltre, essendo stata sede della diocesi di Ruvo fino all’anno 1986, è connessa al palazzo vescovile.
Sulla costruzione della concattedrale ci sono diverse ipotesi, ma molto probabilmente la più veritiera è quella che vede Roberto II di Bassavilla, signore di Ruvo, insieme al Vescovo Daniele, a decidere di costruire una cattedrale a seguito delle invasioni Barbariche e degli eventi bellici del XII secolo che rasero al suolo la città. La chiesa ha una storia di continue modifiche e cambiamenti, già nel 1589 poteva contare dodici altari laterali (poi diventati quattordici). Nonostante l’alto numero di questi la prima cappella costruita si aggira intorno all’anno 1640 ed era dedicata al culto del Santissimo Sacramento, dove l’omonima confraternita si riuniva in preghiera ed a oggi non è più esistente. A questa cappella se ne aggiunse un’altra consacrata al culto di San Biagio e delle sue reliquie, infatti all’interno si venera un frammento del braccio di questo santo, racchiuso in un reliquiario a forma di braccio benedicente.
Nel XVII secolo la chiesa subì ulteriori contrasti a causa degli scontri avuti con il potere laico: sotto il dominio di Ettore Carafa, Duca di Andria e Conte della città di Ruvo fu abbattuto l’altare maggiore per sostituirlo con il trono dello stesso Conte. Fortunatamente nel 1697 fu costruito un nuovo altare e inoltre un ventennio dopo venne riedificato e ampliato il palazzo vescovile.
La cattedrale fu, nella prima metà del settecento, soggetta ad ulteriori cambiamenti: nel 1744 la facciata fu allungata di 2,40 metri per lato e pochi anno dopo (1749) si dotò del controsoffitto ligneo decorato dall’artista Luca Alvese. Inoltre presentava varie cappelle su entrambe le navate: sulla navata sinistra erano disposte le cappelle del coro di notte, del Crocifisso, del Santissimo Sacramento, di San Biagio e di San Lorenzo, mentre sulla destra furono costruite le cappelle dell'Addolorata, della Madonna di Costantinopoli, dei Santi Medici, di San Michele Arcangelo e della Madonna di Pompei.
Si ebbero ancora modifiche nel Novecento: Tra il 1901 e il 1925 fu costruito un nuovo ciborio sul modello di quello della Basilica di San Nicola a Bari e fu messa una vetrata policroma raffigurante l’Immacolata. Sempre nel 1925 fu riedificato l’Episcopio.
Furono eliminate tutte le cappelle, di cui l'ultima (quella del Santissimo Sacramento) solo nel 1935. La distruzione delle cappelle fu attuata (oltre che per motivi pratici) soprattutto per motivi ideologici: per preservare l’originaria veste romanica della cattedrale bisognava eliminare tutte le sovrapposizioni barocche (nel 1918 fu rimosso anche il controsoffitto decorato per gli stessi motivi).
Descrizione Esterno
La facciata, tipicamente romana, è a salienti dotata di tre portali: Il più grande è quello centrale ed è stato arricchito da bassorilievi.
Nell’arco esterno sono raffigurati Cristo affiancato da pellegrini, dalla Madonna e da San Giovanni Battista; questi ultimi sono affiancati da figure angeliche e dai dodici apostoli.
Nel secondo arco è centrale la figura dell’Agnus Dei (Agnello di Dio, simbolo dell’innocenza di Cristo), affiancato dai simboli dei quattro evangelisti; mentre nell’arco interno sono scolpiti due pavoni intenti a beccare un grappolo d’uva (simbolo dell’Eucarestia).
Il portale centrale è dotato di due colonnine sormontate da grifi che poggiano su leoni stilofori a loro volta sostenute da dei telamoni.
I due portali laterali sono invece più piccoli, con al di sopra un arco a sesto acuto.
Sulla facciata sono inoltre presenti archetti prensili con figure umane, zoomorfe e fitomorfe ed al centro si può vedere il grande rosone, cui al di sopra è possibile notare una figura, il “Sedente”, da taluni identificata in Roberto II di Bassavilla. Al culmine della facciata è invece posta la figura del Cristo Redentore che impugna una bandierina segnavento.
Il campanile fu costruito intorno all'anno 1000, prima della concattedrale, con funzione di torre difensiva e di vedetta tanto che da questa struttura era possibile tenere sotto controllo la pianura fino all'Adriatico. Inizialmente la torre era composta di soli tre piani, poi nel XVIII secolo furono aggiunti altri due piani copiando lo stile dei vani originari. La torre faceva quindi anticamente parte del sistema difensivo di Ruvo, per poi diventare campanile con l’edificazione della concattedrale.
Descrizione Interno
L’interno è suddiviso in tre navate che sfociano in tre absidi e in un transetto trasversale alle navate che segue la forma di una pianta a croce latina. La navata più grande è quella centrale ed è circondata in alto da un falso ballatoio che si poggia su due file di colonne, ognuna diversa dall’altra sia per caratteristiche che per provenienza. Le colonne di destra hanno un valore artistico aggiunto rispetto a quelle di sinistra, sono cruciformi e sopra vi sono rappresentate scene della vita di uomini e animali mitologici, su quelle di sinistra invece vi sono rappresentati motivi floreali.
La navata centrale culmina un fantastico ciborio realizzato nel XIX secolo su disegno dell’architetto Ettore Bernich (già famoso per aver realizzato l’eclettico Acquario Romano) e che si ispira a quello della basilica di San Nicola a Bari.
La navata centrale e il transetto sono coperti da una copertura a capriate, mentre le navate laterali da una volta a crociera.
Tesori e Opere d’arte
All’interno della Concattedrale vi sono numerose opere d’arte custodite, tra cui: la statua in legno policromo e intagliato di San Biagio, patrono della città; il reliquario dello stesso santo in argento; un affresco raffigurante la Vergine col Bambino e San Sebastiano risalente al XV secolo, la tavola firmata ZT (il Maestro ZT divenne uno dei protagonisti del revival neobizantino pugliese, che ne condizionò pesantemente lo stile e le iconografie) della Vergine di Costantinopoli; lo splendido crocifisso ligneo del XVI secolo; la statua in pietra del XVI secolo di San Lorenzo; l'affresco del XV secolo la Madonna in trono con il Bambino e il Martirio di S. Sebastiano; una tela della bottega di Marco Pino da Siena raffigurante l'Adorazione dei pastori; tracce di affreschi raffiguranti alcuni santi e la Madonna della misericordia.
Menzione importantissima è la statua argentea di San Rocco realizzata dal maestro napoletano Giuseppe Sammartino.
Sono parte della “collezione” anche numerosi pezzi d’argenteria e di manifattura tessile.
Ipogeo
Il patrimonio sotterraneo della cattedrale di Ruvo è rimasto nascosto per secoli fino al 1925, quando durante i lavori di ristrutturazione emersero alla luce alcune monofore. Tuttavia nel 1935 con l'abbattimento della cappella del Santissimo Sacramento occorse abbassare la quota di calpestio del transetto e delle navate. La nuova pavimentazione però si rivelava in continuazione umida e bagnata, così le indagini condotte tra il 1974 e il 1975 portarono alla scoperta del ricco sottosuolo. Nell’ipogeo furono trovate tombe riconducibili alla civiltà dei peuceti (e romani) che fa pensare che lo zona fosse adibita a necropoli.
Fotografie trovate in rete: tutti i diritti sono riservati agli autori.
Fonti:
“Storia della Cattedrale” , su cattedraleruvo.it , 2009.
“Sistema difensivo di Ruvo di Puglia”, su ruvosistemamuseale.it , 2009
Ferdinando Ughelli, Italia sacra, Venezia, Sebastiano Coleti, 1721.
L'ESTRO PARMENSE DI GIOVANNI LANFRANCO
A cura di Mirco Guarnieri
Giovanni Lanfranco nacque a Parma nel Gennaio del 1582. Divenne paggio del conte Orazio Scotti di Montalbo a Piacenza, ma con la scoperta del talento artistico del giovane Lanfranco il conte lo mise sotto gli insegnamenti di Agostino Carracci, che in quel momento si trovava a Parma al servizio di Ranuccio Farnese per la decorazione del Palazzo del Giardino. Assieme a Sisto Badalocchio rimase al servizio del Carracci fino al 1602, anno della sua morte, per poi dirigersi su indicazione di Ranuccio Farnese a Roma presso la bottega di Annibale Carracci, che stava realizzando gli affreschi del Palazzo di proprietà del fratello Odoardo Farnese. Tra l’arrivo a Roma e il 1610 il Lanfranco realizzò assieme agli altri pittori della bottega i riquadri di scene mitologiche sulle pareti della galleria quali “Arione sul Delfino”1, “Dedalo e Icaro”2, “Ercole e Prometeo”3 tra il 1604-05 e contemporaneamente nella cappella Herrera in San Giorgio degli Spagnoli dove secondo lo studioso Eric Shleiler, il pittore avrebbe messo mano alla lunetta raffigurante “l’Apparizione di San Diego sulla sua tomba”4. Negli ultimi due anni del primo decennio il Lanfranco lavora alla cappella di Sant’Andrea sono le direttive di Guido Reni nel 1608, nell’Oratorio di Sant’Andrea in San Gregorio al Celio nel 1609 dove realizzò le figure di San Gregorio e Santa Silvia, mentre insieme a Sisto Badalocchio produsse un volume di incisioni delle Logge di Raffaello nel 1610.

Il 1609 è l’anno della morte del maestro Annibale. Questo portò al ritorno del pittore nella città natale soggiornando presso il conte Orazio Scotti che gli portò numerose commissioni tra Piacenza e dintorni come il “l’Arcangelo Raffaele che sconfigge il demone”5 per la cappella in San Nazaro e San Celso (Museo Capodimonte, Napoli), la pala d’altare della “Crocifissione con i Santi Pietro e Paolo, la Maddalena e la Vergine” per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Porcigatone presso Borgo Val di Taro del 1610, mentre nel 1611 fece la decorazione, andata perduta, della cappella di San Luca per il Collegio dei Notai in Santa Maria delle Grazie di cui è ci giunta solo “la pala dedicata al Santo”6. L’anno seguente è quello che vide il ritorno del pittore a Roma dove vi rimase fino al 1631. Durante questo secondo soggiorno romano realizzò la pala d’altare della “Salvazione di un’anima”7 per una cappella in San Lorenzo a Piacenza (Museo Capodimonte, Napoli) in cui sono visibili elementi chiaroscurali che rimandano alla pittura di Caravaggio. Ancora più visibili sono nel dipinto “Sant’Agata visitata e curata da San Pietro”8 del 1613-14 (Galleria Nazionale, Parma).
Nel 1615 il pittore firmò un contratto con Asdrubale Mattei per dipingere le volte di tre camere dell’ala settentrionale del proprio palazzo: “Giuseppe e la moglie di Putifarre”9,“Giuseppe nella prigione spiega i sogni dei prigionieri”10 e “l’Elia sul carro di fuoco”, andato distrutto. Sempre quell'anno il Lanfranco ricevette due importantissime commissioni: la prima arrivò dal vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa, Alessandro Peretti Montalto, dove gli veniva chiesto di partecipare assieme a quasi tutti i pittori della bottega di Annibale Carracci alla realizzazione di un ciclo di undici quadri raffiguranti gli episodi della vita di Alessandro Magno, per ornare le pareti della villa del vice-cancelliere sull’Esquilino. Il Lanfranco realizzò “Alessandro malato mostra la lettera calunniosa al suo medico Filippo”11 e “Alessandro rifiuta l’acqua offertagli da un soldato”12 (Fondazione Cassa di risparmio Pietro Mondadori).
La successiva commissione portata a termine l’anno seguente fu anche la prima opera pubblica del Lanfranco a Roma, la decorazione della “cappella Bongiovanni in Sant’Agostino”13ab : nella cupola il pittore elaborò l’illusionismo caratteristico del Correggio in chiave annibalesca, riprese nuovamente l’elemento chiaroscurale del Merisi nelle due opere laterali cd, mentre la pala d’altare inizialmente non prevedendo la figura del Dio Padre13e (Louvre, Parigi) venne sostituita in quella attuale 13f. Sulla stessa scia stilistica in quegli anni abbiamo la “Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Bartolomeo”14 (Museo Capodimonte, Napoli) sempre nel 1616 e la pala raffigurante la “Vergine col Bambino in gloria tra i Santi Agostino, Borromeo e Caterina d'Alessandria”15 (San Pietro di Leonessa, Rieti) del 1630.
Giovanni Lanfranco si dedicò anche ai dipinti di piccolo formato adatti agli studioli, realizzando opere come “Davide che trascina la testa di Golia”16 (Fondazione Longhi, Firenze) per un membro della famiglia Gavotti, “l’Annunciazione della Vergine”17 per il cardinal Montalto (Hermitage, San Pietroburgo) e “l’Assunzione della Maddalena”18 (Puskin Museum, Mosca) tutte e tre realizzate tra il 1616-17 e legate dalla componente neoannibalesca.

L’enorme successo ottenuto dalla decorazione della cappella in Sant’Agostino attirò l’attenzione di personaggi importantissimi come ad esempio il cardinal Scipione Borghese, papa Paolo V e il cardinal Odoardo Farnese, per cui lavorò nel primo soggiorno romano.
Nel biennio 16-17 del Seicento troviamo il pittore parmense a realizzare il Fregio di una parete della sala Regia della cappella Paolina assieme a Carlo Saraceni e Agostino Tassi, facendogli guadagnare la decorazione pittorica della volta della loggia delle Benedizioni in San Pietro. La sfortuna volle che nel 1621 con la morte del papa, il progetto non proseguì e la loggia non fu dipinta.
Con l’arrivo di Gregorio XV, al Lanfranco vengono preferiti il Guercino e Domenichino, ma nonostante ciò negli anni 20 del Seicento realizzò gli affreschi per la “cappella Sacchetti”19abc in San Giovanni Battista dei Fiorentini (1622-23), per la “volta della loggia del primo piano”20 a Villa Borghese (1623-24) e per la “cupola”21 di Sant’Andrea della Valle (1625-27). In queste ultime due decorazioni si può notare come il Lanfranco rivolga il suo sguardo allo stile barocco.



A Gregorio XV succedette Urbano VIII e nel 1625 il pittore gli fece richiesta di ottenere l’incarico di dipingere la “Navicella” in San Pietro per sostituire la pala rovinata di Bernardo Castello e dopo la visione della cupola da parte del pontefice gli venne ufficializzato l’incarico. Nel 1628 l’affresco venne completato portandogli la nomina di Cavaliere all’ordine di Cristo da parte del papa. In questo affresco purtroppo frammentato, viene rappresentato il momento più alto dello stile pienamente barocco del pittore.
Prima di lasciare Roma nel 1634 alla volta di Napoli, Giovanni Lanfranco venne eletto principe dell’Accademia di San Luca nel 1631 e realizzò alcune pale d’altare come quella di Spoleto22 (1632-34), Perugia (1632), Augusta (1632) e Lucerna (1633).

Giunto a Napoli realizzò in poco più di un decennio gli affreschi per la cupola del Gesù Nuovo tra il 1634-36 (successivamente perduta), la “volta della navata maggiore”23 della Certosa di San Martino dal 1637-38, per gli “interni”24 abcdefg della chiesa dei Santi Apostoli tra il 1638-1641, per la “cupola”25 barocca della Reale cappella del Tesoro di San Gennaro tra il 1641-43 e il coro della Basilica della Santissima Annunziata Maggiore anch’esso andato perduto.


Tornato a Roma nel 1646, Giovanni Lanfranco realizzò le ultime due opere, l’affresco del catino absidale26, e dell’arco antistante26 nella chiesa dei barnabiti dei Santi Carlo e Biagio ai Catinati.
Secondo il Bellori l’affresco sarebbe stato inaugurato tra il 4 e 5 Novembre del 1647, poco tempo prima della morte del Lanfranco.

Sitografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-lanfranco_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1482246588114_08_-_Toesca_337.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/14703481.pdf
"LA MANO CHE CREA": MOSTRA SU UGO ZANNONI
Recensione mostra "La mano che crea" a cura di Mattia Tridello
Ugo Zannoni, 1836-1919;
Scultore, collezionista e mecenate;
“Sotto la man che crea
Non tremava il tuo giovine scalpello,
Quando t’apparve alla feconda idea
Tutto avvolto nel suo bruno mantello,
Il divino sembiante
Della grande e sdegnosa ombra di Dante?”
P. Antonibon, Dante scolpito da Ugo Zannoni, Verona 1865
Dante, con sguardo austero, occhi severi e compostezza monumentale, dall’alto del suo piedistallo, guarda da più di 150 anni l’inesorabile e continuo flusso di persone che transitano in Piazza dei Signori, nel luogo che, dal 1865, è diventato la sua sede (Fig. 1-1a). Portandosi la mano al mento, in atteggiamento pensoso, riflette. Sotto di lui, tra un vociferare continuo, espressioni incuriosite e volti di turisti lo ammirano, chi per immortalarlo in qualche foto ricordo, chi, invece, per riservargli una modesta e fuggitiva occhiata. L’Alighieri, tuttavia, continua nel fissare l’eternità, rimane staticamente nella sua posizione, ben consapevole del valore che essa assunse per l’affermazione patriottica di un paese, nell'affermazione di un artista giovanissimo che, a soli vent’anni, con mano vigorosa e forte lo scolpì nel marmo, lo impresse nella memoria dei veronesi che, resistendo all’invasore, videro in questo l’esecutore del più riuscito tributo al padre della lingua italiana. Risulta dunque veramente difficile trovare un artista come l’autore della statua, Ugo Zannoni, così in stretta simbiosi con la storia e l’evoluzione della propria città, capace di aver instaurato un legame forte tanto da farne un indissolubile caposaldo del sistema museale e espositivo veronese.
"La mano che crea": la mostra su Ugo Zannoni
La mostra "La mano che crea", che dal 27 giugno 2020 al 31 gennaio 2021 si apre alla Galleria d’Arte Moderna di Verona, si propone come un’eccezionale e straordinaria opportunità di riscoprire il lato meno noto e per tempo sottovalutato della fondamentale figura dello scultore, veronese d’origine ma milanese d’adozione. Zannoni, infatti, dopo i primi studi all’Accademia di Venezia, ben presto si trasferisce nel tumultuoso e dinamico clima della capitale del Regno Lombardo- Veneto, Milano. Ammesso all’Accademia di Brera egli iniziò a maturare un gusto decorativo inseribile nella cosiddetta “Scuola milanese”, figlio del suo tempo, l’artista si appropriò di uno stile ambivalente: realista nell’interpretazione dei monumenti civili ma incline a un naturalismo descrittivo di ispirazione neo-settecentesca nei soggetti di genere che componevano le sue collezioni private. Non stupisce dunque che le sue prime opere, stimolate dalla volontà di risvegliare la città natale dal torpore nel quale si era addormentata, ebbero notevole e precoce successo tanto da rinforzare, nel suo intimo più profondo, un sentimento municipalistico protettivo e affettuoso nei confronti della città di famiglia, un affetto unico che si tramutò in investimenti e generosi lasciti per il costruirsi di un’identità museale, di una realtà che ancora oggi esiste, il Museo Civico.
Storia della donazione artistica di Zannoni alla base de "La mano che crea"
Anche se, nella storia secolare di collezionisti e mecenati, Verona fu sempre ricca di donazioni che andavano a ingrandire le raccolte museali, nessuna di quest’ultime fu tanto cospicua e ampia come quella che, a diverse riprese, Zannoni generosamente lasciò ai posteri. Dopo un primo lascito di 35 sculture del suo atelier e ben 83 dipinti di autori principalmente lombardi, lo scultore, insieme all’avvocato Zenati, diede inizio a un grandioso progetto espositivo che prevedeva la riorganizzazione dei beni comunali e la creazione di un “sala risorgimentale” (in linea con l’illuminato mecenatismo altolocato ottocentesco) a Palazzo Pompei (all’epoca sede del Museo Civico) per ospitare l’ingente raccolta artistica messa a disposizione dai due donatori. Le sale, aperte il 1 Maggio 1908, riscossero immediato consenso anche dalle autorità civili il sindaco, Luigi Bellini Carnesali, si congratulò personalmente con Zannoni e i suoi colleghi per “il nobile amore e l’assidua opera” prestata per il riallestimento delle raccolte cittadine. La riconoscenza iniziale degli amministratori comunali, tuttavia, non fu sufficiente negli anni successivi ad assicurare la fortuna tanto sperata alle opere lasciate dallo scultore. Il motivo storiografico principale lo si può desumere dal fatto che Zannoni, come accennato in precedenza, apparteneva a una generazione di scultori italiani sottovalutata dalla critica filo-francese dell’epoca. Questa, prediligendo le nuove sperimentazioni plastiche di Rodin e Boccioni, finì per far oscurare le collezioni donate tanto che, arrivate nel 1916 al totale complessivo di all'incirca quattrocento e più beni, iniziarono ad essere parzialmente dimenticate e celate nei depositi. Gli unici pezzi che continuarono ad essere esposti permanentemente furono gli immancabili successi scultorei giovanili quali il modello in bronzo della statua di Dante e le graziose statuine dedicate al tema infantile. L’esposizione si pone quindi come la prima vera e concreta rivalutazione artistica dell’opera di Zannoni a livello sia personale che di commissione e donazione, si mostra al visitatore un affascinante retroscena sul gusto decorativo e collezionistico otto-novecentesco, dà modo di rileggere, nell'attualità moderna, il contributo fondamentale portato dall'artista nella concezione museale stessa, nell'anticipare e esprimere il ruolo, in primis educativo, che assume l’arte e la contemplazione della bellezza. Non a caso la mostra si arricchisce, proprio per tale motivo, di un’attività che non ha avuto precedenti così riusciti nella storia espositiva veronese, di un laboratorio formativo.
Quest’ultimo ha aperto le porte a studenti e professori delle realtà universitarie e accademiche cittadine permettendo loro di cimentarsi e essere coinvolti, accanto allo staff museale, nelle attività di cura delle collezioni, nella sperimentazione di ciò che avviene dietro le quinte, prima, durante e dopo l’apertura pubblica. Anche in questo non manca di certo l’influenza del protagonista dell’esposizione, Zanoni, infatti, sebbene fosse stato molte volte invitato a insegnare presso l’Accademia di Brera, tra il 1904 e il 1915, nell'ultimo periodo di vita, si dedicò con impegno e dedizione all'insegnamento in una scuola a portata di tutti, alla Scuola del Patronato operaio istituita dai padri Stimmatini di Verona. L’umanità autentica unita al messaggio educativo che l’artista voleva presente nelle sue raccolte senz'altro riecheggia egregiamente nelle tre sale della mostra "La mano che crea" e si fa ancor più presente nell'animo di coloro che sapranno gustarla col cuore, prima ancora che con gli occhi.
Il percorso espositivo: il laboratorio-mostra "La mano che crea"
Il laboratorio-mostra si svolge in sette tappe articolate tra la grande Sala orientale del Palazzo della Ragione, lo spazio antistante l’antica Cappella dei Notai e la Sala degli Scacchi.
Per il percorso sono state selezionate 83 opere d’arte delle 212 provenienti dalle donazioni disposte da Ugo Zannoni dal 1905 al 1919.
Ingresso all'esposizione. "La mano che crea"
L’ingresso alla mostra "La mano che crea" avviene tramite un locale voltato nel quale, per introdurre la figura di Ugo Zannoni e il tema del mecenatismo, sono esposti tre busti-ritratto: il primo (Fig. 2) , opera dei fratelli Carlo e Attilio Spazzi, ritrae Ugo Zannoni e fu donato da Achille Forti per l’inaugurazione, l’1 maggio 1908, delle nuove “Sale Zannoni” e “Sale d’arte moderna” del Museo Civico all’epoca nella sede di Palazzo Pompei citata in precedenza. Gli altri due busti presenti (Fig. 3) furono scolpiti in marmo da Zannoni su commissione del Comune di Verona, quale omaggio a Giulio Pompei e a Cesare Bernasconi, due dei protagonisti del primo periodo di incremento delle raccolte artistiche del Museo Civico.
La Sala orientale
Lo spazio complessivo della mostra "La mano che crea" si articola principalmente nella Sala orientale del Palazzo della Ragione. Il vasto ambiente, per l’occasione, risulta diviso, tramite pannelli mobili, in tre differenti sezioni, ciascuna con colori e allestimenti diversi pensati appositamente per rievocare, con l’ausilio di gigantografie di foto d’epoca, determinati luoghi cari e significativi alla figura di Zannoni.
SEZIONE 1, prima sala
La prima sezione della mostra, tramite la gigantografia di una foto d’epoca ritraente l’atelier dello scultore presso la Scuola di Plastica del Patronato operaio degli Stimmatini dove egli insegnò dal 1904 al 1915), mira a ricreare l’ambiente di lavoro e di esposizione delle opere, proprie o acquistate, dello scultore (Fig. 4). Ecco quindi che, insieme ai capolavori che lo resero celebre, come il modello bronzeo della statua di Dante (Fig. 5) o i busti di personaggi illustri del “Pantheon veronese” si susseguono alcune opere di gusto rinascimentale di proprietà di Zannoni e fonti di numerosi riferimenti stilistici, un esempio ne è il “Cristo uomo dei dolori” di Paolo Farinati (artista veronese attivo tra il 1524 e il 1606) (Fig. 6). Alla sinistra dell’entrata sono esposte, invece, raccolte dell’artista di epoca più recente, le statuine di vario genere realizzate da Alessandro Puttinati (Fig. 7) e il “Cesare Beccaria” di Giuseppe Grandi ne sono parte.

SEZIONE 2, seconda sala
La seconda sezione, con grafiche e colori diversi, cerca di riprodurre gli interni di una tipica casa borghese di fine Ottocento. Come è riscontrabile in foto o rappresentazioni d’epoca, le abitazioni del tempo non disponevano di veri e propri spazi dedicati esclusivamente all'esposizione dei quadri e delle statue di famiglia, perciò quest’ultimi venivano collocati negli ambienti di maggiore frequentazione quotidiana, si pensi alle sale da pranzo e ai salotti. Con questo intento si è ricreata un’ipotetica stanza nella quale sono presenti opere di diversi autori e tipologie, di proprietà di Zannoni, probabilmente esposte nella casa di quest’ultimo (Fig. 8a – 8b). Ad arricchire l’ambiente concorre una scrivania d’epoca che funge da supporto per alcune graziose statuette, come l’opera autografa dell’artista, la “Carità”(Fig. 9). A far immedesimare il visitatore sopraggiungono anche le dimensioni, minute e per lo più orizzontali, dei dipinti presenti: si veda, ad esempio, “Lezione a memoria” di Roberto Fontana (Fig.10).
SEZIONE 3, terza sala
Il 1 Maggio 1908 vennero ufficialmente inaugurate le due sale di ri-allestimento della collezione del Museo Civico, all'epoca nella sede di Palazzo Pompei. La terza e ultima sezione espositiva (Fig. 11) cerca, quindi, tramite la riproduzione di una gigantografia di una foto d’epoca scattata all'interno della “sala Zannoni”, di riprodurre il clima che respiravano i visitatori novecenteschi in quell'ambiente, circondati da opere notevoli, presenti ieri come oggi, nelle collezioni civiche (Fig. 12). Ne sono un esempio il “Ritratto di Ugo Zannoni” di Angelo Dall’Oca Bianca (Fig. 12, destra) oppure i gruppi statuari di genere rappresentanti figure sia a tutto tondo che mezzi busti di giovani e aggraziate spose, da notare la complicata ma magistrale lavorazione dei merletti e dei pizzi dei veli delle acconciature (Fig. 13). Un accurato e veramente apprezzabile studio grafico sull'aspetto delle originarie sale novecentesche ha influenzato l’allestimento dell’ultima sezione che, non a caso, presenta nella parte alta della parete alcuni fregi a motivi vegetali simili a quelli presenti in prossimità del soffitto negli ambienti di Palazzo Pompei (Fig. 14).
Termine della visita
Terminata la visita dell’ultima sezione della mostra "La mano che crea", seguendo le indicazioni per l’uscita, si viene introdotti in un ampio ambiente che ospita, oltre a filmati che testimoniano la presenza viva e attuale del collezionismo e del relativo mecenatismo, una suggestiva linea del tempo illustrata (Fig. 15) realizzata, nel corso dell’esperienza laboratoriale, dagli studenti della realtà universitaria e dell’Accademia di Belle Arti di Verona. La rappresentazione, ripercorrendo le tappe fondamentali e principali della secolare storia collezionistica veronese, dal ‘700 fino al ‘900 , conclude cronologicamente l’itinerario artistico nel Palazzo della Ragione.

Giunge alla fine un viaggio retrospettivo e veramente inedito nella figura di Ugo Zannoni, nell'immagine virtuosa e generosa di uno dei principali fautori di un patrimonio artistico unico, di un corpus pittorico e scultoreo che trae le sue radici nell'incondizionato amore dell’artista alla sua città natale, alla terra che ne vide l’evoluzione. Dai primi successi all'ardore patriottico, dalle donazioni alla riorganizzazione del Museo Civico, dal giovane irrefrenabile scultore alla mano paziente e abile nell'allestire spazi d’arte, nel creare luoghi dell’animo in cui piantare i semi dell’amore verso il sentimento del “bello”. Zannoni ha lanciato un seme che ora, germogliando, viene riscoperto, torna alla luce per essere di nuovo da noi tutti apprezzato, alimentato e tramandato alle generazioni future.
Informazioni per la visita
Mostra "La mano che crea", dal 27 giugno 2020 al 31 gennaio 2021
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti - Palazzo della Ragione
Cortile Mercato Vecchio 6 - Verona
Tel. 045 8001903
www.gam.comune.verona.it
Orario
Da martedì a domenica 11 -17
Lunedì chiuso
Ultimo ingresso ore 16.15
SABATO 27 e DOMENICA 28 giugno 2020 INGRESSO SPECIALE 1 euro
BIGLIETTERIA
La biglietteria presso la Galleria d’Arte Moderna è attiva.
Il biglietto può essere acquistato anche online su museiverona.com, prenotando anche l'orario di ingresso.
Biglietto Galleria d’Arte Moderna
Intero: 4,00 €
Ridotto: 2,5 €
scolaresche: € 1,00
Hanno diritto al biglietto ridotto: gruppi superiori a 15 persone; ragazzi dagli 8 ai 14 anni; studenti dai 14 ai 30 anni (con tessera studenti o libretto universitario); adulti oltre i 60 anni di età; possessori delle apposite convenzioni.
Ingresso gratuito: bambini fino a 7 anni, residenti nel Comune di Verona con più di 65 anni, portatori di handicap e accompagnatori, insegnanti accompagnatori di scolaresche (due per ogni classe indipendentemente dal numero di studenti).
Biglietto cumulativo Galleria d’Arte Moderna Achille Forti + Torre dei Lamberti
Intero: 8,00 €
Ridotto: 5,00€
scolaresche: € 1,00
Hanno diritto al ridotto: gruppi superiori a 15 persone, studenti dai 14 ai 30 anni (con tessera studenti o libretto universitario), adulti oltre i 60 anni di età, possessori delle apposite convenzioni ingresso gratuito: anziani (over 65) residenti nel Comune di Verona, portatori di handicap e loro accompagnatori, bambini fino a 7 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche (due per ogni classe indipendentemente dal numero di studenti) con HYPERLINK "https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38678"VeronaCard
Le semplici regole per una buona visita sono disponibili sul sito museicivici.comune.verona.it
Bookshop
Il bookshop del museo è fornito di pubblicazioni e oggetti di design
Servizio di biglietteria e bookshop
Rear soc. coop.
Catalogo
Panini Editore
LA CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA AL FORO
A cura di Maria Anna Chiatti
La chiesa dei Santi Luca e Martina è la sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, insieme al Palazzo Carpegna. Si trova in un punto fortemente suggestivo del centro di Roma, di fronte all’arco trionfale di Settimio Severo, ai piedi del Campidoglio (fig. 1). L’edificio sacro fu costruito ex novo sul sito del titolo primitivo di Santa Martina, concesso nel 1588 da papa Sisto V all' (ancora) Università dei Pittori di San Luca: il passaggio ufficiale da Universitas ad Accademia avvenne infatti nel 1593, con la simbolica fondazione ad opera di Federico Zuccari (1540 - 1609) dell’«Accademia de i Pittori e Scultori di Roma», della quale divenne il primo principe. Soltanto durante il principato di Pietro da Cortona (1596 - 1669), dopo il 1634, gli Architetti entrarono a far parte dell’Accademia al pari di Pittori e Scultori.

Sebbene la chiesa fosse stata oggetto di lavori e progetti di adattamento e parziale ricostruzione fin dall’ultimo decennio del Cinquecento, redatti probabilmente da Francesco da Volterra (1535 - 1594) e da Ottaviano Mascherino (1536 - 1606), il suo integrale rifacimento fu avviato solo nel 1635, grazie al rinvenimento delle reliquie di Santa Martina e all’interessamento del principe dell'Accademia, Pietro da Cortona, che ne progettò l’attuale veste architettonica. I lavori, più volte interrotti, possono considerarsi conclusi entro il 1679; tra il secolo XVIII e il XIX veniva compiuta la sistemazione degli altari e la decorazione interna. In seguito ai lavori per l’apertura, nel 1932, di via dell’Impero, la chiesa rimase unica superstite degli edifici che insistevano sul medesimo isolato e, su progetto di Gustavo Giovannoni (1873 - 1947) ne vennero ridefiniti i fronti laterale a nord e absidale. La demolizione della sede accademica, addossata e contigua alla chiesa, sancì il definitivo distacco dell’Accademia dall'edificio religioso che l’aveva ospitata per oltre tre secoli.
L’accesso alla chiesa avviene tramite l’articolata facciata principale, che fino alle recenti sistemazioni tardo novecentesche costituiva il fondale di via della Consolazione.
San Luca, la chiesa superiore
Maestro della pittura - si ricordi il meraviglioso esempio del Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo Barberini - anche sul piano della progettazione architettonica Pietro da Cortona sviluppò una interpretazione dello spazio del tutto personale. Pur partendo dalla costante e libera riproposizione degli ordini classici, egli attinse anche alle esperienze bramantesche e palladiane, modellando plasticamente i propri edifici in modo scenografico. Sin dai suoi esordi in campo architettonico, mostrò infatti la capacità di unire la tradizione classica e rinascimentale, manipolandole con una sensibilità scenografica in parte riconducibile alla lezione del manierismo fiorentino, in parte allo studio dell’architettura romano - ellenistica.
Tutto ciò è evidente nella chiesa presa oggi in considerazione, che resta uno dei primi e più completi esempi del Barocco romano. Come già detto, la costruzione sorge ai piedi del Campidoglio, tra il Foro di Cesare e l’antica Curia, in luogo della chiesetta medievale di Santa Martina.
Pietro da Cortona cominciò con la ricostruzione (a proprie spese) della cripta, dopo aver ottenuto da papa Urbano VIII il privilegio di potervi erigere la propria cappella funeraria; d’altro canto aveva già disegnato un progetto completo per la chiesa, e la pianta originariamente prescelta fu quella circolare, in omaggio alla tipologia del martýrion. Tuttavia, dopo il ritrovamento delle ossa di Santa Martina, nel corso degli scavi della cripta nell'ottobre 1634, l'importanza dell'impresa aumentò considerevolmente e l’architetto cortonese preferì optare per una pianta a croce greca (fig. 2), nella quale è evidente il ritorno agli schemi del rinascimento toscano anche se - ed è qui che risiede la genialità del progetto - egli ne reinventò completamente la distribuzione degli spazi: il braccio longitudinale della croce è leggermente più lungo di quello trasversale, sebbene entrambi terminino con absidi semiellittiche, le cui morbide curve annullano la percezione di qualsiasi asimmetria dimensionale.
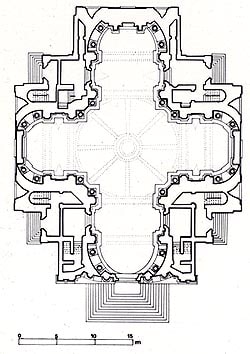
Le pareti interne si snodano lungo il perimetro della croce con un suggestivo alternarsi di rientranze e aggetti scanditi dall'ininterrotto succedersi di colonne, nicchie e paraste ,culminante nell'addensarsi di un complesso sistema di colonne e pilastri ionici binati (figg. 3 - 6), agli angoli d’incrocio dei due bracci. In questo modo la presenza degli spigoli viene di fatto annullata e la sensazione che ne deriva è quella di uno spazio avvolgente che, modellandosi in modo quasi scultoreo, grazie anche all'assoluta prevalenza del colore bianco, suggerisce il senso di uno scenografico colonnato circolare.
Santa Martina, la chiesa inferiore
La chiesa inferiore, riccamente decorata da marmi policromi, è dedicata alla santa martire Martina, della quale sono custodite le reliquie nell'altare maggiore posto al centro della cripta (fig. 7): di forma rettangolare, questa è coperta da una cupola schiacciata a lacunari (fig. 8) sostenuta da colonne angolari. Due cappelle di tipo catacombale si aprono ai lati della cappella centrale, e altre strutture analoghe trovano posto sullo stesso livello inferiore (fig. 9).

Per disposizione testamentaria di Pietro da Cortona, l’amministrazione della chiesa inferiore di Santa Martina venne affidata dopo la sua morte al Conservatorio di Sant'Eufemia, che ne è attualmente proprietario.
La facciata della chiesa dei Santi Luca e Martina
La stessa logica di modellazione delle strutture murarie attraverso lo spregiudicato impiego dell’ordine architettonico si riscontra anche negli esterni e, in modo spettacolare soprattutto nella facciata, rivolta a Sud (fig. 10). Questa, a spiccato sviluppo verticale, è suddivisa in due livelli da una massiccia trabeazione aggettante, che svolge anche la funzione decorativa di marcapiano. La superficie della muratura, a differenza di ciò che avviene in corrispondenza delle altre tre absidi, le quali esternamente presentano pareti piane e squadrate, risulta qui convessa. In questo modo la forma interna trova un immediato riflesso anche all'esterno, dove l’articolato alternarsi di semi-colonne e paraste a coppie con capitelli ionici quasi anticipa al visitatore le soluzioni che potrà trovare all'interno.

L’andamento curvilineo della facciata arginato ai lati da coppie di pilastri sporgenti prosegue l’audace sperimentazione di forme, avviata da Pietro nella perduta Villa del Pigneto dei marchesi Sacchetti. Di fatto questa è la prima facciata decisamente barocca, nata parallelamente alle prime ricerche di Francesco Borromini (1599 - 1667) sul medesimo tema (la facciata dell'Oratorio di San Filippo Neri risale più o meno agli stessi anni). La magnificenza con cui sono state trattate le superfici, fortemente strutturate in un plastico succedersi di colonne incassate e pilastri aggettanti, riecheggia la lezione di Michelangelo senza però escludere accentuazioni decorative e imprevisti accostamenti di linee curve e spezzate che si fanno particolarmente apprezzare nelle capricciose invenzioni sia per l’interno (fig. 11) che per l’esterno della cupola a pianta circolare, la cui fantasiosa tipologia deriva dalla sovrapposizione di due ipotesi costruttive apparentemente opposte: da un lato la calotta a lacunari del Pantheon, dall'altro la struttura con costolonature rilevate di San Pietro. L’effetto decorativo che ne consegue è di straordinario impatto, in quanto il complicato arabesco di cassettoni ottagonali e nervature, valorizzato in toto dagli otto finestroni luciferi del tamburo, conferisce all'intradosso un profuso senso di spazialità dilatata, del tutto assimilabile agli effetti pittorici di sfondamento prospettico dei quali Pietro da Cortona era maestro.

Bibliografia
Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell’arte, Vol. 2, Zanichelli, Bologna 2004
Sitografia
Sito web dell’Accademia di San Luca al link: https://www.accademiasanluca.eu/it/accademia/sede/la_chiesa_dei_santi_luca_e_martina
Sito web del Dizionario Biografico degli Italiani, voce Pietro Berrettini, al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-berrettini_%28Dizionario-Biografico%29/
IL CROCIFISSO DEL CONCILIO A TRENTO
A cura di Alessia Zeni
Il visitatore che si reca nel Duomo di Trento, tra le opere d’arte da vedere, dovrebbe annoverare il Crocifisso del Concilio, così chiamato perché sotto di esso furono firmati i decreti conclusivi del Concilio di Trento (1545-1563). Il Crocifisso è conservato nella Cappella Alberti costruita nel 1682-1687, sulla parete sud della cattedrale, per volere del principe vescovo di Trento, Francesco Alberti Poja (1677-1689), come luogo della sua sepoltura e conservazione della reliquia. E’ un'opera esemplare nel panorama artistico trentino, esempio di arte regionale molto spesso influenzata dalla scuola tedesca d'Oltralpe.

Il vescovo Alberti Poja fece costruire una cappella a pianta quadrata con tamburo ottagonale, cupola con lanterna e una decorazione pittorica e architettonica che doveva esaltare il Crocifisso del Concilio di Trento. La cappella venne realizzata nello stile barocco dell’epoca che tendeva al meraviglioso e allo sbalorditivo con pitture di Giuseppe Alberti (1640-1716), statue ed elementi plastici dello scultore trentino Paul Strudel (1648-1708) e stucchi di Girolamo Aliprandi della Valle d’Intelvi. Purtroppo molte di queste decorazioni sono state rimosse nel restauro del 1843-1845 per smorzare l’aspetto vistosamente barocco della cappella, probabilmente poco apprezzato dalla curia vescovile dell’epoca. Per fortuna gli stucchi che ornavano la cappella non sono andati tutti persi, alcuni di questi oggi decorano l’altare che contiene il Complesso scultoreo del Crocifisso.
La decorazione pittorica di Giuseppe Alberti prevedeva otto Episodi Biblici affrescati nella cupola, scelti per le loro connessioni con il tema della Crocifissione e della salvezza; a questi fanno seguito, più in basso, sulle pareti del tamburo, cinque Scene della Passione e, nei pennacchi, la raffigurazione allegorica di Quattro Virtù, le virtù esercitate da Cristo nel suo sacrificio. A questo tema si legano le rappresentazione delle tele laterali della cappella che raffigurano l’Adorazione dei pastori e la Resurrezione, opere di pittura barocca del bavarese Carlo Loth. Entro l’altare, infine, il rilievo di Adamo ed Eva davanti all’Albero del bene e del male che allude al Peccato originale (la causa del sacrificio di Cristo), le statue della Maddalena e della Veronica (oggi sistemate davanti all'ingresso della cappella) nonché le rappresentazioni dell’Arma Christi che evocano in termini diretti la Passione.

Questo complesso programma iconografico è stato pensato per esaltare la Crocifissione del Concilio di Trento, un’opera imponente con i suoi 218 cm di altezza, e dalla forte drammaticità, tanto da poterla ritenere tra le più tragiche rappresentazioni della morte di Cristo in croce. La scultura è di un artista tedesco, Sixtus Frei da Norimberga, che realizzò la scultura dopo il 1511, quando arrivò nel capoluogo trentino, in legno dipinto di stile tardogotico, dove ogni dettaglio è stato studiato per trasmettere il dolore di Cristo in croce e la tristezza dei due dolenti, Maria Addolorata e San Giovanni apostolo. Il Cristo con i capelli che cadono in disordine, le sopracciglia che si inarcano sulla fronte corrugata, gli occhi che fuoriescono dalle occhiaie incavate e la bocca semi aperta accentuano la sofferenza del figlio di Dio. Una sofferenza che viene amplificata dall'ossatura della cassa toracica, dove si intravedono le costole, da una ferita che mostra il sangue abbondante e dai chiodi che fissano il corpo alla croce. I due dolenti, Maria e Giovanni, sono raffigurati in ricchi panneggi ed entrambi evitano di guardare il Crocefisso, come a voler rifuggire dal guardare lo spettacolo drammatico del Cristo morente.
Il Crocifisso del Concilio è inserito in una delle opere più belle del Duomo di Trento, un altare realizzato in pietra e marmo con sculture e decorazioni dalla forte carica simbolica (figura 1). In primis i due Angeli di Paul Strudel sistemati sul timpano spezzato dell’altare e scolpiti in ginocchio, in morbidi panneggi, che tengono la lancia con cui venne trafitto il costato di Cristo, e la spugna, con cui i soldati gli diedero da bere aceto. Gli Angioletti esultanti che chiudono in alto l’altare, sorreggono uno striscione marmoreo che riporta la scritta: “Unde mors oriebatur inde vita resurgit” ovvero “Dalla morte è venuta la vita” (figura 1).
Inserita tra le colonne dell’altare vi è una delle sculture più belle della cappella, l’Arma Christi di Giuseppe Aliprandi, ovvero l’insieme dei simboli che si riferiscono alla Passione di Gesù. Tra le colonne di sinistra troviamo gli elementi che ricordano la notte in cui Cristo è stato tradito dal discepolo Giuda: il gallo, la sacca dei denari, una fiaccola, una coppa, un elmo, il guanto di un soldato, un pugnale, una lanterna, una veste e una spada. Tra le colonne di destra gli oggetti che ricordano la condanna, le torture e la crocifissione: alcuni flagelli, una brocca, uno scudo, dei fastelli di verghe, l’iscrizione INRI, un’ascia, un martello e la veste coi dadi. Infine inquadra l’edicola della Crocifissione uno straordinario fregio in pietra scolpito da Paul Strudel con l’intenzione di alludere all'albero da cui fu ricavato il legno della croce; l’artista scolpisce un tronco ricoperto di foglie e in alto lo conclude con una corona di spine (figura 3).
Chiude il tutto, nel timpano spezzato dell’altare, la scultura di Adamo ed Eva davanti all’albero del Bene e del Male che rappresenta l’albero del Paradiso terrestre e il peccato dei progenitori vinto da Gesù che morì sulla croce.

IL CASTELLO DELLA PIETRA
A cura di Simone Rivara
Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.
In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.
Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).
Storia del castello della Pietra
Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.
Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).
In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.
Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.
Storia di un restauro
Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.
Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).
Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.
I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).
Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.
Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:
Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.
(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)
Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.
La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.
Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.
Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.
- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -
Bibliografia
PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.
PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.
Sitografia
http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214
L'ICONA DELLA MADONNA DEL PILERIO
A cura di Antonio Marchianò
Il culto della Madonna del Pilerio
L’icona della Madonna del Pilerio attualmente custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è un pregevole dipinto su tavola risalente al XII sec. voluta dall'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo per favorire l'afflusso dei pellegrini. Il culto cattolico della Madonna del Pilerio risale all'anno 1576, quando una devastante epidemia di peste si accanì sulla città di Cosenza facendo numerose vittime. Secondo la tradizione cattolica la popolazione ormai allo stremo, visti gli infruttuosi tentativi umani di arginare l'epidemia, si rivolse a Dio. Si narra che un devoto, che pregava dinanzi all'antica icona della Vergine Maria posta all'interno del Duomo cittadino, si accorse che sul viso della Madonna si era formato un bubbone di peste. Fu allertato il Vicario generale dell'epoca, si sparse immediatamente la notizia, e una grande folla si recò ad ammirare coi propri occhi lo strano evento, che venne interpretato come volontà della Vergine di accollarsi la malattia per liberare la popolazione. La regressione della peste nella città, che avvenne nei mesi successivi, venne interpretata come un vero e proprio miracolo. A seguito dell'evento, la Madonna del Pilerio venne eletta a Patrona Protettrice di Cosenza. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi, e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.
I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603 l'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo, per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse l'icona dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore, e infine, nel 1607, nella cappella appositamente costruita e dedicata alla Vergine, dove ancora oggi si venera. Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'Arc. Mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio come Regina e Patrona della città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quell'occasione si constatò un altro segno sul viso dell'immagine della Madonna: furono infatti notate delle screpolature, che poi scomparvero ma non del tutto, una volta passato il pericolo. Il 6 luglio 1798 si stabilì la celebrazione della sua festa, il giorno 8 settembre di ogni anno, per la sua Natività. Il 12 giugno 1836 l'Arc. Mons. Lorenzo Puntillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con corone d'oro e gemme di grande valore. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l'11 gennaio 1855 ottennero, dall'autorità ecclesiastica l'istituzione di una seconda festa, detta "del patrocinio", in onore della Vergine da celebrarsi ogni anno, il 12 febbraio. Nel 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal capitolo Vaticano e celebrata dall'Arc. Mons. Trussoni (1912-1933). Durante la seconda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due spaventosi bombardamenti che decimarono quasi la città: il 12 aprile e il 28 agosto 1943. Per iniziativa dell'Arc. Aniello Calcara (1941-1961) il 6 settembre 1943 il quadro della Madonna fu temporaneamente trasferito nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta con l'intento di proteggerlo. L'anno 1948 fu caratterizzato dalla "Peregrinatio Mariae" voluta da Calcara come preparazione al Congresso Mariano programmato per il 1951. Il 20 febbraio nuovamente ci fu a Cosenza un violento terremoto. Anche in questa occasione i cosentini si affidarono alla protezione della Madonna del Pilerio, e chiesero e ottennero da Achille Lauro (amministratore apostolico dell'Arcidiocesi) una processione. Il 10 maggio 1981 l'Arc. Dino Trabalzini elevò a Santuario della Vergine SS. del Pilerio il monumentale Duomo di Cosenza. Il 6 ottobre 1984 avvenne la storica visita alla Madonna del Pilerio e al Duomo da parte di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, la cui devozione filiale alla Madonna contraddistinse il suo intero pontificato. Il 10 ottobre 1988 Mons. Dino Trabalzini, in chiusura dei festeggiamenti per l'anno Mariano, proclamò la Madonna del Pilerio Patrona Principale dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e ne confermò il titolo di "Patrona della Città di Cosenza".
L'icona della Madonna del Pilerio: descrizione
L’icona misura 95 x 65 cm ed è stata eseguita in ambito mediterraneo occidentale; grazie alle sue caratteristiche iconografiche è definita “bizantina”. La tavola su cui è rappresentata la Vergine che allatta il Bambino ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti, ma anche danneggiamenti, fino ad essere stata completamente ridipinta. Solo con i restauri voluti dall'arcivescovo Mons. Enea Selis nel 1976-77 ed eseguiti presso la Sovrintendenza per i Beni culturali è stata ripristinata la bellezza originale, che ha permesso una lettura approfondita della immagine dipinta sul legno. L’icona infatti fino ad allora era considerata di scarso valore artistico, e solo una mera riproduzione di una più antica icona medievale. Secondo la Di Dario Guida, l’icona sembra essere stata eseguita durante l’ultimo scorcio della dominazione Sveva. Risulta come uno dei prodotti artistici più rilevanti di un vasto movimento artistico e culturale che subì sia gli influssi del “bizantinismo aulico delle opere messinesi del XIII secolo, sia le affinità delle ricerche plastiche perseguite dai maestri toscani pre-cimabueschi” L’icona si inserisce, inoltre, in una linea che unisce, dal punto di vista artistico, Monreale, Messina e la Campania.
La figura della Vergine
Partendo dalla figura della Vergine rappresentata possiamo affermare, confortati da autorevoli studi, che l’immagine è la sintesi tra una Galaktotrophousa (Colei che dona il latte) e la Kikkotissa (Vergine dal rosso manto). I due particolari pittorici relativi all'allattamento del Divin Bambino e del Maforiuòn (manto rosso) emergono nella loro immediatezza appena ci si accosta all'icona.
Il titolo di Pilerio, chiaramente postumo alla sua realizzazione, offre diverse interpretazioni, alcune anche apparentemente contrastanti, ma tutte permettono di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di tipo teologico, devozionale e pastorale date all'icona. La più tradizionale interpretazione del titolo è quella di Pilastro. Essa fa letteralmente riferimento alla collocazione originaria dell'icona, che si trovava collocata su una colonna all'interno della chiesa Cattedrale. Questo titolo potrebbe risalire proprio al periodo di dominazione spagnola o comunque all'epoca del miracolo della peste nel 1576, epoca nella quale l’influenza della pietas spagnola potrebbe aver portato a Cosenza la devozione per la Vergine del Pilar, anch'essa collocata su di una colonna. Testimonianze di questa influenza sono ancora presenti, ad esempio, nell'America latina, dove forte fu la dominazione spagnola. Un altro dato di cui tener conto è la certa influenza bizantina dovuta all'appartenenza della Città all’Eparchia greca fin dal IV secolo e della vicinanza con Rossano. Nella tradizione e nella liturgia bizantina è uso collocare la Vergine proprio alla porta del Tempio e nei punti strategici delle Città come atto di affidamento alla “Custode” del popolo di Dio (dal greco puloròs = custode della porta).
L’icona è avvolta da una luce tutta particolare che emerge dallo sfondo oro che simboleggia la gloria di Dio che tutto abbraccia. La grazia trasfigura la creatura nella quale “abita l’Altissimo”. Tutte le icone, ma particolarmente quelle della Madre di Dio, sono accompagnate dall'oro che indica il progetto e l’iniziativa di Dio, la gloria scende e prende possesso della tenda. Anche il rosso del velo che scende dal capo e il porpora dell’abito di cui Maria è rivestita sono simboli della divinità che “avvolge” la giovane di Nazaret e ne coinvolge mente e cuore. Il colore porpora dell’abito richiama anche la dimensione sacerdotale e regale ma soprattutto la “potenza dell’Altissimo” di cui l’Angelo annunziante le parla quando le propone il grande progetto della salvezza e della maternità. Il velo rosso che scende sulla spalla vuole significare che la Vergine Maria è stata “avvolta” dall'alto e ricoperta dalla grazia. Il marrone della veste della vergine è richiamo della sua umanità, mentre l’altra parte di manto di colore blu che avvolge la donna, ed avvolge anche gli abiti, indica il privilegiato rapporto con Dio di questa creatura. Base di ogni colore è il bianco che in tutta la tavola esprime la purezza, l’immacolato concepimento della Vergine. Esso si intravede sulla fronte, nella manica del braccio sinistro ed è l’abito che ella indossa sotto tutti gli altri. Le tre stelle, secondo l’iconografia classica bizantina, sono collocate una sulla fronte e due ai lati sulle spalle. Esse indicano che Maria è inabitata dalla Trinità ma anche la sua Verginità prima, durante e dopo il parto. I medaglioni dorati intorno al capo della Vergine sono undici. Rappresentano la Chiesa Apostolica senza l’apostolo Giuda che aveva tradito il Signore. Questo particolare stellario indica Maria presente nel Cenacolo di Gerusalemme, accanto agli Apostoli, proprio nei giorni e nelle ore della Pasqua fino alla Pentecoste. Le scritte in latino (MR e DOMINI) collocate rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine come prescritto dal Concilio di Nicea (787d.C) indicano la maternità divina di Maria. L’aureola sul capo del Divino Bambino contrassegnato dalla croce è un chiaro richiamo alla Passione di Cristo e al suo regnare glorioso. Il mistero dell’Incarnazione infatti è strettamente collegato con quello della Redenzione. Un ultimo segno che appare sulla tavola è la macchia scura sul volto della Vergine. È il segno della peste di cui Maria si è caricata per liberare miracolosamente la città di Cosenza afflitta dal terribile morbo e di cui storia e devozione popolare sono ancora testimoni. La Vergine Maria regge il Bambino tra le braccia e Gesù è seduto delicatamente sulla mano destra; essa diventa per lui quasi un trono da cui regna. Un drappo rosso posto tra le mani della Madonna richiama la sua signoria, la sua potestà regale e sacerdotale, la sua divinità. Non è escluso anche il richiamo alla Passione. Gesù che prende il latte dalla mammella diventa un particolare iconografico molto evidente: c’è una stretta tensione tra Cristo che è capo della Chiesa e il suo corpo mistico, di cui Maria ne è icona perfetta. Alcuni studiosi vedono proprio nella posizione del collo piegata verso il Bambino questa strettissima dipendenza e questo stretto rapporto tra Gesù e Maria, tra Cristo e la Chiesa. L’iconografia del seno si chiarisce ancora di più se la Vergine è colta nella dimensione di nutrice dei figli (Colei che nutre, imbandisce il banchetto, la mensa) fino a diventare, come la invoca la Chiesa ortodossa, Trapeza, evidente richiamo alla mensa eucaristica. Il Bambino è rappresentato con due addomi, strettamente legati da una fascia rossa intrecciata, ad indicare che le due nature umana e divina che sono unite in Cristo. Nella piccola fascia rossa intrecciata alcuni hanno intravisto anche un prolungamento del cordone ombelicale che unisce il figlio (divino) alla Vergine (madre) per esprimere visivamente il titolo di Madre di Dio (Theotòkos) inciso sulla tavola. Copre il Bambino un trasparente velo bianco che ricorda la divina purezza di Cristo agnello senza macchia che toglie i peccati del mondo e riscatta con l’effusione del suo sangue l’intera umanità dalla schiavitù, dai peccati e dalla morte. La Vergine come in ogni antica icona indica con la mano sinistra il figlio, si fa Odigitria (indica la Via) per tutti coloro che guardano la sua immagine e che potrebbero cadere nella tentazione di fermare lo sguardo su di lei. Le dita delle mani indicano anche alcune verità di fede: le tre dita della mano destra richiamano il mistero trinitario e ancora il parto verginale di Maria toccata dal mistero dell’Incarnazione; le due dita della mano sinistra invece indicano la doppia natura umana e divina di Cristo.
Bibliografia
Di Dario Guida M. Pia, Itinerario dell’arte dai Bizantini agli Svevi, in “Itinerari per la Calabria”, ed. l’Espresso, Roma, 1983, p.157.
Di Dario Guida M. P., Cultura artistica della Calabria medievale, di Mauro Edizioni, 1978.
Frangipane A., Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II – Calabria, Roma 1933, p. 121.
Leone G., Icone della “Theotokos” in Calabria, Ed. Vivarium 1990
Leone G., Icone della “Teotokos” in Calabria, in “Concilio Niceno II e l’iconografia mariana in Calabria”, atti del convegno, Cz, 1987, a cura di Squillace M., Edizioni Vivarium, Catanzaro, 1990, pp.119 e ss.
Napolillo V., Storia e fede a Cosenza, la Madonna del Pilerio, Edizioni Santelli, Cosenza, 2002, p.13.
Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus, dogma dell’Immacolata, 8 dicembre 1854.
Tuoto G., La Madonna del Pilerio, Leggenda, Cosenza 2001, p. 32.
Vitari S., Il Duomo di Cosenza, in Bilotto L., Il Duomo di Cosenza, Effesette, Cosenza, 1989, p.101.
LA GROTTA ARTIFICIALE NELLA FIRENZE MEDICEA
A cura di Luisa Generali
Introduzione: mitici antri
Tra le meraviglie e i tesori che la dinastia dei Medici potette vantare nelle proprie raccolte di opere d’arte ci fu anche il genere della grotta artificiale da giardino. Questi antri rocciosi che volevano imitare gli ambienti ipogei naturali furono concepiti come vere e proprie architetture rustiche, orchestrate in modo da suscitare delizia e stupore negli astanti. Nate sugli esempi delle grotte e dei ninfei romani, tali costruzioni divennero dal Cinquecento in avanti una moda diffusa fra le nobili famiglie che in tali artifici trovavano il piacere di esprimere le proprie ricchezze. Il primo ruolo assunto da queste “fabbriche bucoliche” era senz'altro il fine concreto di realizzare uno spazio di sosta per assicurare fra i percorsi del giardino un riparo dalle calure estive: per di più all'interno i questi anfratti venivano spesso allestiti impianti idrici che consentivano la messa in opera di fontane e giochi d’acqua, rafforzando l’effetto d’insieme dell’ambiente fresco e gradevole. La presenza delle grotte nei parchi costituiva anche l’immagine di un luogo ameno che richiamasse l’antichità e i suoi miti, a cui frequentemente erano consacrate le decorazioni interne alla camera, finalizzate ad un’allegoria encomiastica-celebrativa del proprietario.
La Grotticina di Madama nel Giardino di Boboli: la prima grotta artificiale
La Grotticina di Madama nel giardino di Boboli (così chiamata probabilmente in omaggio alle granduchesse medicee cui spettava il titolo di “Madama”) rappresenta il primo esempio di grotta artificiale compiuto a Firenze fra il 1553 e il 1555 sotto il ducato di Cosimo I de Medici (fig. 1). Il progetto già teorizzato da Tribolo e portato avanti dopo la sua morte dal genero Davide Fortini, in seguito affiancato da Giorgio Vasari, prevedeva la realizzazione di un piccolo edificio vicino al muraglione occidentale che definiva il confine del parco, in una zona riservata alle frequentazioni private della famiglia. Questo vero gioiello architettonico presenta il corpo di fabbrica esterno rivestito da una parete rocciosa e inquadrato da una cornice in pietra: l’estremità è conclusa da un timpano, mentre al centro si apre una porticina in marmo posta di sbieco e leggermente incavata nella facciata. All'interno si apre una stanza voltata a botte, coperta dalle medesime escrescenze naturali, quali tartari e stalattiti, in dialogo con un concerto di arti (pittura, architettura, scultura) che decorano l’ambiente attribuendogli un molteplice significato allegorico (fig. 2-3-4). Il soffitto, spartito da lacunari in spugne e cornici in stucco, contiene specchiature dipinte a grottesche ed episodi mitologici, realizzati da Francesco di Ubertino, detto Bacchiacca (1494-1557), già attivo per altri incarichi promossi dal duca: la decorazione a grottesche era evocativa delle celebri pitture rinvenute nei sotterranei della Domus aurea di Nerone, le cosiddette "grotte" da cui deriva il termine grottesche. Alle modulazioni del soffitto corrispondono gli ornamenti geometrici-classicheggianti del pavimento in cotto bianco e rosso, opera del 1556 di Santi Buglioni (1494- 1576). Le mura laterali, coperte dalla medesima roccia spugnosa che caratterizza l’intero complesso, sono interrotte da due pannelli in stucco bianco, probabilmente compiuti in epoca lorenese per collocarvi arredi da giardino e sculture minori. La parete di fondo che si apre di fronte all'entrata costituisce l’essenza della grotta, creando una sorta di quadro plastico dove sono protagoniste delle sculture animali con la funzione non meno importante di fontana. La parete centinata rappresenta un monte roccioso in cui la zona superiore è dominata da una Testa di ariete, mentre al di sotto, rivolte verso questa in atteggiamento quasi contemplativo, due capre sono abbarbicate in precario equilibrio su protuberanze rocciose scolpite nella pietra serena (fig. 5). Nella sezione inferiore un’altra capra dalle dimensioni maggiori e le mammelle gonfie rivolge lo sguardo agli astanti, affiancata da due Puttini con delfino, aggiunti alla composizione d’insieme in un secondo momento. Conclude la composizione una vasca ovale con volute su zampe di leone, oggi sostituita da una copia (l’originale si trova lungo il fronte di palazzo Pitti), che aveva lo scopo di raccogliere l’acqua zampillante dalla parete. Le sculture-fontana furono eseguite da Giovanni Paolo Fancelli (inizio XVI secolo-1586), allievo di Baccio Bandinelli (a eccezione della capra centrale assegnata dalla critica proprio al suo maestro), come testimonia Vasari nella Vita di quest’ultimo, in cui il biografo riferisce anche il merito dell’intera commissione alla duchessa Eleonora dei Toledo “Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de’ Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall’acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua […]".

Il tema pastorale che prende a modello la capra come immagine di resistenza e forza capace di sopravvivere alle avversità non basta tuttavia a giustificare l’insistenza in questa grotta artificiale sul significato dell’animale, che si collega infatti, secondo sottilissimi riferimenti mitologici, alla celebrazione di Cosimo I come Giove (o Zeus per i greci), signore degli dei. Tale parallelismo trae origine dalla scelta da parte del duca di adottare come ascendente astrale il segno del capricorno, collegandosi idealmente con i potenti nati sotto tale costellazione, come Cesare Augusto e Carlo V, protettore dello stesso ducato fiorentino. L’iconografia del capricorno, considerato di buon auspicio, vessillo di forza e potere imperiale trova qui, in assonanza con l’amenità del luogo, un diretto collegamento con il mito idilliaco della capra Amaltea, legato all'infanzia di Giove, quando la madre Rea (o Opi) lo sottrasse alla voracità del padre Crono, per nasconderlo a Creta nella caverna del monte Ida e affidarlo alle cure delle ninfe Adrastea e Melissa che lo nutrirono con del miele e il latte della capra. Il richiamo a questo episodio mitico si univa al concetto di grotta madre, dispensatrice della nuova vita inaugurata dal governo cosimiano, oltre a voler mantenere un filo diretto con l’antichità classica dei templi pagani ed in particolare riferendosi all’Amalheion, l’edificio sacro alle ninfe intitolato ad Amaltea, che spesso trovava collocazione nei boschi in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua.
Altri riferimenti simbolici narrati dal mito arricchirono l’iconografia intorno ad Amaltea, come la cornucopia, derivata da un suo corno spezzato, che assunse il significato di fertilità e abbondanza; inoltre alla sua morte, in segno sempiterno di riconoscenza, Giove scelse di tramutarla in una stella, identificata con Capella (termine latino che significa capra) nella costellazione dell’Auriga insieme ai suoi due capretti. Secondo alcune varianti del mito Giove trasse dalla sua pelle perfino il suo infallibile e potente scudo, l'Egida.
Un equivalente pittorico del mito di Amaltea si trova anche a Palazzo Vecchio, nel cuore del potere politico fiorentino, in quello che viene chiamato il Quartiere degli Elementi, un ambiente di più stanze destinato agli uffici di corte e agli ospiti, decorato fra il 1551 e il 1566 durante i lavori di ampliamento del Palazzo voluti dallo stesso duca. Nella Sala di Giove eseguita da Giorgio Vasari e i suoi collaboratori (Marco da Faenza, Cristofano Gherardi e Giovanni Stradano), in un corrispettivo di rimandi con la sala di Cosimo I al primo piano, si celebravano le glorie e le virtù del duca assimilandolo a Giove, proprio come nella Grotticina di Madama. Tra le opere pittoriche su tavola che addobbano il soffitto si trova l’episodio in cui Giove è allattato dalla capra Amaltea (fig. 6), aiutato dalle ninfe Adrastea, mentre tiene ferma la capra nel momento dell’allattamento, e Melissa (come suggerisce il suo nome che significa “ape”) raffigurata mentre tiene in mano un alveare.

La Grotta degli Animali o del Diluvio nella villa dei Medici a Castello: l'iconografia
Il ruolo metaforico assegnato alle sculture raffiguranti animali, di rimando alla celebrazione della casata Medici, venne eseguito su larga scala nella Grotta degli Animali detta anche del Diluvio, situata nel giardino della villa medicea di Castello, alle porte di Firenze: questo enigmatico ambiente, concepito da Tribolo intorno 1540 e portato avanti dal genero Fortini in un periodo di tempo che va dagli anni ‘60 fino al 1595 circa (quando già al potere di Firenze era succeduto il figlio di Cosimo, Francesco I), rappresenta una lode al regno animale pacificato grazie alla condotta esemplare del duca di Firenze. Al suo interno, in tre grandi nicchie si trovano gruppi scultorei di animali nostrani ed esotici riuniti in modo apparentemente casuale con le relative vasche marmoree per il raccoglimento dell’acqua (fig. 7); proprio questo elemento doveva rivestire un ruolo cardine se pensiamo all'altro nome con cui è indicata la grotta, anche detta del Diluvio, forse in analogia con l’episodio biblico dell’Arca di Noè che portò in salvo dal diluvio universale ogni specie animale vivente sulla terra.

Ma l’allusione al diluvio poteva anche riferirsi più letteralmente alla vera e propria “inondazione” di acque provenienti dal pavimento che investivano il visitatore nella grotta artificiale: questi giochi d’acqua concepiti come un sistema di spruzzi e zampilli di fine pioggerellina sono considerati un capolavoro dell’ingegneria idraulica, recuperati grazie al restauro concluso nel 2019 che ha permesso il ripristino dei sistemi idrici e la loro scenografica riattivazione (fig. 8).

Come per la Grotticina di Madama, anche a Castello si cela un fine programma iconografico rivolto all'esaltazione della famiglia Medici, ad oggi ancora di difficile comprensione considerata la moltitudine di riferimenti figurativi che popolano questa grotta artificiale e le trasformazioni che hanno alterato nel corso del tempo il progetto originale. Secondo recenti studi la conformazione della grotta artificiale sarebbe stata concepita sul modello del tempio di Egeria a Roma sulla via Appia, di cui oggi rimangono i ruderi risalenti al II secolo d.C., già scoperti nel Cinquecento e in cui per l’occasione del passaggio di Carlo V a Roma nel 1536 vi venne preparato un banchetto. A supportare le analogie fra le due costruzioni interviene il significato iconologico inerente alla storia mitica della ninfa Egeria, moglie e consigliera di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che per stilare le nuove leggi del suo regno si affidò ai suggerimenti dell’amata, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni. Grazie probabilmente al supporto intellettuale di Benedetto Varchi, che Vasari ricorda essere “amicissimo di Tribolo”, la leggenda di Numa Pompilio ed Egeria si poté traslitterare modernamente nelle figure di Cosimo e la moglie Eleonora, come regnanti leali ed equi, consacrati implicitamente dalle radici storiche romane. Testimoniano tale corrispondenza ideologica diversi componimenti letterari con finalità elogiative che indicano la centralità di questo mito a partire dai primi anni Quaranta del Cinquecento, e che in particolar modo celebrano la figura Eleonora quale alter ego della ninfa, moglie fedele e consigliera saggia.
Secondo alcuni disegni, il primo progetto di Tribolo immaginava l’inserimento nella grotta artificiale di due sculture raffiguranti Pan e Nettuno, poste ai lati della camera, mentre la terza testata sarebbe stata dunque riservata a Eleonora come nuova Egeria, e a Cosimo, suo consorte, come Numa Pompilio. Le successive modifiche condussero invece su tutt'altro piano, con la messa in opera delle tre nicchie animali e il probabile inserimento centrale di una statua (oggi andata persa) raffigurante un Orfeo citaredo (suonatore di cetra). La presenza del cantore, famoso per la sua incantevole musica capace di domare gli animali, e l’epilogo triste delle sue vicende amorose con la moglie Euridice, aveva dato luogo a Firenze ad una serie di assimilazioni concettuali con il potere mediceo. In primo luogo, ricordiamo la commissione di Papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de' Medici) che nel 1519 assegnò a Baccio Bandinelli (1493-1560) la statua di Orfeo e Cerbero per il cortile del palazzo Medici in Via Larga a Firenze (fig. 9): in questo caso l’episodio si riferisce al viaggio che Orfeo dovette affrontare per raggiungere la moglie nell'oltretomba, riuscendo a placare il terribile cane a tre teste, Cerbero, di guardia alla porta degli inferi. Il significato metaforico della scultura voleva qui presumibilmente alludere alle straordinarie capacità di saper conciliare e ammansire sotto il potere mediceo qualsiasi temibile nemico. A tal proposito anche Vasari nella vita di Bandinelli ricorda quest’opera, plasmata sul celebre modello dell’Apollo del Belvedere: “Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de’ Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de’ Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l’Inferno a pietà. Immitò in questa opera l’Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l’Orfeo di Baccio non faccia l’attitudine d’Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore”.

Lo stesso episodio ricompare più avanti nel Ritratto di Cosimo I de 'Medici come Orfeo di Agnolo Bronzino (1537-1539) conservato al Philadelphia Museum of Art (fig. 10). Al celebre personaggio vengono qui conferite le fattezze del duca, mentre l’incantesimo della musica su Cerbero sembra già in atto. La posa sensuale del corpo nudo di Cosimo, memore degli avvitamenti michelangioleschi, è coniugata al tipico pittoricismo cristallino ed impeccabile che distingue lo stile di Bronzino. L’intento encomiastico dell’opera rivela anche in questo caso le virtù di Cosimo come Orfeo, pacificatore e cultore delle arti, oltre che marito fedele e integerrimo: la fedeltà coniugale come chiave di lettura del dipinto si unisce alla possibilità che questo fosse stato commissionato proprio con l’occasione del matrimonio della coppia ducale avvenuto nel 1539.

A Castello il mito si sarebbe invece riferito al ruolo di Orfeo nelle vesti di conciliatore del mondo animale, in un’iconografia che trovava molti riscontri nell'antichità romana come documenta il mosaico pavimentale conservato al museo archeologico Antonio Salinas di Palermo raffigurante Orfeo tra gli animali datato al III secolo d. C. (fig. 11). Oltre alla composizione d’insieme che vede il cantore attorniato da una cornice di animali, come doveva verificarsi nel vano della grotta artificiale di Castello, anche i valori allegorici assunti dalla figura di Orfeo nell'antichità vennero adottati e traslitterati modernamente dalla propaganda medicea. La fortuna di questo tema venne già sviluppata dai greci e ampiamente diffusa dai romani, in epoca imperiale e successivamente nella tarda antichità, assumendo una molteplicità di significati fra cui la celebrazione propagandistica dell’impero grazie all'assimilazione del princeps con Orfeo. Secondo una lettura politico-ideologica, l’azione pacificatrice e civilizzatrice della società romana era dunque espressa dal poeta-cantore come emblema di concordia, capace con la sua musica di riunire intorno a sé gli animali docili e quelli feroci. Secondo un’altra interpretazione, che spiega l’exploit di tale soggetto fra il II e il III secolo, c’era il desiderio crescente di una nuova speranza che ponesse fine al clima conflittuale e di incertezza che attanagliava l’impero, auspicando una rinata età dell’oro con soluzioni figurative che richiamassero tematiche pastorali e idilliache. Un altro significato è la figura di Orfeo come simbolo di armonia ed equilibrio del cosmo, per cui anche il nome del duca Cosimo (dal significato greco di ordine-armonia) poteva sottilmente alludere nel processo identificativo col personaggio. Infine, anche l’arte paleocristiana impiegò la figura pagana di Orfeo come incarnazione di Cristo, allusivo al ruolo di conciliatore di anime, vicino all'immagine del buon pastore, ed instaurando un parallelismo con l’ambientazione bucolica della scena, come prefigurazione del paradiso.

La Grotta degli Animali nella villa dei Medici a Castello: descrizione
Entrando nel merito di quello che oggi rimane a Castello, vediamo come le pareti di questa grotta artificiale siano coperte da un manto roccioso nell'imitazione puntuale di una vera concavità ipogea, mentre la volta propone una decorazione con maschere e motivi all'antica composta da mosaici di conchiglie e ciottoli colorati (fig. 12). Ai lati e di fronte all'ingresso sono scavate tre edicole contenenti le sculture degli animali: la messa in scena teatrale di tali serragli lapidei evoca un effetto trionfalistico finalizzato all'apoteosi del regno animale. Le singole sculture sono realizzate in pietre eterogenee scelte rispetto alle caratteristiche del vello di ogni esemplare, in modo da restituirne un’impressione pittorica e verosimile: difatti le screziature e le venature di alcuni marmi utilizzati favoriscono l’effetto di mimesi, incrementando quella percezione d’insieme al confine fra natura e artificio. In un primo momento la realizzazione degli animali doveva combinare anche l’unione di materiali lapidei e spugne, per favorire maggiormente l’assimilazione delle sculture con l’ambiente selvaggio e primigenio della grotta, un’ipotesi scartata a favore dell’uso integrale della pietra a cui si accompagnò, probabilmente in epoca successiva, l’introduzione di autentiche corna e zanne animali (fig. 13). L’intento originario (oggi in parte perduto) era quello di illustrare in un unico ambiente l’unione armonica di tutte le specie animali, come rappresentanti dell’acqua, della terra e del cielo: dalle vasche decorate con rilievi iperrealistici raffiguranti specie marine, ai mammiferi grandi e piccoli che popolano la superficie del globo, ai volatili in bronzo, oggi non più presenti nell'arredo della grotta. All'interno delle nicchie le sculture degli animali si trovano inerpicate le une con le altre, in modo da formare un gruppo ascensionale, in cui certi esemplari sono messi in posa, mentre altri si presentano in azione, interagendo fra loro (fig. 14-15-16): le specie più minute appaiono soggiogate in una sorta di piramide gerarchica in cui domina la fiera più forte, pur mantenendosi nell'insieme un equilibrio armonico di fondo basato sul rispetto dell’ordine naturale (fig. 17). Per quanto concerne la realizzazione delle sculture, Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e Giambologna (1529-1608) certamente ebbero un ruolo primario nella realizzazione degli uccelli in bronzo, come già accennato non più presenti a Castello, ma attualmente conservati in buona parte al Museo Nazionale del Bargello, nella loggia esterna al primo piano (fig. 18). Anche i volatili vennero riprodotti secondo specie distinte, dai più comuni come il gallo, il fagiano, il pavone, agli uccelli rapaci quali il gufo e l’aquila reale. L’immaginazione di Giambologna si riconosce nel Tacchino (fig.19), una tra le prime raffigurazioni di questo animale proveniente dall'America, in cui stupisce la resa naturalistica del piumaggio che sfrutta gli effetti peculiari della fusione del bronzo. I volatili realizzati a grandezza naturale, rilucenti grazie allo stillicidio dell’acqua che scivolava sulle loro superfici bronzee, si dovevano trovare secondo il progetto originale arroccati fra le rocce della grotta di Castello, forse su appositi sopporti che imitavano sporgenze arboree. Rimangono invece ancora incerti gli autori degli animali in pietra, per cui oltre all'ipotetico apporto di Giambologna e Ammannati, dai documenti emerge anche la presenza di altri nomi quali Antonio Lorenzi, e la famiglia del Tadda con a capo Francesco Ferrucci Del Tadda (1497- 1585) e i figli Giovan Battista e Romolo, scalpellini e scultori originari di Fiesole. Il genere animalier, così bene espresso nella grotta di Castello grazie ad un’accorta e peculiare attenzione al dettaglio naturalistico per cui si ha l’impressione di trovarsi immersi in un bestiario tridimensionale, trovò a Firenze il giusto clima culturale per potersi affermare. Innanzitutto l’interesse per la fauna selvatica era già notoriamente diffuso a Firenze, in relazione alla passione per la caccia che coinvolse fin dagli albori la famiglia Medici, tanto che verso la metà del secolo fu lo stesso Cosimo I a commissionare al fiammingo Giovanni Stradano (1523-1605), la realizzazione dei cartoni per la serie di arazzi dedicati alle Scene di Caccia, destinati alla villa di Poggio a Caiano. Le numerose incisioni circolanti dello Stradano, famoso per le sue variazioni sul tema, di cui si riporta un esempio di Caccia allo struzzo (fig. 20), contribuirono all'idealizzazione del mondo animale come meraviglioso e bizzarro, enfatizzato dallo stile nordico dell’artista che predisponeva scene affollate e vivaci, cariche di meticolosi dettagli. Fra gli episodi realizzati dallo Stradano i soggetti si distinguevano proprio rispetto dell’ecosistema di appartenenza, come cacce terrestri, d'aria e d'acqua, sempre accompagnati dalla presenza costante dell’uomo, capace di conformare la natura alle sue necessità.

Oltre la grotta artificiale: capodogli, "camelopardi" e giraffe
Oltre alla passione per la caccia, nacque a Firenze una crescente attrazione per il mondo naturale nelle forme di sapere enciclopedico, così come nelle grandi corti europee, sulla scia delle nuove scoperte geografiche, che incrementarono la curiosità e il desiderio di conoscenza sui misteri della natura ancora da svelare. Anche Cosimo comprovò il suo interesse per lo studio di reperti naturali e botanici, conciliando il sapere proveniente dall'antichità greco-romana con il pensiero moderno, che guardava alle stranezze naturali come un vanto propagandistico di corte. Nel 1549 il duca dette prova apertamente della sua passione per le rarità animali, ordinando la sistemazione di una grande carcassa di capodoglio proveniente da Livorno sotto la Loggia dei Lanzi. La dimostrazione pubblica dell’enorme esemplare aveva lo scopo di destare stupore nel popolo e al contempo sottintendere alla raffinatezza intellettuale del regnante. Questo tipo di auto-celebrazione rimandava agli usi e ai costumi dell’antichità narrati dalle fonti classiche che testimoniavano come già i romani impiegassero i resti animali per la celebrazione degli imperatori ed anche Augusto, guida ispiratrice di Cosimo, fosse solito adornare le sue ville con meraviglie di questo tipo.
Faceva inoltre parte del fasto della corte medicea il serraglio, quale emblema di sontuosità principesca, presente anche a Firenze in prossimità di Palazzo Vecchio, poi trasferito nella zona di San Marco, e di cui facevano parte animali selvaggi nostrani quali lupi e orsi, ma anche tigri e leoni.
Alcune specie esotiche provenienti da zone lontane del mondo, agli occhi degli europei considerate straordinarie per la loro bizzarria e particolarità, furono talvolta catturate e sottratte ai loro habitat per diventare oggetto di scambio o dono. Un evento singolare che rimase a lungo nella memoria storica di Firenze riguarda proprio la famosa “Giraffa Medici”, il cui arrivo in città destò lo stupore della folla e degli artisti che riprodussero questa creatura come “citazione” dell’illustre episodio. Secondo le cronache la giraffa arrivò dall'Egitto nel 1487 e fu presentata a Lorenzo de’ Medici dagli ambasciatori egiziani del sultano, insieme ad altri omaggi. Nello specifico questi doni facevano parte di un’azione diplomatica svolta dal Magnifico, a cui gli ambasciatori richiesero la sua mediazione nel rilascio del fratello del sultano che era prigioniero in Francia. Anche in questo caso fu determinante ai fini encomiastici l’associazione di tale avvenimento con un episodio analogo della romanità che nel 46 a.C vide Giulio Cesare celebrare il suo trionfo in Egitto portando a Roma anche una giraffa, denominata dagli antichi "camelopardo".
Celebri sono le raffigurazioni della “Giraffa Medici” che suscitò tanto clamore e curiosità: in pittura soprattutto l’animale iniziò a figurare a fianco di Lorenzo il Magnifico, in ricordo dell’evento, ma anche indipendentemente in contesti diversi come nel caso dell’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio per il ciclo di affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella (1485 al 1490): nel paesaggio retrostante sullo sfondo della scena alla scena principale nel corteo orientale compare anche una giraffa, dall'aspetto realistico in cui viene conferito particolare risalto all'aggraziato portamento (fig. 21-22).
Un altro riferimento visivo che ricorda tale vicenda è presente nell'opera canadese raffigurante Vulcano ed Eolo maestri dell'umanità (fig. 23) da datare fra il 1500-1505, appartenente al ciclo smembrato delle Storie dell'umanità primitiva, dipinto da Piero di Cosimo (1461-1522): questo artista famoso per la sua eccentricità viene descritto da Vasari come “molto astratto e vario di fantasia”, a cui piaceva “investigare certe sottigliezze della natura” e recarsi spesso “a veder o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et ccaso di molte volte”. Il vivo interesse di Piero di Cosimo per il mondo naturale venne apprezzato anche da Cosimo I, come ricordato ancora una volta da Vasari, che tra le collezioni del duca cita “pur di mano di Piero un libro d’animali della medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti”. Molte delle opere oggi attribuite a Piero di Cosimo dimostrano l’effettiva sensibilità del pittore verso il regno animale, come comprova l’Incendio nella foresta (fig. 24), dello stesso ciclo sopraindicato (forse in origine appartenuto secondo la testimonianza vasariana al palazzo di Francesco Del Pugliese), in cui sono presentate in primo piano diverse specie animali locali ed esotiche, accostate a creature bizzarre.
Anche il già citato Bacchiacca, lo stesso autore della decorazione del soffitto della Grotticina di Madama a Boboli, ricordato per essere un eccellente pittore di animali, rende omaggio alla famosa Giraffa Medici citandola nella Caduta della Manna (1540/1555), esposta alla National Gallery of Art di New York (fig. 25). Intorno al 1545 Bacchiacca fu all'opera nello scrittoio di Cosimo al piano mezzanino di Palazzo Vecchio, in una decorazione di stampo enciclopedico-scientifico assai moderna. L’ornamento realizzato con la tecnica dell’olio a muro, e per questo oggi molto deteriorato, rappresentava piante e specie vegetali, la cui veridicità è stata accostata ad un erbario o un tratto di botanica, per cui fu necessaria probabilmente da parte dell’artista un’imitazione reale dei campioni. L’ambiente, oggi purtroppo non inserito nel percorso di visita del palazzo per motivi conservativi, si presenta come un piccolo vano ribassato e voltato, decorato inoltre con specie volatili e grottesche in un richiamo onnipresente all'antichità.

Sempre in relazione con i lavori di restauro a Palazzo Vecchio, il duca volle ricordare nella stanza dedicata al Magnifico anche il memorabile episodio della giraffa, commissionando a Vasari e i suoi collaboratori l’episodio del Tributo degli ambasciatori a Lorenzo (1556 e il 1557): la scena esalta il ruolo di Lorenzo al centro della devota folla di delegati che gli offre tesori ed animali esotici, tra cui al di sopra di tutti svetta il lungo e flessuoso collo dell’animale (fig. 26).

La stessa citazione reiterata nelle testimonianze figurative del secolo si trova scolpita anche a Castello, nell'edicola sinistra (fig. 27). La scultura ha un aspetto realistico, conferito anche grazie all'uso della pietra maculata che ricorda verosimilmente il manto della giraffa. A fianco delle sculture di animali desunti da modelli reali, nella grotta figurano anche altri esemplari celebri, tratti da riferimenti iconografici ormai affermati: fra questi, il più noto è senz'altro il rinoceronte, ricalcato sul disegno celeberrimo di Albrecht Dürer (1471-1528) che nel 1515 aveva diffuso tramite incisione l’immagine del primo esemplare indiano portato a Lisbona come dono al re portoghese Manuele I (fig. 28). L’artista che non vide l’animale dal vivo ma a cui pervennero testimonianze disegnate e scritte, modificò l’aspetto reale del rinoceronte, forse volutamente con elementi di fantasia o per equivoco, contribuendo a divulgarne un’immagine ancor più mitica. La fortuna della xilografia di Dürer divenne un modello iconografico diffusissimo tanto che perfino a Castello la scultura del rinoceronte (adiacente alla parete nel vano sinistro) ne conserva i medesimi dettagli immaginativi, come l’epidermide simile ad un’armatura e il dettaglio, piccolo ma significativo, del secondo corno sulla schiena (fig. 29).

Il cinghiale presente nella nicchia destra venne invece realizzato su imitazione di un pezzo antico rinvenuto alle pendici dell’Esquilino nel 1556 ed in seguito offerto in dono da Papa Pio IV a Cosimo I de’ Medici che lo espose a Palazzo Vecchio (oggi agli Uffizi, fig. 30-31). L’opera risalente al II-I secolo a.C. e ispirata a un modello ellenistico dovette interessare particolarmente il duca per gli straordinari esiti naturalistici, offrendo ai suoi artisti un modello antico da studiare e riprodurre: la statua del cinghiale venne infatti ricalcata a Castello e più tardi (1633) sul medesimo modello antico fu forgiato il famosissimo Porcellino di Pietro Tacca per la Loggia del Mercato Nuovo (l’originale al Museo Bardini, fig. 32).
Tra gli esemplari esotici scolpiti a Castello compaiono anche il cammello, l’elefante e due scimmie, entrati a far parte del comune repertorio figurativo (fig. 33): anche i cani, più volte riprodotti fra i serragli della grotta, trovano una corrispondenza iconografica nelle scene pittoriche cinegetiche in cui venivano spesso ritratti in azione durante i frenetici inseguimenti della caccia (fig. 34). Tra l’innumerevole serie di animali orientali e nostrani, di cui solo l’unicorno esula dalla realtà, l'iconografia delle fiere è probabilmente da leggersi su più fronti, simbolici e celebrativi, come il leone nella nicchia centrale (fig. 35), personificazione ed immagine araldica di Firenze, che fu già restituita magnificamente nel Marzocco di Donatello nei primi decenni del Quattrocento (fig. 36): un medesimo rimando diretto al centro del potere fiorentino è assegnato al cavallo scalpitante nell'edicola orientale (fig. 37), attribuito alla mano di Bartolomeo Ammannati per la somiglianza con i cavalli marini della Fontana del Nettuno, capolavoro dello stesso artista realizzata tra gli anni ‘60 e ‘70 del XVI secolo in piazza della Signoria.
Bibliografia
Vasari, Vita di Piero di Cosimo in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Ed. Einaudi, 2015, pp. 565-571.
Vasari, Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino in Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri, Firenze 1568 Ed. Newton Compton Editori, 1997. Testo integrale presente su https://it.wikisource.org/
Vossilla, “Cosimo I, lo scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la filosofia naturale”, in Annunci del Kunsthistorisches Institut di Florenz, 37.1993,2 / 3, pp. 381-395.
Medri, La grotta di Madama, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, p. 98.
Medri, Le grotte, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 68-103.
Medri, Il Cinquecento: le sculture e le fontane; allegoria mitologiche e "Villani" nel giardino, in Il Giardino di Boboli, a cura di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 108-125.
Masseti, “Sculptures of mammals in the Grotta degli Animali of the Villa Medici di Castello, Florence, Italy: a stone menagerie”, in Archives of natural history, 35 (1) 2008, pp. 100-104.
Cascianelli, Orfeo citaredo incantatore di animali: il mito, l'iconografia, i significati, la fortuna, in Le catacombe di San Callisto, storia, contesti, scavi, restauri, scoperte; a proposito del cubicolo di Orfeo e del Museo della Torretta, a cura di Fabrizio Bisconti e Matteo Braconi, Todi 2015, pp. 141-155.
Ferretti, S. Lo re, “Il ninfeo di Egeria sulla Via Appia e la grotta degli Animali di Castello: mito e architettura tra Roma e Firenze”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 14-23.
Giannotti, “La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra”, in Opvs incertvm, anno 4 (2018), pp. 24-35.
Sitografia
Restauro grotta degli Animali a Castello: www.lanazione.it/firenze/cronaca/restaurata-grotta-villa-medicea-castello-1.4454363
Mostra Stradano: www.fermataspettacolo.it/flowcost/curiosita-e-bizzarrie-nelle-cacce-dello-stradano-a-cerreto-guidi
PIRANESI, ARCHITETTO SENZA TEMPO
Recensione della mostra "Giambattista Piranesi, architetto senza tempo" a cura di Mattia Tridello
La mostra a Palazzo Sturm
Trecento anni fa, precisamente il 4 Ottobre 1720, nasceva Giambattista Piranesi, un artista che con le sue opere incisorie ha regalato al mondo vedute straordinarie dei più importanti monumenti della classicità romana, visioni sublimi dell’antico da lui tanto amato e studiato. Con la volontà di rendere omaggio a quest’ultimo, in occasione del trecentenario dalla nascita, nell’incantevole scenario del settecentesco Palazzo Sturm, sulle sponde del Brenta, dal 21 Giugno 2020 si apre al pubblico un’esposizione che, ad oggi, non ha avuto eguali nella storia museale bassanese. “Giambattista Piranesi, architetto senza tempo” è infatti la prima grande mostra della collezione delle incisioni di Piranesi presenti nel comune di Bassano del Grappa, ed è quindi la prima occasione per poter vedere e apprezzare una raccolta che, grazie ai prestiti della Fondazione Cini di Venezia, si può definire completa, satura di tutta l’opera artistica e grafica prodotta da Piranesi nel corso della sua vita, cronologicamente dettagliata e ampia tanto da creare un concentrato incisorio unico nella città veneta. L’esposizione si configura come la concreta risposta all'esigenza di esporre ai visitatori i tesori che si trovano aprendo semplicemente i cassetti della sala stampe o della biblioteca della città, alla necessità di sensibilizzare pubblicamente la vastissima e pregevole quantità di opere che troppo spesso stanno in disparte e giacciono nei depositi museali, alla volontà di ribadire il primato storiografico e culturale portato da un artista del quale, per via di malintesi e fraintendimenti, per molto tempo si è conosciuto pochissimo della sua vita giovanile, in particolare sul luogo di nascita.
Giambattista Piranesi: gli anni giovanili
Risulta veramente singolare constatare dunque che, pur essendo uno dei maggiori protagonisti dell’arte incisoria europea del Settecento, Piranesi non nacque, come da decenni è stato pensato, a Mogliano veneto, bensì a Venezia. Proprio nella città lagunare egli trascorse l'infanzia e i primi anni della giovinezza accanto al padre Anzolo, un tagliapietre che proveniva dall’Istria, precisamente dalla città di Pirene. Venezia, come è noto, utilizzava per la costruzione dei suoi edifici enormi quantità di pietra d’Istria poiché, già a partire dal governo del Doge Orseolo, il territorio, ora facente parte della Slovenia, risultava annesso alla Serenissima. E’ dunque facile comprendere da dove derivi il cognome della famiglia Piranesi e perché quest’ultima si sia stabilita, negli anni, proprio nella laguna. All'età di vent'anni Giambattista parte alla volta della Città Eterna in qualità di disegnatore nella spedizione diplomatica di Francesco Venier (ambasciatore veneziano). Nel 1743 pubblica a Roma “La prima parte di architetture e prospettive” (1743), il suo primo catalogo di incisioni, a cui ben presto si susseguono altri volumi, primi fra tutti le “Vedute di Roma” (1748) e “Le carceri”(1749 prima edizione, 1761 seconda edizione). Da lì a pochi anni, nel 1778, Piranesi si spegne lasciando però acceso un nutrito e intimo desiderio di continuare l’opera da lui iniziata spingendo così numerosi artisti italiani e europei a imitare le sue vedute, i suoi sguardi sull'antico, i suoi occhi sul tempo passato.
E’ dunque per questo che il sottotitolo stesso dell’esposizione, “architetto senza tempo” vuole rimarcare quanto appena illustrato sottolineando come lo stesso artista, seppur con una basilare formazione architettonica, non produsse, da architetto, molti progetti. Della sua attività costruttiva ci rimane solamente la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma e il completamento assiale del famoso portale con “il buco della serratura” situato accanto al luogo sacro e sempre sull'Aventino. Una nuova e veramente interessante riflessione sul tema temporale legato al rapporto tra la contemporaneità settecentesca, in cui viveva Piranesi, e l’epoca romana, ben più distante, viene fornito già dalla prima sala al piano terra (Fig. 1) dell’edificio dove, per la prima volta, viene esposta un’opera di un artista vivente in relazione al tema centrale della mostra. Luca Pignatelli, infatti, propone una stampa di dimensioni notevoli riproducente una veduta di Piranesi, “La veduta del castello dell’acqua felice” (Fig. 2). Su quest’ultima egli inserisce volontariamente orologi di diversa tipologia e grandezza per rimarcare come lo scorrere del tempo, ieri come oggi, sia inesorabile, continuo nel rivestire con la sua patina le città odierne e quelle antiche.
Il percorso della visita
Sfruttando l’ordine cronologico-biografico la mostra si articola negli ultimi due piani del palazzo bassanese che, dopo il recente restauro, sono stati riportati all'originario splendore. Tra stucchi e soffitti dagli echi neoclassici trova sistemazione la ricca e completa collezione incisoria della città, ben custodita grazie a contenitori protettivi e termoisolanti. Un occhio di attenzione e riguardo è stato posto anche nella sistemazione dei punti di illuminazione naturale e artificiale, che permettono una buona lettura delle opere evitando riflessi sul vetro protettivo, utilizzato per non compromettere la perfetta condizione delle incisioni e che garantisce la focalizzazione dell’osservatore sulle stampe, sia singole che rilegate.
Sala 1 e sala 2
Nella prima sala del quarto piano di Palazzo Sturm (Fig. 3), l’esposizione si apre con un’assai piccola stampa risalente al 1757. L’elemento raffigurato e adottato come logo della mostra è un “Occhietto con uroboros”(Fig. 4). L’immagine, seppur di ridotte dimensioni, racchiude un preciso significato, che ancora una volta può far riflettere sulla vita e sui desideri dell’artista. Noto soprattutto per le sue incredibili incisioni, il vero sogno di Giambattista Piranesi rimase sempre quello di essere architetto. In vita, come accennato precedentemente, ottenne un solo incarico in questa veste: il rifacimento della Chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma. Questo suo desiderio si riflette sia nel fatto che si firmasse come “architetto veneziano”, sia che usasse come occhietto, in cui collocare il nome della persona alla quale veniva dedicato un determinato volume, un’incisione con gli strumenti di tale disciplina: la penna, la squadra e il compasso.
Questi utensili sono legati insieme fra loro dall’uroboros: un serpente che, mordendosi la coda, forma un cerchio senza inizio né fine. Presente nella cultura di molti popoli ed epoche, l’uroboros, apparentemente immobile ma in eterno movimento, rappresenta l'energia universale che si consuma e si rinnova di continuo, la natura ciclica del mondo, l'unità, l'infinito e l'eternità. Un rimando quindi all'antico di cui Piranesi fu fervente sostenitore e studioso, e una raffigurazione che verrà ripresa in altri contesti ma simili significati anche dal Canova nel monumento funebre per Maria Cristina d’Austria nella Chiesa degli Agostiniani a Vienna (Fig. 5).
Il resto dell’ambiente risulta occupato da alcune delle primissime incisioni, perlopiù frontespizi (Fig. 6), del giovane Piranesi, che proseguono poi anche nella sala successiva.

Sala 3-4-5
La terza sezione del percorso espositivo (Fig. 7) è completamente dedicata a una delle raccolte che, senz'altro, resero celebre Piranesi sia in Italia che all'estero: si tratta di stampe singole o rilegate in volumi eccezionalmente aperti e visibili interamente riproducenti visioni, scorci, vedute della Roma sia antica che contemporanea all'artista, con la popolazione ritratta nelle normali attività quotidiane. Non deve stupire, quindi, vedere come nella “Veduta del Ponte e Castel Sant’Angelo” (Fig. 8), oltre ai meravigliosi monumenti cittadini, non manchino navigatori, pescatori con le loro piccole imbarcazioni intenti a sistemare le reti nel Tevere. Come fa notare uno dei curatori della mostra e del catalogo, Pierluigi Panza, “ … nelle sue vedute vi è un’umanità piccolissima ma sempre indaffarata … è un gran teatro veneziano e umano” .
Nelle numerose vedute presenti (Fig. 9-15), sia in quelle che rappresentano la Roma moderna, sia in quelle legate al ricordo e alla memoria della città imperiale romana, l’indiscussa protagonista è la storia. Attraverso il disegno delle architetture classiche e delle rovine, Piranesi vuole enfatizzare quelle sopravvissute testimonianze di un passato ormai irraggiungibile, di un passato antico ricoperto dalla natura che prosegue nel suo intento corrosivo e al contempo poetico.
Sala 6 a
Terminata la visita alla prima parte dell’esposizione, salendo l’elegante scalinata settecentesca del palazzo, si giunge alla seconda e ultima sezione della mostra. L’ambiente al quinto piano è diviso in due differenti zone di interesse. La prima di queste ospita alcune sedute per poter guardare il filmato che viene proiettato tramite uno schermo alla parete (Fig. 16). Il cortometraggio, realizzato da Grègoire Dupond per factum Arte, ricostruisce tridimensionalmente ogni ambiente delle sedici tavole delle cosiddette “Carceri”(ospitate nella sala successiva) portando così il visitatore all'interno di un viaggio virtuale nelle famose e altrettanto singolari ultime incisioni dell’artista (Fig. 17).
Sala 6 b
L’ultima sala dell’esposizione (Fig. 18) è interamente dedicata all'esposizione dell’importante prestito concesso dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia: le stampe delle “Carceri d’Invenzione”(Fig. 19-23). Per la loro straordinaria libertà di immaginazione e per la capacità di trasferire nel segno grafico una sensibilità pittorica, le incisioni rivelano l’influenza dei Capricci di Gianbattista Tiepolo, incontrato da Piranesi presumibilmente nel 1747, poco prima della sua ripartenza per la Città Eterna. Descritte da Victor Hugo come “l’orribile Babele sognata dal Piranesi” , le sedici tavole esposte vennero incise dall'artista dopo un delirante attacco di febbre. In queste, il carattere ancora rococò del capriccio piranesiano si unisce alle cupe visioni dell’eccesso barocco, con quel susseguirsi di scale che non portano in alcun luogo, i ponti sospesi, le grate, gli antri bui, gli strumenti di tortura e le figure minuscole che si agitano all'interno. Esse sono il contributo dell’artista al dibattito dell’epoca sui sistemi di tortura e sulla pena capitale, un’espressione di angoscia interiore che anticipa egregiamente le raffigurazioni di Escher e le scomposizioni volumetriche dell’architettura decostruttivista, oggi affermata in tutto il mondo.
Dalle architetture visionarie, stravaganti, per certi versi veramente immaginarie, si ritorna quindi al tema su cui si fonda la mostra stessa. Piranesi, architetto senza tempo, incisore, amante dell’arte antica tanto da essere conosciuto principalmente per quest’ultima, invece che per la sue opere architettoniche, a trecento anni dalla nascita, viene omaggiato e dovremmo dire, ringraziato per la sua straordinaria capacità di captare, raggruppare, immortalare la realtà a lui contemporanea e quella antica in un corpus artistico straordinario, in stampe realizzate sotto un’unica mano, sotto un tratto abile e veloce nel carpire e imprimere nella carta il respiro del passato, la voce dell’antico, l’eco del tempo.
Informazioni per la visita:
PALAZZO STURM
Via Schiavonetti, 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
21.6.2020 — 19.10.2020
ORARI
Tutti i giorni, 10-19
chiuso il martedì.
La biglietteria chiude alle 18.
BIGLIETTI
Ingresso compreso nel prezzo del biglietto
7 € intero, 5 € ridotto
CONTATTI
T +39 0424 519 940
*Il catalogo scientifico della mostra edito da Silvana Editore, a cura di Chiara Casarin e Pierluigi Panza, presenta tutte le opere e le incisioni di Piranesi esposte a Palazzo Sturm con i testi di Chiara Casarin, Pierluigi Panza, Luca Massimo Barbero, Enzo Di Martino, Manlio Brusatin e Stefano Pagliantini.