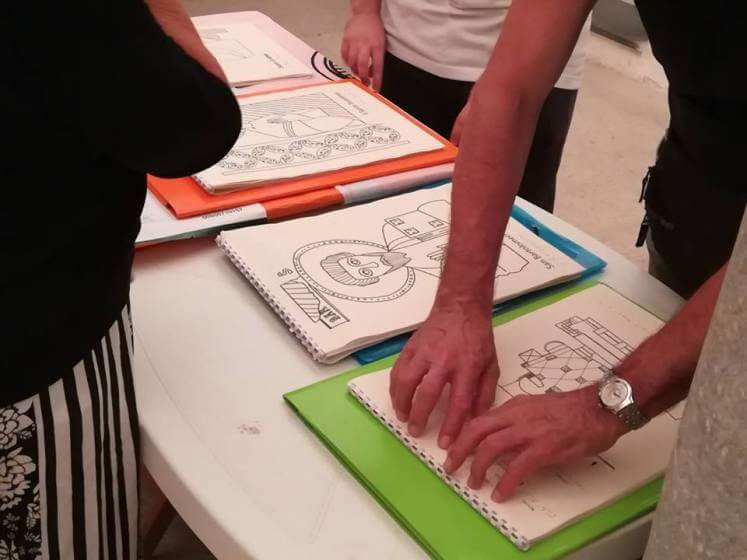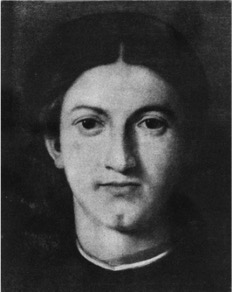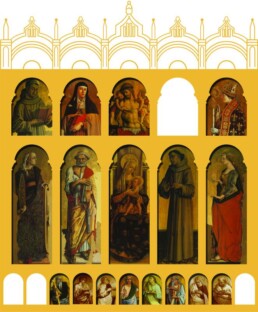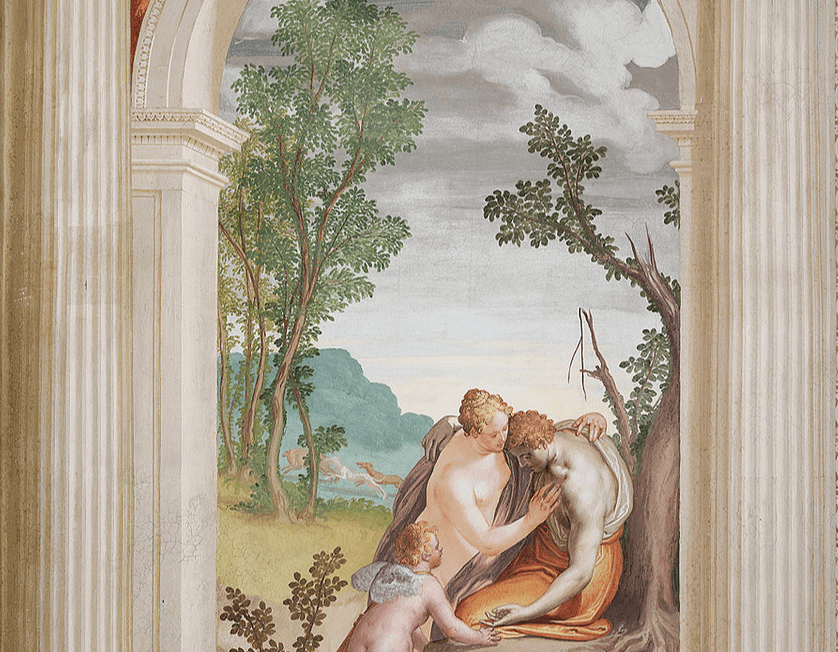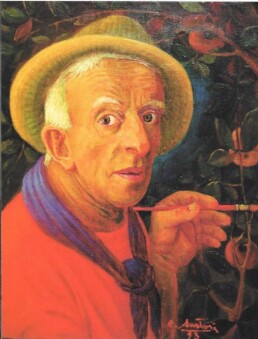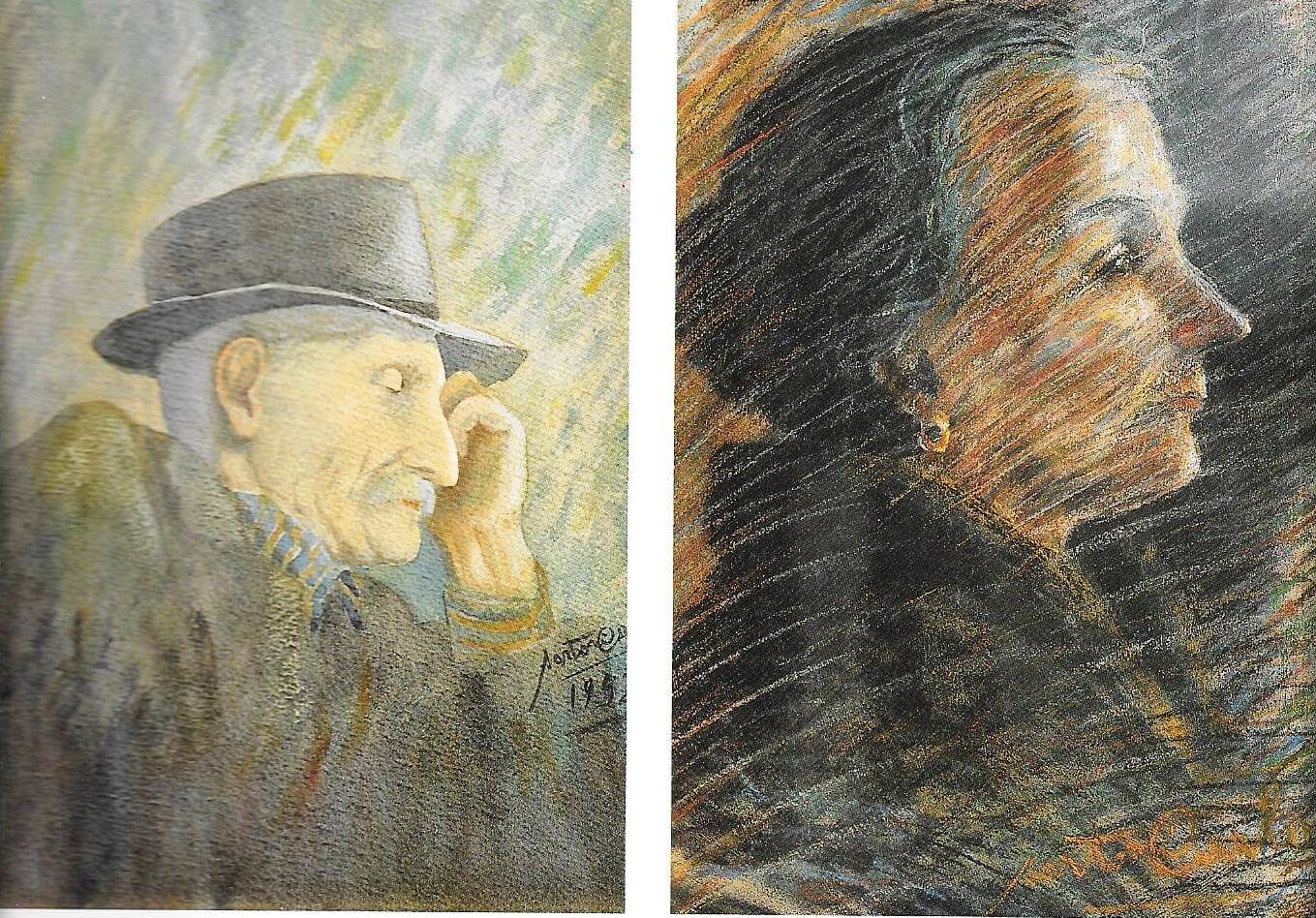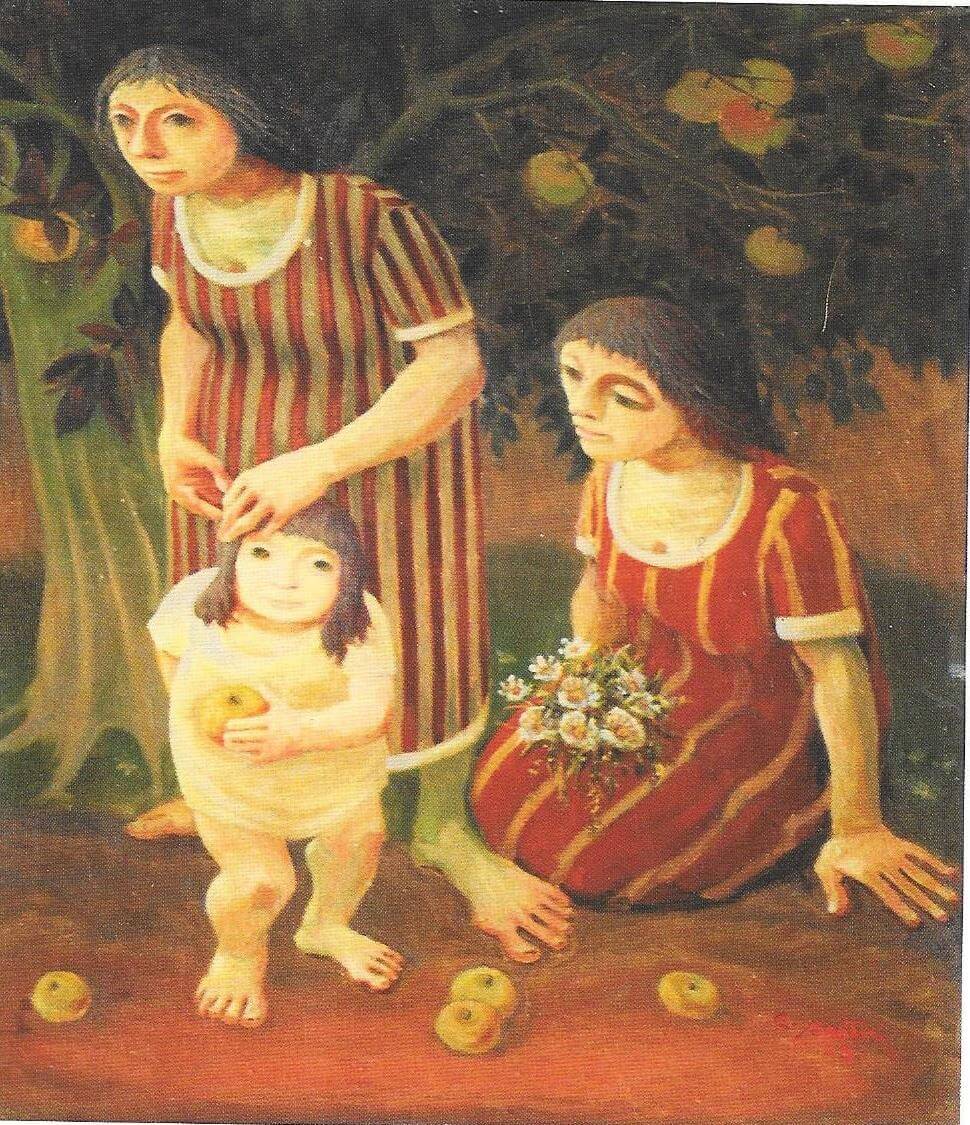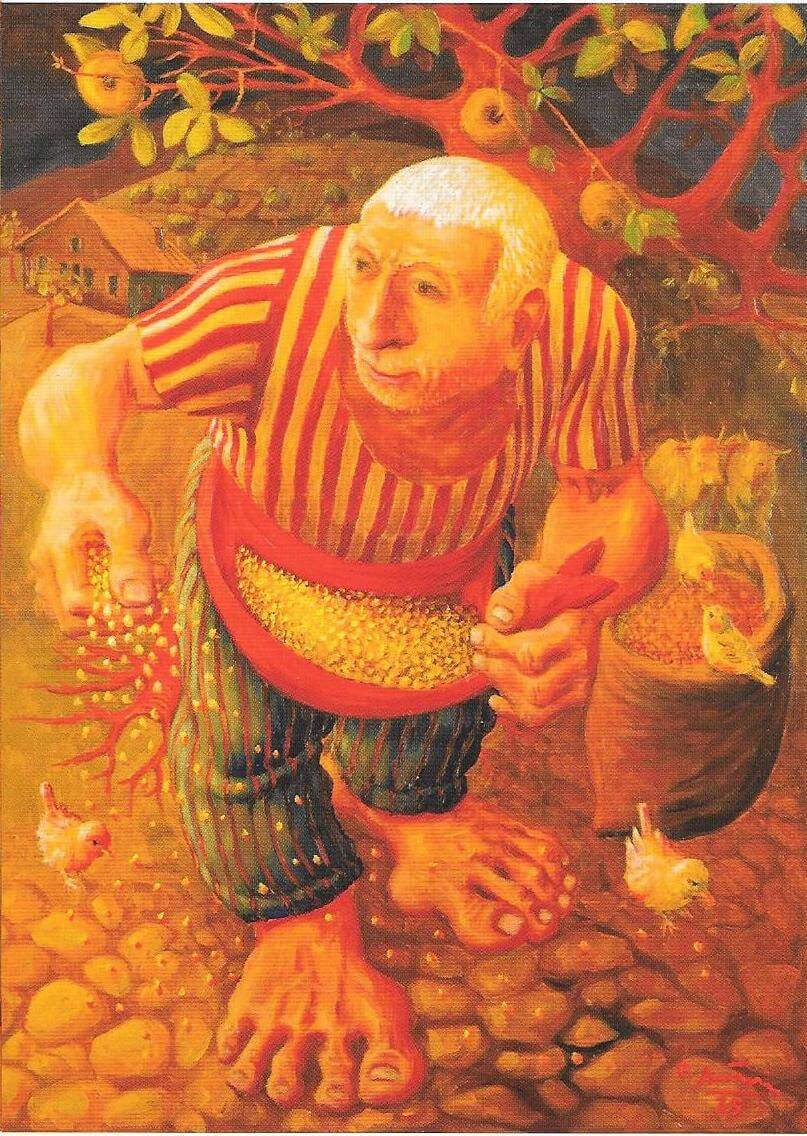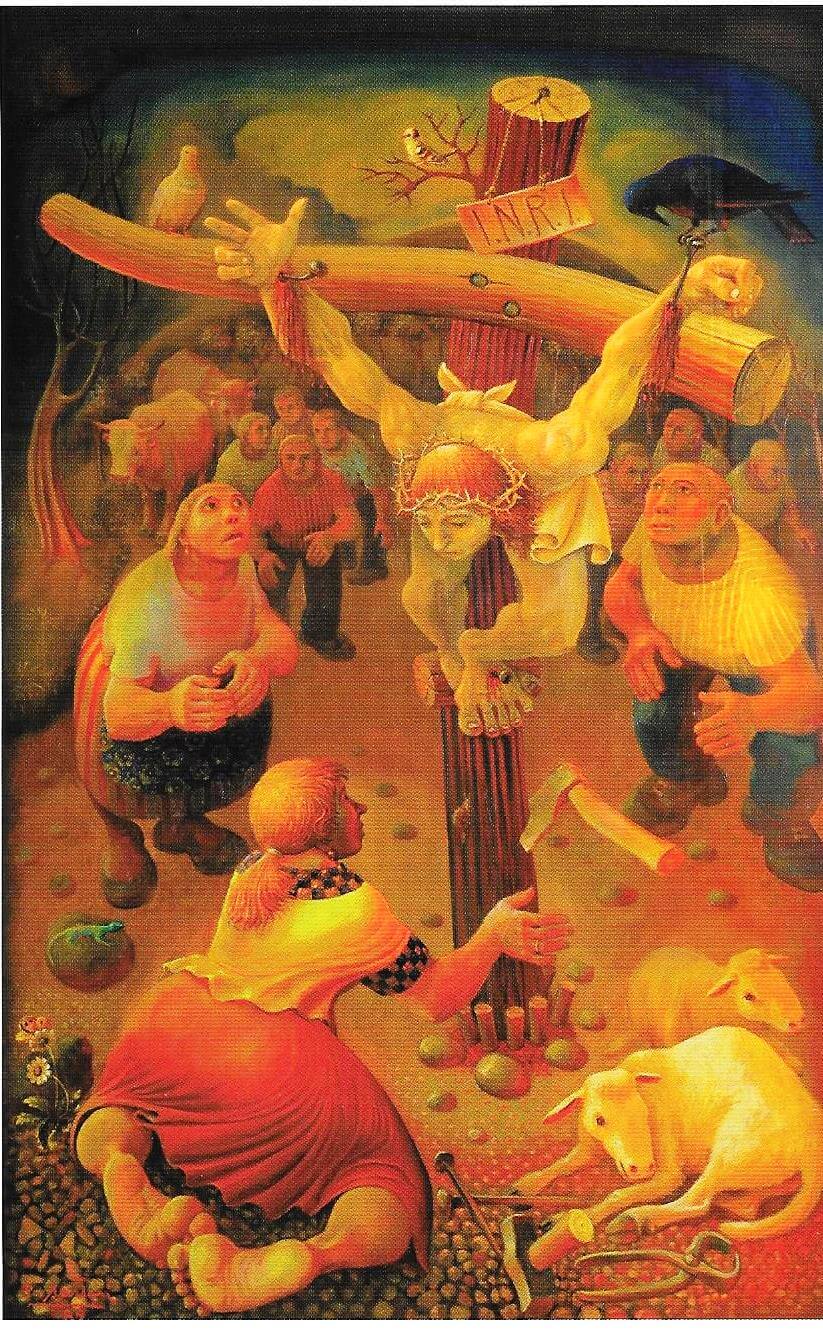SAN GIUSEPPE A ROMANO DI LOMBARDIA
A cura di Michela Folcini
Breve introduzione alle vicende di San Giuseppe
La Chiesa campestre di San Giuseppe è la costruzione religiosa più antica del territorio di Romano di Lombardia, paese della bassa bergamasca ai confini con le provincie di Brescia e di Cremona.
Edificata durante l’epoca dell’Alto Medioevo e originariamente dedicata a S. Eusebio, la chiesa sostituisce quasi sicuramente una più antica edicola sacra, collocata lungo la strada del guado (chiamata anche via antica), sicuramente utilizzata già a partire dall’età preromana e romana, e successivamente anche in epoca viscontea. É il ritrovamento di una moneta d’argento con il ritratto di Gian Galeazzo Visconti, in un campo vicino a S. Eusebio, a testimoniare la frequentazione di questa via anche durante il corso del Trecento e Quattrocento.
L’origine della chiesa di San Giuseppe (o S. Eusebio) nell’Alto Medioevo è dovuta alla famiglia De Duca o De Ducibus, o meglio dei Duchi di Romano, capaci di mantenere per alcuni secoli il comando amministrativo e militare del borgo antico di Romano e del suo distretto. Infatti, durante il corso del VIII secolo il Dux di Romano, ovvero il signore con incarichi militari, procurò il terreno necessario per la costruzione di un nuovo edificio, con dedicazione antiariana di S. Eusebio, che doveva essere collocato al centro del distretto. Da quel momento tutta la popolazione del borgo di Romano, sia di stirpe romana che longobarda, prese l’incarico di custodire questa piccola chiesetta venerata da tutti coloro ebbero la fortuna di visitarla.
Nel 1148 la chiesetta di S. Eusebio fu assegnata alla Diocesi di Cremona e dal XV secolo in poi a quella di Bergamo. La chiesa fu abbandonata fino al 1634, venendo usata come deposito di attrezzi agricoli, per poi essere finalmente restaurata durante il corso dell’Ottocento. In quest’occasione la chiesa venne dedicata a San Giuseppe. Purtroppo, durante il corso del Novecento, gli affreschi cinquecenteschi subirono molte operazioni di strappo non del tutto idonee alla loro conservazione e il tetto subì un crollo. Solo grazie all’intervento del gruppo de “Gli amici di San Giuseppe” costituito nel 1968, la chiesa venne restaurata e ne fu curato anche lo spazio esterno. Dal momento della loro fondazione, “Gli amici di San Giuseppe” provvedono alla pulizia e alla manutenzione della chiesa, ma allo stesso tempo all’organizzazione della tradizionale festa dedicata a San Giuseppe, che si svolge il 19 marzo.

La chiesa campestre di San Giuseppe
La Chiesa di San Giuseppe riprende la struttura architettonica dell’edificio sacro di forma elementare tipico delle chiesette campestri, caratterizzate da un’unica aula mono-absidata e costruite con materiali poveri e facilmente reperibili come la pietra o il cotto. Questa tipologia di edifici, pensati come oratori privati, si colloca al di fuori del centro abitato in aree rurali. Lo schema dell’aula absidata deriva dall’architettura civile romana e tutta la muratura si articola seguendo il modulo dell’opus spicatum, ossia a spina di pesce, molto diffuso nella pianura bergamasca. La chiesa è orientata da est verso ovest, con l’abside rivolto a Oriente, e la copertura è a capanna.
Studiando sia l’esterno che l’interno della struttura, gli studiosi hanno individuato tre possibili fasi di costruzione. Il nucleo primitivo databile al X secolo, corrispondente alla zona dell’abside semicircolare, all’epoca presentava una copertura lignea e un modesto portichetto con pilastri grossolani in muratura. Sempre a questo periodo risalgono i due oculi della faccia orientale, al di sopra dell’abside, e due piccole finestrelle, considerate come le uniche fonti di luce della chiesa.
La seconda fase di costruzione dell’edificio è collocabile nel corso della prima metà del XII secolo, periodo delle lotte per i confini ecclesiastici. In quest’occasione l’aula viene allungata, raddoppiando le misure del primo nucleo e mantenendo le caratteristiche strutturali della fase più antica. All’unica porta d’ingresso della prima fase, si aggiungono due porte laterali e la facciata assume le caratteristiche della tipologia a capanna.
Infine l’ultima fase di costruzione prende avvio nel 1500, in contemporanea all’inizio della decorazione pittorica. La realizzazione di una nuova muratura in facciata, in corrispondenza dell’ultima capriata, comporta l’accorciamento dell’aula. La nuova facciata presenta tre aperture con contorno in pietra arenaria; la porta centrale, unica rimasta dopo la chiusura delle due laterali di XII secolo, consente ai fedeli di recitare una preghiera anche nei momenti di chiusura della chiesa. Il vasto pronao che si viene a costituire, largo quanto l’aula, è il risultato della distruzione della vecchia facciata. A questa fase risale probabilmente anche la costruzione del piccolo campanile a vela.
L’apparato decorativo interno
L’interno della Chiesa di San Giuseppe era totalmente ricoperto da affreschi, sia figurativi che decorativi. Purtroppo, attualmente ben poco è rimasto di questo patrimonio, solo poche tracce e frammenti incompleti o poco leggibili. Gran parte della perdita delle pitture di San Giuseppe sono da rintracciare nelle operazioni di strappo degli affreschi: questa operazione di restauro viene eseguita nella speranza di salvare gli affreschi da una distruzione imminente, con lo scopo di una maggiore conservazione delle pitture in luoghi più idonei. Purtroppo, nel caso della nostra chiesetta, gli affreschi non hanno mai trovato posto in nessun museo, anzi sono stati venduti per pochi soldi a coloro che avevano provveduto allo strappo: ciò che noi ammiriamo oggi altro non è che lo strato pittorico sottostante lo strappo.
Gli affreschi appartengono a tre epoche ben distinte: di fine Quattrocento inizio Cinquecento quelli dell’aula; del tardo Cinquecento quelli dell’arco trionfale; dell’ultimo periodo del Seicento quelli del catino absidale. Le pitture della parete destra sono in totale sette e incorniciate in riquadri colorati: S. Defendente e S. Giovanni Evangelista, Nobiluomo a cavallo, Sacra Famiglia, S. Eusebio e S. Francesco, S. Giovanni Evangelista, Sacra Famiglia e un affresco illeggibile.
Le pitture della parete sinistra si pongono in una continuità decorativa identica a quella destra, mostrano: S. Antonio e S. Eusebio, Natività e Santi, una Santa non identificabile, Madonna con Bambino, Sacra Famiglia e un ulteriore affresco totalmente illeggibile.
L’arco trionfale presenta le raffigurazioni di S. Antonio, a destra, e una decorazione con vasi e fiori a sinistra. Sopra i due affreschi e al di sotto dei due oculi, si trovano rispettivamente a destra la Madonna che riceve l’Annuncio e l’Angelo Annunziante a sinistra. La decorazione pittorica dell’area presbiteriale, oggi assai compromessa, può essere ricostruita grazie alle fotografie dell’epoca. Il ciclo pittorico è costituito da un finto basamento architettonico, sopra il quale si inseriscono sei nicchie che ospitano le immagini di sei santi. Riconoscibili sono S. Antonio da Padova con il Bambino e S. Defendente. Gli affreschi di San Giuseppe potrebbero risalire a un pittore locale, il quale ha voluto rappresentare in questa chiesa i santi della devozione della propria gente.
Bibliografia
Cassinelli B, Rodeschini M.C., Itinerari tra arte e storia del Borgo di Romano, 1990.
Comune di Romano di Lombardia, Borgo di Romano. L’arte come specchio della storia, 2014.
LA CHIESA DI SANTA MARIA DE LAMA
A cura di Rossella Di Lascio
Santa Maria de Lama: introduzione
Santa Maria de Lama è una delle più antiche chiese di Salerno, dedicata alla Madonna della Lama, datata tra la fine del X e gli inizi del XI sec., dunque di epoca longobarda. Si trova nel centro storico cittadino, lungo Via Tasso, e a cui si giunge percorrendo i cosiddetti “gradoni della lama”.
Il toponimo “lama” si riferisce alla presenza nella zona di un torrente che ancora oggi scorre davanti all’edificio, sotto il livello stradale.
Di probabile fondazione nobiliare, le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1055. Nel corso del XIII sec., probabilmente a causa di un terremoto o di un’inondazione, l’edificio subisce profonde modifiche che portano alla costruzione di una nuova chiesa nella parte superiore, con la pianta rivolta ad ovest, mentre quella originaria diventa una cripta, successivamente sigillata per assumere la funzione di sepolcreto.
La chiesa superiore: descrizione degli esterni
La chiesa superiore è stata restaurata in stile barocco nel XVII sec., perdendo quasi tutti gli affreschi e i mosaici originari. Al Seicento risale anche il campanile che affianca la facciata, la cui mole è alleggerita dall’apertura di monofore.
Quest’ultima, semplice ed essenziale, presenta, nella parte inferiore, un portale rettangolare a cui si accede mediante gradini semicircolari e, nella parte superiore, due monofore ogivali laterali e un oculo centrale.

La chiesa superiore: descrizione degli interni
L’interno presenta un impianto basilicale a pianta rettangolare, sormontato da capriate lignee, divisa in tre navate da due file di colonne di spoglio romane su cui si impostano altrettanti capitelli misti.
Le colonne dovevano essere decorate con affreschi, di cui oggi restano solo alcune lievi tracce cromatiche, ad eccezione di due colonne sul lato destro, su cui è ancora possibile ammirare le due figure, un Cristo portacroce e una figura femminile che sorregge una lanterna accesa, probabilmente la Maddalena, orientativamente datati tra il XIV- metà XV sec.

Della Maddalena spiccano i lunghi e fluenti capelli biondi e le mani dalle dita affusolate, mentre della figura di Cristo, meglio conservata, colpiscono la delicatezza dei lineamenti del suo volto, l’intensità e la pacatezza del suo sguardo e la docilità che esprime nel semplice gesto di abbracciare la sua croce.
L’eleganza complessiva delle figure e dei loro lineamenti, i colori vividi, il blu dello sfondo richiamano la pittura senese.

Santa Maria de Lama. La chiesa inferiore e il primo ciclo di affreschi (X - XI sec.)
La chiesa originaria, attualmente corrispondente alla cripta, sorge sui resti di un edificio di età romana, un impianto termale datato al II sec. d. C., di cui restano ancora visibili alcune tracce di muratura in opus reticulatum e opus listatum. Presenta una pianta rettangolare divisa in due navate da tre colonne centrali e coperta da otto volte a crociera: la navata destra termina con un’abside circolare affrescata con la figura di Santo Stefano, mentre quella di sinistra con un’abside rettangolare recante tracce di affreschi con eleganti decorazioni a girali. Sul lato settentrionale, si apre uno spazio curvo che si ritiene possa essere l’abside di un primo nucleo della chiesa a pianta quadrata, orientato sull’asse N-S.
È questo il cuore pulsante dell’intero complesso, in cui è possibile ammirare due interessanti cicli di affreschi, il primo dei quali datato tra la seconda metà del X e i primi anni dell’XI sec. Ciò significa che ci troviamo di fronte a preziosissime testimonianze di pittura longobarda, le uniche presenti in città.
Il ciclo pittorico prevedeva una teoria di Santi raffigurati in piedi, dall’impostazione frontale e dall’aspetto ieratico, inquadrati da cornici rettangolari costituite da fasce bicolori. Due figure sono meglio conservate e riconoscibili, grazie alla presenza di resti di iscrizioni che ne consentono la sicura identificazione: San Bartolomeo e Sant’Andrea.

San Bartolomeo si presenta come un uomo maturo, il cui viso, di forma ovale, è incorniciato dalla barba bianca terminante a due punte e da una capigliatura riccioluta bianca. Indossa un semplice abito e un mantello di colore chiaro, ha la mano destra benedicente, in cui unisce pollice e mignolo, mentre con la sinistra, velata dal mantello, regge un elegante volume chiuso e impreziosito da una croce gemmata.

Sant’Andrea è il patrono di Amalfi e ciò testimonia la presenza a Salerno di una comunità amalfitana, che si ritiene frequentasse la chiesa. Gli amalfitani furono deportati in città dai Longobardi, per volere del principe Sicardo, in modo da potenziare o avviare lo sviluppo commerciale della città.
Anche Sant’Andrea ha il volto ovale incorniciato da una capigliatura riccioluta e dalla barba a due punte, ma ha un aspetto più giovane di San Bartolomeo; la mano destra è aperta e benedicente, mentre la sinistra sorregge una sottile e preziosa croce gemmata.
I tratti, i lineamenti dei volti, la resa stessa delle figure, dei dettagli degli ornamenti, degli abiti e delle pieghe delle vesti sono resi mediante l’impiego di marcate linee scure.
Ancora oggi colpiscono i colori che, originariamente, si presentavano più intensi, e la fissità dei volti dei personaggi, di cui risaltano gli occhi grandi e rotondi.
La chiesa inferiore: il secondo ciclo di affreschi (XIII - XV sec.)
Il secondo ciclo pittorico risale, invece, al XIII-XV sec. Anche qui doveva essere presente una teoria di Santi, sempre racchiusi entro cornici rettangolari bicolori.

Nell’abside semicircolare, che si apre lungo il muro est, si riconosce la figura di Santo Stefano, identificabile dalla scritta SCS STEPHANUS posta ai lati dell’aureola.
Dall’aspetto giovane, imberbe e dai lineamenti delicati, è seduto su di un trono, con la mano sinistra reggente un libro e la destra aperta in atteggiamento di saluto.
L’eleganza della figura è data dal raffinato abito ricamato che indossa e da un motivo di perline bianche che decora l’aureola e la cornice che lo inquadra.

Sull’ultimo pilastro del muro sud si staglia un giovane santo imberbe, vestito da monaco e con il capo coperto dalla cocolla, recante nella mano sinistra una catena spezzata, mentre la destra è in atto benedicente. Tale figura era stata inizialmente identificata con Santa Radegonda, ma si ritiene possa trattarsi di un personaggio maschile, probabilmente San Leonardo. L’iconografia ritrae solitamente San Leonardo con l’abito nero e bianco dell’ordine benedettino e con le catene spezzate, in quanto considerato patrono dei carcerati per aver spesso intercesso in favore dei prigionieri. Inoltre, il culto per San Leonardo, a differenza di quello per Santa Radegonda, è attestato in zona dalla fondazione di un convento cistercense dedicato a San Leonardo.
In questo secondo ciclo di affreschi è possibile notare un maggiore gioco tra luci ed ombre che conferisce senso plastico alle figure, come nel caso di Santo Stefano in trono, di cui si accenna alla volumetria delle ginocchia.
Santa Maria de Lama: stato attuale
Allo stato attuale, purtroppo, gli affreschi sono molto danneggiati a causa dell’umidità, delle infiltrazioni d’acqua e dei cambiamenti climatici verificatisi nel corso degli anni, perciò si auspica in un intervento tempestivo di restauro e conservazione, per evitare in futuro la perdita totale di questo patrimonio.
Il complesso di Santa Maria de Lama è stato lasciato in uno stato di abbandono e di chiusura dopo il terribile terremoto del 1980. I lavori di restauro sono stati avviati dagli anni Novanta, ma è solo di recente che è tornato a nuova vita, grazie all’opera del Touring Club di Salerno che l’ha preso in gestione dal 2015, consentendone l’apertura ai visitatori e ai cittadini ogni fine settimana, dalle ore 10 alle ore 13.
Il complesso è oggi accessibile anche ai disabili, grazie ad un sistema di passerelle per i disabili motori e al progetto “Accessibilità all’arte”, messo a punto dal 2018, grazie all’opera del giovane e brillante ricercatore e matematico salernitano Michele Mele.
Impiegando tecnologie che sfruttano un particolare sistema di algoritmi, tra l’altro già sperimentati con successo in Gran Bretagna, è stato realizzato un album per ipovedenti e non vedenti, contenente immagini a rilievo di alcune delle opere più significative del complesso su speciali fogli di polimeri che riproducono le immagini tattili bidimensionali degli affreschi, affiancati da didascalie in braille.
I visitatori possono, così, sfogliare l’album, “toccare con mano” le opere, e, al contempo, ascoltare la spiegazione della guida.
Infine, la chiesa superiore ospita periodicamente giornate di studio, concerti musicali, presentazioni di libri, rievocazioni in costume, che ne fanno un polo di attrazione culturale.
Sitografia
La chiesa di S. Maria de Lama a cura di Paola Valitutti e Barbara Visentin
www.livesalerno.com
www.ambientesa.beniculturali.it
Speranza D., Michele, il matematico che aiuta i ciechi a vedere l’arte: “La disabilità è chance” in www.ilmattino.it
D’Amico P., Michele, il matematico ipovedente “I miei algoritmi abbattono barriere” in www.corriere.it
CARLO CRIVELLI: IL TEMA MARIANO
A cura di Matilde Lanciani
Carlo Crivelli (Venezia 1430-35 - Ascoli Piceno 1494-95), artista veneziano fratello del pittore Vittore Crivelli, dopo un soggiorno a Zara, seguendo le orme di Giorgio Schiavone, giunse nelle Marche nel 1468 e vi innestò un linguaggio influenzato dalla prima formazione padovana con accenti donatelliani e tardogotici, con particolare attenzione ai dettagli preziosi tramite un segno decorativamente incisivo.
Abbiamo iniziato col ripercorrere le sue orme a Montefiore dell’Aso per arrivare ora a considerare il tema mariano della Madonna con il Bambino fra Corridonia e Macerata. Nell’articolo si tratterà della pala della Madonna che allatta il bambino (Fig.1) collocata nella chiesa dei SS. Pietro Paolo e Donato a Corridonia, e della pala della Madonna col Bambino presso il Palazzo Buonaccorsi di Macerata.
Luigi Lanzi, importante storico dell’arte italiano di origine marchigiana, del Crivelli scriveva: “È pittor degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione. Per il succo delle tinte e per un nerbo di disegno questo pittore può a buon diritto chiamarsi pregevolissimo tra gli antichi. Si compiacque d'introdurre in tutti i suoi quadri delle frutta e delle verdure, dando la preferenza alla pesca ed al citriolo; quantunque trattasse tutti gli accessori con bravura tale che in finitezza ed amore non cedono al confronto de' fiamminghi. Non sarà inutile accennare che i suoi quadri sono condotti a tempera e perciò a tratti, e sono impastati di gomme sì tenaci che reggono a qualunque corrosivo; motivo per cui si mantennero lucidissimi”[1].

Per quanto riguarda la Madonna che allatta il bambino abbiamo una tavola realizzata intorno al 1430-1500 ed attualmente visibile nel percorso espositivo “La fede dipinta e tramandata” all’interno della chiesa di S. Pietro a Corridonia, allestito con la concessione del parroco Don Fabio e curata dalla museologa Giuliana Pascucci e dall’architetto Mario Montalboddi. A livello stilistico l’opera anticipa il grande Polittico del Duomo di Ascoli del 1473 ed è simile ai due Trittici di Valle Castellana (Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno) e alla Madonna di Poggio Bretta (Museo Diocesano di Ascoli). Si tratta di una tempera di 127x63 centimetri che viene menzionata per la prima volta in un inventario del 1727 e citata come decorazione di uno degli altari laterali della ormai distrutta chiesa di S. Maria di Gesù a Corridonia. La sua realizzazione, infatti, è legata all’edificazione di questo edificio nel 1471 e alla fondazione della Confraternita del SS. Sacramento.
L’inventario esplica: “L’Altro altare di questa chiesa, che ha il titolo della Madonna della Concezione sta nella parte destra verso da piedi. Ha questo la sua buona predella, la croce davanti; in mezzo la piccola lapide, col suo sepolcrino di pietra, ed una scalinata à un sol ordine non dipinta, et adorna di semplici cornici. Il quadro di questo, quale è dipinto in tavola, rappresenta la Madonna Santissima in atto di azzinnare il Bambino Gesù, con due angioli, uno di qua, et uno di là, con molte facce di serafini di intorno alquanto guasto, e da un lato forato. L’ornamento di questo è di gesso adorno di rilievi indorati, di due Santi dipinti a destra l’uno, l’altro a sinistra, quali non si conoscono chi siano, per esser quasi guasti. In mezzo a detto ornamento vi è una descrizione che per esser guasta (come è tutto l’ornamento) appena dimostra leggibili queste parole: “EGO IMMACULATA ET CAPUT MEUM PLENUM EST RORE”. Il passo si riferisce a quello biblico del vello bagnato di rugiada di Gedeone, il quale simboleggia la Verginità di Maria[2].
La Madonna indossa un ricco e prezioso mantello, al quale si aggrappa l’infante che si volge teneramente a guardare lo spettatore (Fig.2) mentre la madre lo cinge. La visione scorciata della scena costituisce un’inquadratura molto moderna, così come lo è la dimensione umana e meno iconica rispetto alla tradizione; la psicologia dei personaggi è indagata a fondo e restituisce la loro umanità in maniera sorprendentemente fedele dal punto di vista introspettivo. L’opera, attribuita al Crivelli dai critici Cavalcaselle e Morelli, riveste un ruolo di primaria importanza nella produzione di tale artista.

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi custodiscono un’altra Madonna col Bambino del Crivelli. Il dipinto reca nel retro, su un frammento di tela ritagliata, la seguente iscrizione "KAROLUS CRIVELLUS VENETUS PINXIT 1470 FERMIS". In questo caso abbiamo un dipinto a tempera e oro su tavola trasportato su tela, di 59x41 centimetri, databile al 1470 circa che è parte superstite del perduto Polittico di Fermo.

Nel dipinto sullo sfondo astratto dorato si stagliano la Madonna a mezza figura, girata di tre quarti, e il Bambino adagiato sulle braccia della madre, che lo avvicina al viso osservando intensamente lo spettatore, già consapevole del destino del figlio. Sul manto indossato da Maria è raffigurata la stella che allude alla cometa di Betlemme ed il cardo che allude alla corona di spine, dunque alla passione. L’opera costituisce l’elemento restante di una composizione di maggiori dimensioni, forse una pala d’altare o un polittico (citato da Luigi Lanzi nel 1789) destinati all’antica chiesa maceratese di Santa Maria della Pietà, fondata da San Giacomo della Marca nel 1426 per i Minori Osservanti. Un incendio devastò l’edificio nel corso del 1799, come racconta Amico Ricci nel 1835, che però non andò completamente distrutto: la tavola di Crivelli venne in parte recuperata e ne furono salvati due frammenti. Il maggiore, quello con la Madonna col Bambino, venne tesaurizzato nel Palazzo Comunale, restaurato alla fine dell’Ottocento presso la Biblioteca Comunale, l’altro raffigurante la Pietà entrò a far parte della collezione Caccialupi, poi di quella romana di Nevin, per giungere infine al Fogg Art Museum di Cambridge. Inoltre Girolamo di Giovanni trasse dall’iconografia di questa Madonna una copia nella cappella della frazione montana di Malvezzi a Bolognola, oggi alla Pinacoteca civica di Camerino.
Note
[1] Zampetti, P., & Crivelli, C. (1986). Carlo Crivelli. Nardini.
[2] Dal catalogo Pinacoteca Parrocchiale, la storia, le opere, i contesti, 2003, pag.70.
Bibliografia
Coltrinari, F. (2011). Note e precisazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Incontri. Storia di spazi, immagini, testi, Macerata, 143-171.
De Carolis, F. (2017). Alcune considerazioni sulla prima attività di Carlo Crivelli nelle Marche. Il dossier Crivelli della Fondazione Federico Zeri. INTRECCI d'arte, 6(6).
Liberati, G., Zaccari, L., Pascucci, G., & Quintili, G. (2003). Pinacoteca parrocchiale: la storia, le opere, i contesti.
Pietro Zampetti, Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze 1986.
LA SALA DEI FASTI FARNESIANI A CAPRAROLA
A cura di Andrea Bardi
La sala dei Fasti Farnesiani
Nel secondo appuntamento dedicato al palazzo di Alessandro Farnese a Caprarola si intende fornire un approfondimento sull’ambiente che meglio di tutti riesce a tradurre visivamente i “fatti degl’uomini illustri di casa Farnese”[1], la sala detta propriamente dei Fasti Farnesiani [Fig. 1].
Ubicazione e Cronologia

La Sala dei Fasti Farnesiani, collocata al primo piano (o Nobile) del palazzo, ne riempie per buona parte il lato nordorientale, chiuso a sud dalla Cappella e a Nord dall’ Anticamera del Concilio. Inclusa nel complesso di sale detto ‘Appartamento d’Estate’ (corrispondente alla parte destra della grande mole pentagonale) e dunque frequentata dal cardinale e dai suoi illustri ospiti nei mesi più caldi dell’anno, la sua decorazione venne concepita a partire dai primi anni Sessanta del Cinquecento, in un momento in cui la grande macchina decorativa si era messa in moto relativamente da poco. Benedetta dall’arciprete della Collegiata di Santa Maria il 25 aprile 1559[2] , e ultimata nella sua ossatura architettonica al volgere del nuovo anno, l’imponente creatura, che Alessandro voleva nata dal “capriccio, disegno e invenzione”[3] del Vignola si apprestava ad essere rivestita da un manto di affreschi che si sarebbe ben presto guadagnato il ruolo di paradigma figurativo non solo nel Lazio. Una campagna decorativa di così ampia portata comportava un impegno e una supervisione costanti. Fu proprio per questo motivo che il cardinal Alessandro, incassato il rifiuto del bresciano Girolamo Muziano (1528-192)[4], e dirottato il suo sguardo verso il marchigiano Taddeo Zuccari (1529-1566)[5], pretese dall’alter Raphael [6] del secolo un monitoraggio costante del cantiere. Le condizioni contrattuali di Taddeo, fedelmente riportate da Vasari, prevedevano “dugento scudi l’anno di provisione” (cifra esorbitante ma sicuramente alla portata del cardinale più ricco del XVI secolo), ma l’artista si trovava ad essere “obbligato a lavorarvi egli stesso due o tre mesi dell’anno, et ad andarvi quante volte bisognava a vedere come le cose passavano e ritoccare quelle che non istessono a suo modo”[7]. Le prime sale interessate furono ovviamente quelle del pianterreno (o Piano dei Prelati) [8], mentre per la decorazione del Salone dei Fasti si dovette attendere il 1563. Il ritrovamento, negli anni Sessanta dello scorso secolo, del Libro delle misure del palazzo del Ill.mo e R.mo Farnese a Caprarola, effettuato da Loren Partridge presso l’Archivio di Stato di Roma, ha consentito un arretramento al 20 febbraio 1560 almeno degli studi nella compartimentazione della volta. Tra questo termine e il 15 gennaio 1561, infatti, data della terza misura (documento di pagamento) si dovette perciò procedere allo “sfondato fatto nella volta del salone” [9]. All’estate del 1563, tuttavia, come attestano alcune lettere di Alessandro Farnese (7 e 20 agosto) a Onofrio Panvinio, antiquario di corte e responsabile – insieme all’editore veneziano Paolo Manuzio – della redazione del programma iconografico della sala, alcuni pezzi risultavano ancora mancanti, come alcune iscrizioni di accompagnamento alle scene dipinte e quattro ritratti che comprendevano figure di cardinali e imperatori[10]. Entro la fine dell’anno, tuttavia, il Salone ultimato si presentava nella sua conformazione attuale.
Descrizione della Sala dei Fasti Farnesiani
La volta
La volta a specchio della Sala dei Fasti Farnesiani è, in ossequio alla tendenza all’horror vacui dei saloni pubblici del palazzo[11], interamente ricoperta da pitture a fresco ed eleganti stucchi policromi la cui fitta trama a motivi geometrici definisce i confini spaziali delle varie scene. Come notato da Hermann Voss nella capitale pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze (1920), l’impaginato della volta Farnese calca le orme della Sala Paolina in Castel S. Angelo, altra committenza farnesiana (Paolo III) portata a compimento dalla talentuosissima équipe di Perin del Vaga (1501-1547) tra il 1545 e il 1547[12]. Qui a Caprarola il centro di gravità della volta, l’antico blasone Farnese [fig. 2] a sedici gigli[13] azzurri su campo color oro, dipinto e non a stucco come nella Paolina, è arricchito da una fantasia di piume, completato da un elmo a sua volta sovrastato da un unicorno rampante e inscritto in una cornice, questa sì in stucco, dal cui interno trova posto un ricco bouquet di foglie e piccole bacche.

La “sofisticata eleganza neogotica” dell’antica arme familiare[14] è accompagnata da altri due piccoli rilievi in stucco plasmato ancora una volta per realizzare due tra le imprese più care al cardinale, il Giglio della Giustizia [Fig. 3] (in greco ΔΙΚΗΣ ΚРІΝΟΝ), rivolto in direzione del lato corto del camino, e la Freccia nel Bersaglio [Fig. 4] (il motto greco, ΒΑΛΛ’ΟΥΤΩΣ, traducibile in “colpisci così”, è ripreso da un verso dell’Iliade) rivolta invece verso il lato della Cappella.
La Freccia nel Bersaglio, la cui invenzione si deve con ogni probabilità al poeta Francesco Maria Molza[15], venne interpretata da Girolamo Ruscelli come emblema di prontezza politico-militare. Il cardinal Alessandro, del resto – che mai tenne celate le sue mire papali pur mancando ripetutamente l’obiettivo – sentiva sulle sue spalle il destino della cristianità intera. L’Europa cattolica, al tempo, era infatti attaccata su due fronti contemporaneamente: da Nord, i veementi strali antiromani di Martin Lutero avevano fatto breccia tra le popolazioni germaniche; partendo da sud-est, invece, gli Ottomani si erano spinti a ridosso delle mura di Vienna (1529) senza avere successo per poi uscirne sconfitti anche in occasione della battaglia navale di Lepanto (7 ottobre 1571). A questo fuoco incrociato, dunque, Alessandro voleva opporre – e ci provò, effettivamente, da legato di Paolo III – una politica di alleanze tra le due maggiori potenze continentali, la Francia dei Valois e l’Impero Asburgico. Difensori della cristianità anche in seguito allo scisma di Enrico VIII Tudor, i due sovrani avrebbero dovuto, nelle intenzioni del Farnese, accantonare le reciproche tensioni e mettere a disposizione i loro eserciti al servizio di una respublica christiana[16].Potere temporale e potere spirituale di nuovo uniti, dunque, sotto il segno dell’azione diplomatica dei Farnese. Un messaggio già forte come quello trasmesso dall’accostamenti dei due piccoli stucchi veniva trasformato in aperta dichiarazione d’intenti mediante i due riquadri – dipinti – con la Sovranità spirituale [Fig. 5] e la Sovranità temporale [Fig. 6], collocati sulla direttrice del lato lungo rispettivamente in corrispondenza del Giglio della Giustizia e della Freccia nel Bersaglio.
Assisa sui vapori decisamente plastici di una nube, la Sovranità spirituale, o Religione, tiene in mano una grande croce. Simile nell’impianto costruttivo generale, la Sovranità temporale, accompagnata invece da un globo terrestre, è in atto di innalzare al cielo una sfera armillare[17]. Lungo l’asse più corto si oppongono invece, in due ovali, la Fama [Fig. 7] e il Valore [Fig. 8]. La prima, in corrispondenza dell’accesso dal portico, segue il modello iconografico della Victoria Romana[18]. La monumentalità della figura femminile, ritratta in posa frontale nell’atto di suonare una tromba, è stemperata e non tradita grazie al frequente ricorso di arricciature nella definizione dei panneggi. Felice risulta inoltre l’accostamento dello stesso profilo circolare del panno che, avvolgendo il volto della figura a partire dal suo avambraccio, entra in un gioco euritmico di forme con la cornice vera e propria.
Alla Fama risponde un’allegoria del Valore [Fig. 8], che Vasari identifica con Bellona[19].I “fatti illustri” veri e propri, invece, trovano posto in sei scene corredate da iscrizioni in latino: quattro riquadri, disposti in due coppie sui lati lunghi, e due tondi, uno su ciascun lato corto, illustrano i capitoli iniziali della straordinaria (ma qui non sempre storicamente accurata) epopea dei Farnese. Sulla parete del camino, il primo tondo in ordine cronologico illustra Pietro Farnese che Fonda Orbetello.
L’iscrizione, inserita in una lapide dipinta, recita:
PETRVS FARNESIVS HOSTIBVS S ROMANAE ECCLESIAE FVSIS AC PROFLIGATIS IN VESTIGIIS COSAE VVLCIENTIVM ORBITELLVM VICTORIAE MONVMENTVM CONDIDIT ANNO SALVTIS MC
(“Pietro Farnese, avendo sconfitto e scacciato il nemico della chiesa, fonda a memoria della sua vittoria la città di Orbetello sulle rovine di Cosa, che apparteneva a Volci, nell’anno della salvezza 1100”)
L’evento, narrato da Onofrio Panvinio nella Vita di Paolo III, risulta una completa invenzione dello storico[20], il cui ricorso alla manipolazione della verità storica, ben lungi dal rimanere circoscritto a episodi sporadici, appare nella Sala quanto mai sistematico. In ogni caso, nonostante il formato, inusuale per scene di guerra, e le dimensioni ridotte, Taddeo riesce nell’impresa di far entrare lo spettatore direttamente nel cuore dell’evento. L’arrivo da destra dei reparti di cavalleria, guidati proprio da Pietro, coglie impreparati i “nemici della Chiesa”, riversi a terra sui loro scudi, in una concitazione che, se da un lato riporta alla mente il groviglio di corpi e di scudi della Battaglia di Ponte Milvio, dall’altro ne stempera decisamente le asprezze cromatiche livellando il tutto su una dominante pastello che sarà uno dei leitmotiv di tutto lo spazio della volta. La seconda scena frescata dallo Zuccari, sulla parete opposta, è invece quella con Guido Farnese che porta la pace ad Orvieto.
Il testo dell’iscrizione stavolta è:
GVIDO FARNESIVS VRBISVETERIS PRINCIPATVM CIVIBVS IPSIS DEFERENTIBVS ADEPTVS LABORANTI INTESTINIS DISCORDIIS CIVITATI SEDITIOSA FACTIONE EJECTA PACEM ET TRANQVILLITATEM RESTITVIT AN MCCCXIII
(“Guido Farnese, divenuto principe di Orvieto su richiesta dei cittadini, espulse la fazione sediziosa e riportò pace e tranquillità alla città che era stata turbata da discordie interne nell’anno 1313”).
Guido, mai eletto principe di Orvieto (fu invece vescovo), è l’assoluto protagonista della scena. Seduto su di un alto podio, e tenendo in mano uno scettro, il Farnese colpisce per il senso di sicurezza, al limite della spavalderia, che traspare dai suoi occhi e che risulta confermata dagli sguardi di prostrazione ad esso riservati tanto dalla popolazione di Orvieto, sulla sinistra, quanto dal gruppo di dignitari sul lato opposto. Nella terza scena, sulla parete esterna, il protagonista è Pietro Niccolò Farnese che libera Bologna dall’assedio dei Visconti [Fig. 9].

Questo il testo dell’iscrizione:
PETRVS NICOLAVS FARNESIVS SEDIS ROMANAE POTENTISSIMIS HOSTIBVS MEMORABILI PRAELIO SVPERATIS IMMINENTI OBSIDIONIS PERICVLO BONONIAM LIBERAT AN SAL MCCCLXI
(“Pietro Niccolò Farnese, sconfitto un nemico estremamente potente per la Santa Sede in una battaglia memorabile, libera Bologna dal pericolo imminente di un assalto nell’anno di salvezza 1361”).
La maggiore dimensione dello spazio, in aggiunta al formato rettangolare, risulta, in questo caso, vantaggiosa a Taddeo che, per inscenare la liberazione di Bologna all’interno del conflitto che vedeva opposti l’esercito pontificio del cardinal Egidio Albornoz e il Ducato di Milano, sfrutta appieno le suggestioni visive che Francesco Salviati aveva lasciato su una delle pareti dell’omonima stanza nel palazzo di Alessandro a Roma[21](Vittoria di Pietro e Ranieri Farnese sui Pisani).

I rimaneggiamenti storici continuano nella scena con Pietro Farnese che entra trionfante a Firenze [Fig. 10] – anche se in questo caso la verità storica viene fatta semplicemente slittare di un anno[22] – e negli ultimi due riquadri (Ranieri Farnese messo a capo dell’esercito fiorentino; Ranuccio Farnese viene nominato capitano generale della Chiesa). L’entrata nella città va letta da destra a sinistra: lo sfondo cittadino, che occupa la metà superiore sinistra, è circondato su ogni lato dai reparti di cavalleria, le cui lance creano una sorta di palizzata che riporta al Quattrocento cavalleresco di Paolo Uccello[23]. Nel riquadro di Ranieri, invece, l’iscrizione, che recita
RAINERIVS FARNESIVS A FLORENTINIS DIFFICILI REIPVBLICAE TEMPORE IN PETRI FRATRIS MORTVI LOCVM COPIARVM OMNIVM DVX DELIGITVR ANNO CHRISTI MCCCLXII
(“Ranieri Farnese è scelto dai Fiorentini in un periodo difficile per la repubblica come comandante dell’esercito al posto del defunto fratello Pietro nell’anno del signore 1362”).
lascia intravedere due errori storici. Il primo riguarda il nome del protagonista. Ranuccio, infatti – e non Ranieri – era il suo nome, cambiato con ogni probabilità per non far confondere lo spettatore con il protagonista della scena successiva[24]. Il secondo, invece, è di collocazione temporale dell’evento: Ranieri/Ranuccio rimpiazzò infatti Pietro solo nel 1363. Nel riquadro il comandante in capo delle guarnigioni fiorentine è ritratto, fresco di nomina, su di un trono rialzato e circondato da una piccola corte di personaggi che gli riservano tutti gli onori del caso: in primo piano, il portastendardo sventola una grossa bandiera sulla quale campeggia fiero il giglio fiorentino; sulla destra, anche un anziano cardinale rivolge lo sguardo allo spettatore. I due pilastri a semicolonne scanalate chiudono la composizione creando una quinta architettonica che, assieme al profilo statuario di un satiro sulla destra, mantiene – nonostante le policromie marmoree forniscano un immediato rimando al contesto toscano – una certa connessione con il mondo antico. Per la scena con Ranuccio Farnese viene nominato capitano generale della Chiesa, Panvinio compone la seguente iscrizione:
RANVTIVS FARNESIVS PAVLI III PAPAE AVVS AB EVGENIO IV P M ROSAE AVRAE MVLIERE INSIGNITVS PONTIFICII EXERCITVS IMPERATOR CONSTITVITVR ANNO CHRISTI MCDXXXV (“Ranuccio Farnese, nonno di Papa Paolo III e insignito della rosa d’oro da Papa Eugenio IV, è nominato comandante dell’armata papale nell’anno del Signore 1435”).
L’episodio dell’elezione di Ranuccio Farnese a gonfaloniere della Chiesa rimane, al netto delle rielaborazioni dello storico di casa Farnese, ancora da provare sul piano documentario. In ogni caso, anche qui la data risulta forzata, essendo la carica in quell’anno ricoperta da Francesco Sforza[25]. Strutturalmente, l’episodio ruota attorno a una diagonale ideale che, rinforzata dai profili emiciclici della scalinata vista da sinistra, continua con la spada di Ranuccio per esaurire la sua forza nel gioco di sguardi tra il capitano dell’esercito e il pontefice stesso. Nella scena anche una piccola finestra quadrata, pretesto sfruttato appieno da Taddeo per l’inserzione di un delicato brano paesistico.
Note
[1] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, p. 701.
[2] S. Mascagna, Caprarola e il palazzo Farnese. Cinque secoli di storia, p. 39; al 31 Maggio dello stesso anno Vignola “dovette trovare una fabbrica già iniziata [...]Su una base di tufo non scavata si alzavano i cinque muri perimetrali per l’altezza di un piano e i cinque bastioni con stanze dentro (che furono poi modificate), una porta e cinque finestre nella facciata principale (poi rimosse) e qualche parete interna” (I. Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, p. 93).
[3] Vasari, pp. 700-701.
[4] Ibidem.
[5] Taddeo era, negli anni Sessanta, uno dei pittori più in voga a Roma (C. Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of the arts, p. 239).
[6] Tanto da farsi seppellire nel Pantheon affianco all’Urbinate. Vasari, p. 699: “fu da Federigo data Sepoltura a Taddeo, nella Ritonda di Roma vicino al Tabernacolo dove è sepolto Raffaello da Urbino del medesimo stato. E certo sta bene l’uno a canto all’altro, percioche si come Raffaello d’anni 37 & nel medesimo dì, che era nato morì cioè, il Venerdì Santo, così Taddeo nacque a di primo di settembre 1529 & morì alli dui dello stesso mese l’anno 1566.”
[7] Ivi, pp. 692-693. La vita di Taddeo (B. Agosti, sulla biografia vasariana di Taddeo Zuccaro, p. 139) venne redatta a partire dal 1 marzo 1567. A testimonianza, una lettera scritta dall’aretino a Vincenzio Borghini.
[8] P. Portoghesi, Caprarola, p. 55. Taddeo aveva in primis decorato le Sale delle Stagioni al pianterreno per poi passare al soffitto della Sala di Giove.
[9] L. Partridge, Divinity and Dynasty at Caprarola: Perfect History in the Room of Farnese Deeds, p. 494, nota 1.
[10]I ritratti erano del Cardinal Alessandro Vitelli, del Monsignor Luigi di Guisa, dell’imperatore Ferdinando I e di Massimiliano II.
[11] Le stanze private del cardinale erano, al contrario, decorate solo sulla volta.
[12] H. Voss, La pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze, p. 282.
[13] Il numero dei gigli, al tempo del cardinale, era stato abbassato a sei.
[14] Faldi, p. 263.
[15] Partridge, p. 496.
[16] Partridge, p. 496.
[17] Per questa Allegoria un disegno preparatorio, a matita rossa e nera, è custodito presso la Biblioteca Reale di Torino.
[18] Ivi, p. 499.
[19] Vasari, p. 701.
[20] Partridge, p. 499.
[21] Partridge, p. 503.
[22] L’evento avvenne nel 1363 e non nel 1362.
[23] Si veda a proposito Portoghesi, p. 58: “I momenti storici che si vogliono richiamare alla vista sono rivissuti con lo spirito neofeudale [...] che il casato farnesiano stava recuperando”.
[24] Partridge, p. 504.
[25] Ibidem.
Bibliografia
Agosti, sulla biografia vasariana di Taddeo Zuccaro, in “Prospettiva”, 153/154, Firenze, Centro Di della Edifimi, 2014, pp. 136-157.
Faldi, Il palazzo Farnese di Caprarola, Torino, SEAT, 1981.
Labrot, Le Palais Farnese de Caprarola, Parigi, Klincksieck, 1970.
Mascagna, Caprarola e il palazzo Farnese. Cinque secoli di storia, Viterbo, Quatrini, 1982.
Partridge, Divinity and Dynasty at Caprarola: Perfect History in the Room of Farnese Deeds, in “The Art Bulletin”, 60, New York, 1978, pp. 494-530.
Pierguidi, Disegnare e copiare per imparare: il trattato di Armenini come fonte per la vita di Taddeo Zuccari nei disegni del fratello Federico, in “Romagna Arte e Storia”, 92/93, Rimini, Panozzo, 2011, pp. 23-32.
Portoghesi (a cura di), Caprarola, Roma, Manfredi, 1996.
Robertson, Il Gran Cardinale. Alessandro Farnese patron of arts, New Haven-Londra, Yale University Press, 1992.
Trasmondo Frangipani, Descrizione storico-artistica del r. palazzo di Caprarola, Roma, coi tipi della civiltà cattolica, 1869.
Vecchi, P. Cimetta, Il palazzo Farnese di Caprarola, Caprarola, Il Pentagono, 2013.
Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568.
Voss, La pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze (1920), Roma, Donzelli, 1994.
Sitografia
http://www.bomarzo.net/palazzo_farnese_caprarola_04_sala_fasti_farnesiani_it.html
https://www.britannica.com/biography/Taddeo-Zuccaro
www.culturaitalia.it
https://www.rocaille.it/villa-farnese-a-caprarola-pt-1/
GIULIO PAOLINI E L'ARTE CONCETTUALE
A cura di Gianmarco Gronchi
Introduzione: un guardare nello specchio fino al momento in cui.
«L’eco delle immagini dell’arte antica è sovente il motore del primo passo verso ciò che però dobbiamo cercare oltre quel dato. Se prevalga la memoria della cosa o il desiderio di superarla, questo non saprei valutarlo. Però, è impossibile negare che ci sia una specie di filtro di trasparenza, che ci consente di guardare al di là. Aprire una finestra sul vuoto non provoca molte emozioni o desideri. Ma se il vano della finestra è impaginato su qualcosa che interferisce col vuoto, la visione si fa più attraente, mi consente di vedere oltre la traccia già esistente»1. Con queste parole Giulio Paolini, uno dei maggiori esponenti internazionali della corrente ribattezzata Arte Concettuale, descrive il suo rapporto con i maestri del passato. Nel 1967, su «Artforum», Joseph Kosuth, altro famoso artista concettuale, scriveva che «quando un artista utilizza una forma concettuale, vuol dire che tutte le programmazioni e decisioni sono stabilite in anticipo e l’esecuzione è solo una faccenda meccanica»2.
La definizione di concettuale che Kosuth offre fornisce una chiave di lettura sintetica e funzionale anche per tutto il lavoro di Paolini. Accomunato al filone dell’Arte Povera, sebbene con posizioni molto personali, Paolini è uno degli artisti che più di altri si è interrogato sul rapporto tra arte antica, arte classica e arte contemporanea. L’esordio nel 1960 è subito contrassegnato da una forte componente di riflessione analitica sullo statuto dell’arte e i suoi strumenti, ma è l’anno della sopracitata definizione di Kosuth, il 1967, quando l’artista italiano inizia a lavorare sui dipinti del passato:
«[lavorare su una forma citazionista dei maestri del passato è] una fase che comincia nel 1967, prosegue e per certi versi non mi ha più abbandonato. È stata una svolta abbastanza decisiva nel mio lavoro, in qualche modo predestinata perché fin dall’inizio ho sempre parlato d’arte come storia, come dimensione, affrontando i materiali, l’essenzialità della stessa. Dalla panoramica sugli strumenti sono approdato alle immagini dell’arte, alle visioni che, come in uno specchio, si riflettevano nei miei quadri»3.
Giulio Paolini e il confronto con i grandi della pittura
Il 1967 è infatti l’anno di Giovane che guarda Lorenzo Lotto. È uno dei primi confronti diretti tra Paolini e la pittura a olio del XVI secolo. Il Ritratto di giovane, opera di Lotto datata 1506 e conservata oggi agli Uffizi, viene stampata sulla tela, in bianco e nero e a dimensioni naturali. In questo caso il rapporto stabilito con l’artista cinquecentesco non è formale né tecnico, quanto mentale.
Cala la parete di distanza spazio-temporale e lo spettatore diventa, per il tempo della visione, Lorenzo Lotto. Attraverso uno sfasamento cronologico, chi guarda è introdotto in una dimensione di realtà che supera l’apparenza fisica del dipinto. Come scrive lo stesso autore, «a un certo punto non saprete più distinguere se siete voi a guardare l’opera o se, invece, è l’opera a spiare il vostro sguardo» 4.
Ruolo centrale è occupato dal titolo, che Paolini considera alla stregua, e forse più importante, dell’opera stessa, per la sua capacità di sintetizzare l’idea, il concetto sotteso all’opera, fulcro artistico dell’operazione. In questo modo l’autore si interroga su quale sia il processo generativo e conoscitivo dell’immagine, con una conseguente messa in discussione dello statuto dell’hic et nunc dell’opera d’arte e anche del concetto di autorialità. Chi guarda non è qui e non è ora, ma è nel 1506 davanti alla tela appena conclusa da Lotto. Allo stesso modo, Paolini diventa anch’egli Lotto, e l’opera è, quindi, anche una riflessione sul conoscere e sul conoscersi. In questo processo, il medium fotografico rappresenta un aspetto fondamentale. La fotografia infatti serve, come spiega l’artista, per «appropriarsi, attraverso il tempo, di una situazione che non si è vissuta nel reale, ma che si recupera attraverso il linguaggio» 5.
l risultato è «un’immagine nuova che non riesce a liberarsi della propria memoria» 6.
Giulio Paolini: immagine e tempo
Immagine che diventa memoria, quindi, e memoria che diventa tempo, tempo sovvertito e riscritto. Tempo che si mortifica nel non-tempo, annullando le distanze e offrendo l’illusione di un eterno presente. Tutto è fuori dal tempo. «Niente tempo. Il tempo dell’orologio, o dell’uomo, è trascurabile. In arte non c’è né antico né moderno, né passato né futuro. Un’opera d’arte è sempre del presente. Il presente è il futuro del passato, non il passato del futuro» 7.
È proprio con le inedite capacità del medium fotografico che Paolini, soprattutto nel biennio 1967-68, crea e riflette sul ruolo dell’artista e sul fare arte. Esemplificativo a questo proposito è L’ultimo quadro di Velazquez, tela con stampa fotografica del 1968, la cui didascalia riporta «l’invisibilità che esso supera non è quella di ciò che è occultato: non aggira un ostacolo, non svia una prospettiva, si rivolge a quanto è reso visibile sia dalla struttura del quadro sia dalla sua esistenza come dipinto». In quest’opera, Paolini si confronta con Las Meninas, opera velazqueña del 1656. L’artista genovese raffigura a stampa sulla sua tela il celeberrimo dettaglio con il ritratto allo specchio del re spagnolo Filippo IV e consorte. L’immagine però è speculare rispetto alla tela di Velazquez, di modo che il re risulti sulla sinistra. Il rovesciamento dell’originale, portato in grandezza al vero, fa sì che l’opera sia «un fac-simile dell’opera che lo spagnolo aveva davanti a se stesso» 8.
Torna ancora la tangenza tra autore e autore, tra Paolini e Velazquez, in questo caso. Ma anche tra pubblico e pittore.
Significativo, in quest’opera, che il dettaglio scelto da Paolini sia la coppia in posa. Vediamo cioè l’arte nel suo farsi, il compimento della pittura che sta nascendo, adesso, davvero, qui e ora. Altra opera che si muove sugli stessi binari sottili di camuffamento, di messa in discussione della percezione, è Lo studio, sempre del 1968.
Qui il close-up di Paolini si focalizza sull’opera che il pittore ha sul cavalletto nella famosa tela di Vermeer L’allegoria della pittura, datata circa 1666. Ancora, il soggetto dell’arte è l’arte stessa, che diventa tema tautologico che gioca ad autodefinirsi, da un’epoca all’altra, da una tela a un’altra. Non a caso, il dettaglio viene prelevato proprio da un’opera in cui si vuole vedere, a sua volta, una rappresentazione allegorica della pittura. Un’allegoria dell’allegoria, quasi, in cui Paolini si cala nei panni dell’olandese del Seicento. Spiega Celant che «l’istanza è quella di offrire un’immagine categoriale dell’autore, senza aggiungere la nuova identità, Paolini stesso, che assimilando il ruolo degli autori già esistiti, vi si identifica come categoria» 9.
Infine, a chiusura di questa speculazione atemporale e labirintica sul fare e sul vedere artistico, si guardi Nel mezzo del dipinto Flora sparge i fiori, mentre Narciso si specchia in un’anfora d’acqua tenuta dalla ninfa Eco, ancora del 1968. L’opera che Paolini analizza è un olio di Nicolas Poussain, Il regno di Flora, datato 1631 circa e conservato a Dresda. La tela dell’artista italiano è ora un ricettacolo di triplici rimandi tra l’opera in sé, l’opera di Poussain riprodotta e di nuovo lo stesso dettaglio di Poussain, riproposto ancora, più piccolo, dentro la riproduzione precedente. In questo modo Flora si trova due volte al centro del quadro.
Come spiega Giovan Battista Salerno, però, «una volta è la figura allegorica che abita lo spazio prospettico della rappresentazione, lo spazio convenzionale al quale Poussin l’ha consegnata e cioè si trova al centro di una scena profonda fino all’orizzonte, fino alle nuvole e al cielo che le fanno da sfondo; e un’altra volta si trova proprio al centro dello spazio materiale del dipinto, un centro calcolato in rapporto alle dimensioni della tela, e si veste della sua qualità di frase pittorica costituita di segni organizzati su una superficie bidimensionale».10 Flora, quindi, non è solo un’immagine, non in maniera assoluta almeno, perché è anche la porzione di spazio calcolata matematicamente in cui Paolini l’ha situata. È questo, quindi, il paradosso della rappresentazione e della sua stessa contraddittorietà, che per Paolini è insito nella pittura.
Se è vero che per Paolini «è inutile e vano inventare qualcosa di proprio […] se possiamo scoprirlo nel passato»,11 allora si deve accettare che l’invenzione assoluta – e anche l’unica possibile – è quando la creazione si riduce a identificazione. In questo senso, quindi, l’operazione messa in atto da Paolini è rendere visibile l’atto stesso della visione, in una dimensione in cui lo spazio non ha misure e il tempo non scorre, poiché infiniti e eterni. Allora, l’arte diventa una meta-riflessione su se medesima, un guardare nello specchio le sue fondamenta ontologiche, perfette perché già date e immutabili, fino al momento in cui[.]
Note
1 Paolini in V. TRIONE (a cura di), Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea, Electa, Milano 2013, p. 176.
2 AA. VV., Arte contemporanea, Electa, La biblioteca di Repubblica-L’Espresso, Milano 2018, vol. III, p. 28.
3 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei, Skira, Milano 2006, p. 174.
4 AA. VV., Arte contemporanea cit., p. 33, didascalia.
5 Giulio Paolini 1960-1972, a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2003, p. 188.
6 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei cit., p.174.
7 Paolini in Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 50.
8 Cfr. Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 244.
10 G.B. SALERNO, L’invenzione di Paolini, in «Art Dimension», Roma, luglio - settembre 1975, n. 3, pp. 20-22, in particolare p. 20.
11 Paolini in ibidem.
Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.
LA MAUSOLEA: LA VILLA-FATTORIA CAMALDOLESE
A cura di Alessandra Becattini
Introduzione
In Casentino, tra Soci e Partina, in provincia di Arezzo, è possibile visitare una villa dalla storia speciale: la Mausolea (fig. 1). Questa struttura, di proprietà dei camaldolesi, oggi accoglie la sede dell’associazione "La Grande Via", dedita alla promozione e all’insegnamento di un approccio consapevole al benessere, fisico e mentale; ma in origine aveva tutt’altra funzione.

La Mausolea
Come si è potuto leggere negli articoli precedenti, la comunità camaldolese era strettamente collegata al territorio. Tutta la congregazione dipendeva dall’Eremo, dove gli anacoreti vivevano una vita esclusivamente dedita allo studio e alla contemplazione divina. La strutturazione del Monastero poi contribuiva al loro sostentamento e ne filtrava i rapporti con la società esterna. I monaci, oltre che alla vita religiosa, erano altresì dediti ad una intensa attività lavorativa; infatti potevano mantenersi con la produzione diretta di ortaggi e con la raccolta e distribuzione attenta del legname prodotto dagli abeti dalla foresta che abitavano. Tuttavia un insediamento a più di 800 m d’altitudine non poteva offrire molto altro e quindi, seguendo le esigenze di una comunità in continua espansione, i camaldolesi si avvalsero delle produzioni generate da possedimenti fondiari e terrieri, prevalentemente frutto di riscatti, donazioni o lasciti.
Proprio con questa funzione nasce la villa della Mausolea, la cui lunga storia evolutiva è articolabile in tre fasi. Un documento della fine dell’XI secolo testimonia la cessione di un terreno con querceto e un casale, denominato “Musileo”, agli eremiti di Camaldoli: siamo di fronte alla nascita della prima cellula della Mausolea, che dal toponimo di questo possedimento prende il nome [1]. I terreni attorno al casolare furono utilizzati come campi per la coltivazione di derrate alimentari e per il pascolo. Nello specifico, la presenza del querceto indica la possibile esistenza di un allevamento di suini, la cui carne si prestava molto bene ad essere conservata più a lungo con la produzione di salumi e insaccati [2]. Indispensabile per le esigenze di una comunità monastiche era inoltre la produzione di vino ed infatti, fin dai primi documenti, nella tenuta è attestata la presenza di un vigneto [3].
Col tempo vennero ampliati i possedimenti e le produzioni, e i nuovi terreni coltivabili acquisiti da Camaldoli andarono a creare plurime realtà agricole attorno al casale principale. Si formò così una vera e propria grangia (o grancia), cioè una fattoria direttamente dipendente da una comunità monastica. Inoltre, è in questo periodo che nei documenti storici il toponimo inizia a cambiare, ottenendo il genere femminile “Musilea” verosimilmente perché riferito alla casa rurale, alla fattoria [4]. La definitiva trasformazione in “azienda agricola” è attestata dai documenti del Catasto del 1446, dove si evince che “alla Musolea” [5] risiedeva stabilmente un gruppo di monaci camaldolesi, per seguire direttamente le produzioni agricole della fattoria, e che il complesso era formato da più abitazioni collegate tra loro, tra cui una adibita a deposito del raccolto. In questo periodo, oltre alla coltivazione di ortaggi e alla vinificazione, venivano prodotti formaggi e, di conseguenza, erano allevati anche animali per la produzione del latte. Nella fattoria venivano poi coltivati cereali come grano e farro, macinati nel mulino di Soci, di proprietà dei camaldolesi stessi già dalla fine del XIII secolo [6].
Alla fine del XV secolo, dunque, la Mausolea aveva ormai assunto la sua forma definitiva di grangia e, grazie alla strategica collocazione su importanti vie di comunicazione, aveva assunto una forte importanza produttiva ed economica per la comunità di Camaldoli. Protagonista di una nuova stagione della storia evolutiva della Mausolea fu il nobile veneziano Pietro Dolfin, generale dell’ordine camaldolese dal 1480. Il giovane monaco umanista, animato da una accesa e convinta spiritualità, voleva avvicinare gli appartenenti all’ordine ad una osservazione più rigorosa della regola monastica [7]. Nella sua visione, il contatto con il mondo agreste era un pilastro fondamentale del vivere cenobitico e proprio per questo decise di dedicarsi con cura ed attenzione allo sviluppo e al mantenimento della villa-fattoria.
Il Dolfin, sostenuto ed aiutato dal monaco Basilio Nardi, sviluppò così l’idea di realizzare una Mausolea completamente nuova dalle fondamenta. Il progetto era quello di creare un edificio che, oltre ad avere la funzione di base di controllo per dirigere tutte le attività della fattoria, fosse anche una dimora per i camaldolesi e un luogo di ospitalità per autorità in visita.
Dalle numerose lettere del Dolfin che ci sono pervenute, oltre ad una onesta considerazione per la sua comunità, traspare anche un interessamento più personale nell’esecuzione di questa villa, che difatti diventerà poi dimora stabile del superiore generale, il suo luogo prediletto per un ritiro fisico e spirituale.
Il grandioso progetto, accettato con reticenza dalla comunità di Camaldoli, prese inizio nel 1492 e terminò due anni dopo. Per seguire attentamente tutte le fasi di realizzazione dell’edificio, il fidato Nardi venne nominato gubernator, cioè direttore dei lavori [8]; invece è tuttora ignoto il nome dell’architetto che la progettò. Attualmente della villa del Dolfin rimangono soltanto alcune tracce delle fondamenta perché i materiali utili vennero riutilizzati per la costruzione del nuovo palazzo del XVII secolo. Ad oggi, negli archivi non sono stati rinvenuti progetti, piante o disegni che potessero trasmetterci la sua rappresentazione, ma possiamo immaginare che fu costruita all’insegna della magnificenza. Alcune caratteristiche strutturali sono tuttavia desumibili dalle lettere del suo ideatore e dai successivi documenti catastali. La villa era caratterizzata da un atrio doppio, una cappella per la devozione e una cantina, con cella vinaria, che si espandeva interrata per tutto il perimetro dell’edificio [9]. Il palazzo presentava poi “due palchi e sale, con diverse camere ed altri ambienti abitativi […]”, oltre che una piazza, un pozzo e una stalla per gli animali da tiro e da soma [10].
Nonostante il grande impegno del Dolfin nel realizzare l’opera, la villa non ebbe lunga vita. Infatti, a poco più di un secolo di distanza le strutture erano già gravemente compromesse a causa dell’instabilità del terreno sottostante. Considerata ormai un’attività di vitale importanza per la comunità, il capitolo dell’Eremo decretò così che si intervenisse drasticamente con l’edificazione ex novo di una terza Mausolea.
La villa-fattoria venne ricostruita su un terreno più pianeggiante, poco distante dalla precedente, e i lavori si protrassero dal 1647 al 1650. A dirigere attivamente la fabbrica fu Padre don Simeone da Cremona, prima priore dell’Eremo e poi eletto camerlengo.
Come già anticipato, i materiali da costruzione furono recuperati dal vecchio edificio quattrocentesco del quale, però, si volle mantenere la memoria: sulla facciata nord dell’attuale villa fu collocato uno stemma proveniente dal palazzo del Dolfin. Il rilievo marmoreo (fig. 2), recentemente restituito da Alfredo Bellandi a Gregorio di Lorenzo, che per gli eremiti aveva già lavorato trentadue anni prima, rappresenta al centro lo stemma dei camaldolesi, costituito da due colombe che si abbeverano al medesimo calice, sorretto da due delfini [11]. La presenza di questi mammiferi marini rende l’opera un omaggio al committente della villa poiché erano l’emblema araldico del Dolfin stesso. Sotto la cornice dal gusto spiccatamente classicista, decorata con un motivo ad ovuli e dentelli, i camaldolesi ricavarono uno spazio per apporre una lastra con incisa la data del termine dei lavori della nuova villa (1650).

Anche per questo cantiere i documenti archivistici a disposizione sono pochissimi, né sono noti i nomi dell’architetto o delle maestranze che presero parte al progetto. In questo caso, però, la struttura si è conservata fino ad oggi, rendendo più facile la descrizione.
L’entrata della villa è preceduta da una scalinata a ventaglio e da un pizzale lastricato, al quale attualmente si accede superate le mura di cinta tramite un portale in pietra della fine del XVIII secolo (fig. 3). Il fabbricato, compatto ma elegante, si sviluppa su quattro livelli, di cui uno seminterrato adibito a cantina, come nella vecchia grangia [12]. La facciata principale (fig. 4) è estremamente semplice nella sua simmetria, impreziosita dalla loggia a tre fornici del piano nobile. Entrando dal portone centinato, con stemma camaldolese centrale, si trova un grande atrio voltato a botte, dal quale si accede a due cappelle.
Quella di destra, decorata alle pareti con finte specchiature marmoree, presenta un altare con un quadro settecentesco con San Romualdo (fig. 5). In quella di sinistra troviamo un secondo piccolo altare con una pala squisita rappresentante la Madonna del Rosario in gloria tra i Santi Romualdo e Michele Pini (fig. 6), attribuita da Liletta Fornasari al pittore bolognese Emilio Taruffi [13]. Un particolare di questa tela suggerisce che l’opera possa essere stata commissionata direttamente dalla comunità di Camaldoli: una piccola rappresentazione dall’alto dell’Eremo è indicata infatti dai due santi al centro della composizione (fig. 7).
L’esecuzione della cornice in stucco dorata, modanata con volute e cherubini, è stata restituita da Riccardo Spinelli al fiorentino Lorenzo Merlini [14].
Tra i locali del palazzo, il più importante è certamente il salone (fig. 8) a doppio volume collocato al piano nobile: oggi adibito a sala conferenze, l’ampio ambiente dal soffitto cassettonato accoglie due grandi opere. Sulla parete sinistra si trova la tela con Triboniano consegna le pandette a Giustiniano (fig. 9), eseguita da Vicenzo Camuccini, esponente del Neoclassicismo romano. Di fronte si conserva l’Incoronazione della Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo (fig. 10), una grande pala che fino agli inizi del XX secolo era posizionata sull’altare maggiore della chiesa dell’Eremo di Camaldoli. La sua esecuzione fu commissionata al pittore Niccolò Cassana dal principe Ferdinando de’Medici in persona, il quale la donò agli eremiti in cambio di un’opera di Annibale Carracci appartenuta al cardinale Odoardo Farnese[15]. La struttura lignea che possiamo vedere oggi attorno alla tela è quella originaria ed è stata attribuita da Riccardo Spinelli a Paolo Manacorti, su disegno di Giovanni Battista Foggini [16].
Note
[1] B. Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, pp. 42-43.
[2] Ivi, p. 45.
[3] Ivi, pp. 45-47.
[4] Ivi, p. 54.
[5] Ivi, p. 56.
[6] Ivi, p. 59.
[7] Raffaella Zaccaria - Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, Roma, 1991
[8] B. Buratti, La casa delle Vigne … cit., p. 76
[9] Ivi, p. 80
[10] A. Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, p. 19.
[11] Ivi, pp. 21-22.
[12] S. Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), tesi di Laura, Università degli Studi di Firenze, a.a. 2002/2003, p. 129.
[13] L. Fornasari, Le prime stanze del collezionismo moderno nell’aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, Edifir, Firenze, 2003, p. 243.
[14] R. Spinelli, La decorazione a stucco ad Arezzo e nel territorio aretino, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, p. 37.
[15] S. Buricchi, Niccolò Cassana. La trinità in gloria incorona la Vergine con i Santi Benedetto e Romualdo, in Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, pp. 334-335.
[16] R. Spinelli, Tracce per la scultura del Settecento in terra aretina, in Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, pp. 141-143.
Bibliografia
Il Seicento in Casentino: dalla Controriforma al Tardo Barocco, catalogo della mostra (Poppi, Castello dei Conti Guidi, 23 giugno- 31 ottobre 2001), a cura di L. Fornasari, Firenze, 2001.
Arte in terra d’Arezzo: il Seicento, a cura di L. Fornasari-A. Giannotti, Firenze, Edifir, 2003
Landi, La villa-fattoria della Mausolea in Casentino. Un esempio di gestione del territorio dei monaci di Camaldoli (sec. XVII - XVIII), Tesi di Laura, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze, Anno Accademico 2002/2003
Arte in terra d’Arezzo: il Settecento, a cura di L. Fornasari-R. Spinelli, Firenze, Edifir, 2007
Buratti, La casa delle Vigne. Appunti per una storia della Mausolea in Casentino, Soci, Fruska, 2012.
Bellandi, “Uno stemma di Gregorio di Lorenzo per il generale camaldolese Pietro Dolfin alla Mausolea di Soci”, in Nuovi studi, 22, 2016, pp. 17-24.
CARLO CRIVELLI E IL TRITTICO DI MONTEFIORE
A cura di Arianna Marilungo
Introduzione. Carlo Crivelli e la committenza francescana nelle Marche: il caso del trittico di Montefiore dell'Aso
“[ Carlo Crivelli ] È pittor degno che si conosca per la forza del colorito più che pel disegno; e il suo maggior merito sta nelle piccole istorie, ove mette vaghi paesetti, e dà alle figure grazia, movenza, espressione, e talora qualche colore di scuola peruginesca. Quindi qualche sua opera è passata in certi tempi per lavoro di Pietro, come udii di quella di Macerata. […]
Ciò che più monta, si è che per il succo delle tinte e per un nerbo di disegno questo pittore può a buon diritto chiamarsi pregevolissimo fra gli antichi. Si compiacque d'introdurre in tutti i suoi quadri delle frutta e delle verdure, dando la preferenza alla pesca ed al citriolo; quantunque trattasse tutti gli accessorj con bravura tale che in finitezza ed amore non cedono al confronto de' fiamminghi. Non sarà inutile l'accennare che i suoi quadri sono condotti a tempera e perciò a tratti, -e sono impastati di gomme sì tenaci che reggono a qualunque corrosivo, motivo per cui si mantennero lucidissimi.” (Luigi Lanzi, Storia pittorica della Italia dell'abate Luigi Lanzi antiquario della R. Corte in Toscana).
Il breve estratto appena riportato è la prima vera fonte storico-critica relativa all'arte di Carlo Crivelli, artista vissuto nel XV secolo, veneziano di nascita ma marchigiano d'adozione. L'abate Luigi Lanzi (Treia, 14/06/1732 – Firenze, 30/03/1810) fu il primo vero studioso del Crivelli e ne tentò un recupero della personalità dopo secoli di oblio. Questo grande pittore, infatti, ha attraversato secoli di silenzio e dimenticanza: non è stato citato neanche dagli storici veneziani a lui contemporanei. La mancanza di notizie sulla vita del Crivelli e la dispersione delle sue opere hanno provocato l'assenza del Crivelli anche nelle “Vite” del Vasari, che probabilmente non lo conobbe né vide le sue tavole: nel XVI secolo queste erano ancora intatte, sparse nei piccoli paesi marchigiani e costituivano oggetto di devozione popolare quindi lontane da ogni interesse di critica storico-artistica[1].
La vita e le opere
Prima del Lanzi solo i veneziani Ridolfi e Boschini citano il Crivelli, ricordandone alcune opere giovanili lasciate a Venezia, ma oggi perdute. L'esodo delle opere crivellesche verso Roma iniziò già ai tempi del Lanzi quando l'alta gerarchia ecclesiastica iniziò la sistematica spoliazione delle chiese marchigiane.
Poche sono le notizie relative alla sua vita: Carlo Crivelli nasce a Venezia negli anni tra il 1430 ed il 1435, figlio di Jacopo Crivelli, anch'egli pittore. Gli anni della sua formazione non risultano ben documentati, ma è probabile che Carlo appartenesse a quel gruppo di pittori legati alla tradizione tardo-gotica attivi alla scuola dello Squarcione: Mantegna, Schiavone, Marco Zoppo, Gentile e Giovanni Bellini e Bartolomeo Vivarini.
Il 5 marzo 1457 viene condannato a 6 mesi di carcere e 200 lire di multa per aver condotto a casa propria Tarsia, una donna sposata con cui aveva convissuto per lungo tempo. Da questo episodio è possibile dedurre che Carlo Crivelli all'epoca dei fatti era già attivo come pittore poiché era in grado di mantenere una donna in casa propria. Inoltre questa vicenda fu, probabilmente, la causa dell'allontanamento del pittore da Venezia. Da qui ha inizio la sua peregrinazione, sempre accompagnato dal fratello Vittore. Negli anni Sessanta del secolo si trasferisce a Zara, in Dalmazia, presumibilmente per seguire il pittore Giorgio Schiavone. Alla fine di questo decennio, invece, si sposta nelle Marche, operando in diverse località tra Fermo ed Ascoli Piceno, dove rimarrà fino alla fine della sua vita.
In questo territorio la sua carriera prende uno slancio rinnovato e numerosissime furono le commissioni: nel 1468 firma e data il polittico di Massa Fermana, due anni più tardi dipinge e data il Polittico di Porto San Giorgio, oggi smembrato e disperso in diversi musei[2]. I primi cinque anni marchigiani del Crivelli sono i più fecondi: nelle opere prodotte in questo periodo (dal Polittico di Massa Fermana a quello di Ascoli Piceno) elabora ed arricchisce di nuove modulazioni il suo raffinato ed accentuato linearismo. Nonostante ciò, il segno crivellesco è caratterizzato da un netto distacco dalla cultura classica. Per il Crivelli il riferimento costante all'antico non è essenziale, anche se certamente è un pittore conservatore e assolutamente non reazionario.
L'arte di Carlo Crivelli
Oltre all'accentuato linearismo l'arte del Crivelli si caratterizza per l'uso costante dell'oro nel fondo e della luce naturale quale valore di sintesi formale della composizione. Altro elemento degno di nota è lo studio dal vero, che trascende in un contesto fantastico, inducendo alcuni critici d'arte a parlare di effetto surreale o, addirittura, espressionismo[3].
Dal 1473 l'artista è ad Ascoli Piceno, come dimostra l'acquisto di una casa avvenuto nel 1478. In questi anni il Crivelli è mosso da una profonda irrequietezza che lo spinge ad operare in città e luoghi diversi per trovare nuove commissioni: inizia così il suo rapporto con Camerino, città culturalmente viva e per cui firma numerose tavole, tra cui il trittico per la Chiesa di San Domenico.
Negli anni Ottanta del XV secolo il Crivelli si divide tra Ascoli e Camerino.
Nel 1487 risulta nuovamente ad Ascoli al funerale del figlio, di cui non si conosce neppure il nome, ma dall'anno successivo risulta “commorante”, ossia abitante della città di Camerino.
Il 2 aprile 1490 il principe Ferdinando di Capua, futuro re Ferdinando II di Napoli, conferisce al Crivelli il titolo di “Miles”, accettandolo quale familiare a causa della sua “probitate”. Gli ultimi anni di vita del Crivelli lo vedono spostarsi frequentemente tra Fabriano, Matelica e Camerino.
È tuttora sconosciuta la data esatta della sua morte, comunque avvenuta dopo il 7 agosto 1494 e prima del settembre 1495, quando sicuramente non si trovava a Fermo[4].
Vicenda storico-critica del Trittico di Montefiore dell'Aso
Il Trittico di Montefiore dell'Aso, piccolo borgo collinare situato in provincia di Ascoli Piceno, è una tavola che rientra a pieno titolo nel cosiddetto “Caso Crivelli”, ovvero la vicenda, unica nella storia, di un pittore che nel momento stesso della sua riscoperta e valutazione critica veniva messo nelle condizioni di essere umiliato attraverso la dispersione delle sue opere[5]. Il Trittico conservato presso il Polo Museale di San Francesco[6] di Montefiore dell'Aso, infatti, è un assembramento arbitrario di parti di un polittico che sono collocate in collezioni geograficamente molto distanti tra di loro. Questo Polittico è forzatamente diventato Trittico: il Crivelli e la sua committenza, per lo più formata dagli ordini mendicanti della famiglia Francescana e Domenicana, amavano i grandi Polittici verticaleggianti di stampo gotico in cui inserire i grandi Santi francescani o domenicani. Originariamente, quindi, anche l'attuale Trittico era nato come Polittico commissionato dalla comunità francescana di Montefiore dell'Aso e destinato ad adornare la Chiesa di San Francesco, attualmente chiusa[7]. Venne eseguito poco dopo il 1470 e rimase nella sede originaria fino alla metà del XIX secolo quando numerosi pannelli vennero ceduti all'antiquario romano Vallati che, dal 1859 al 1862, li disperse fra diversi acquirenti. A tutt'oggi risultano smarriti tre pannelli della predella e uno dei santi a mezza figura della cimasa[8].
Il Trittico, oltre ad aver subito lo smembramento, è stato oggetto di numerose discussioni circa la sua paternità: la prima attribuzione al pittore veneziano Carlo Crivelli la si deve al Cantalamessa nel 1907, ma questa proposta non venne più presa in considerazione tanto da essere contestata dallo stesso Lionello Venturi. Ciononostante nel 1908 il Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione ne vietò la vendita con un apposito decreto. Negli anni successivi altri autorevoli critici ne disconobbero la paternità crivellesca: per citare un esempio, nel 1913 il Geiger assegnò l'opera a Vittore Crivelli, fratello di Carlo, o ad altro imitatore. Solo nel 1925 il Serra confermò l'originaria attribuzione del Cantalamessa. In seguito, nel 1932 e nel 1936, anche il Berenson assegnò l'opera al Crivelli riconoscendo però nell'esecuzione interventi di collaboratori.
L'opera venne definitivamente attribuita a Carlo Crivelli nel 1950 dal critico Pietro Zampetti, attribuzione approvata anche dal Pallucchini, riconoscendone l'altissima qualità.
Descrizione del Trittico
Nella facies attuale il Trittico presenta tre figure di santi a mezzo busto nell'ordine superiore e tre figure di santi ad altezza completa nel registro centrale.

Nelle cuspidi i soggetti rappresentati sono, da sinistra a destra, santo francescano, Santa Chiara d'Assisi e San Ludovico da Tolosa. Nel registro centrale, invece, sono rappresentati: Santa Caterina d'Alessandria, San Pietro Apostolo e Santa Maria Maddalena.

Il primo santo francescano del registro superiore è stato oggetto di un dibattito circa la sua identità. Alcuni appassionati studiosi hanno cercato di sciogliere questo enigma. Una delle tesi più accreditate è quella di da padre Silvano Bracci che ha ipotizzato si trattasse del Beato Giovanni Duns Scoto (Duns, 1266 – Colonia, 8 novembre 1308), identificazione provata per esclusione. Nel XV secolo, infatti, i Santi francescani erano: San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova, San Ludovica da Tolosa, San Bernardino da Siena, i Santi protomartiri dell'ordine e San Bonaventura. Analizzando i tratti iconografici del Santo in questione non vi è stata ravvisata una corrispondenza con il consueto lessico utilizzato dal Crivelli per rappresentare San Francesco, Sant'Antonio, San Bernardino o San Bonaventura. I tratti iconografici dei Santi, infatti, erano molto importanti nella pittura del Quattrocento: ogni artista era tenuto a rispettarli per garantire una precisa e chiara decodificazione da parte dei fedeli e, quindi, una corretta e agile lettura dell'opera. I tratti del misterioso santo francescano hanno condotto il Bracci ad identificarlo con il Beato Duns Scoto per numerosi riscontri positivi: “È un frate dai capelli neri, il che dice l'età non avanzata del personaggio, e con il copricapo dottorale in testa che costringe a pensare a un dottore universitario – ed infatti Duns Scoto era detto dottor sottile - … a questo punto la mente corre verso Giovanni Duns Scoto accolto molto giovane nell'Ordine francescano, dottore a Cambridge, Oxford, Parigi e Colonia, deceduto poco più che quarantenne l'8 novembre 1308” (Padre Silvano Bracci, 1997).
Il Beato Giovanni Duns Scoto è stato rappresentato in atto di leggere. La luce, che proviene da destra, illumina in pieno la figura del Beato creando una zona d'ombra nettamente definita al di sotto del libro aperto per poi ruotare intorno al suo volto accentuandone il valore plastico e la grande forza espressiva. Questa figura è una chiara prova del sapiente uso della luce di cui era capace Carlo Crivelli[9].

Accanto al Beato Giovanni Duns Scoto ed al centro del registro superiore vi è Santa Chiara d'Assisi (Assisi, 16 luglio 1194 – 11 agosto 1253), rappresentata con il saio nero e marrone dell'Ordine delle Clarisse, il giglio simbolo della purezza ed il libro della Sacra Scrittura. La Santa fondatrice delle Clarisse è caratterizzata da una sapiente modulazione delle linee curve su cui dolcemente scivola la luce[10].

Ultimo elemento del registro superiore è San Ludovico da Tolosa (Brignoles, febbraio 1274 – Tolosa, 19 agosto 1297), riconoscibile dal manto gigliato sulla tonaca francescana, decorata a rilievo. Rappresentato di profilo in abiti vescovili e con mitra sul capo: la mano destra è stata colta in atto benedicente e la sinistra poggiata sul bianco pastorale.
San Ludovico da Tolosa era figlio di Carlo d'Angiò, re di Napoli. Conobbe la spiritualità francescana quando fu fatto prigioniero presso il re d'Aragona. Una volta riacquistata la libertà rinunciò al trono per entrare nell'ordine serafico. Venne ordinato sacerdote nel 1296 e vescovo della diocesi di Tolosa l'anno successivo; morì dopo pochi mesi di malattia.
Santa Caterina d'Alessandria (III-IV secolo) è la prima figura a sinistra della predella. La santa, rappresentata a figura intera, reca i propri tratti iconografici: la ruota dentata, simbolo del miracolo avvenuto per suo tramite, e la palma, simbolo del suo martirio. L'eleganza lineare, l'opulenza decorativa e la sottile indagine psicologica sono i tratti distintivi di questa figura[11]. Santa Caterina è rappresentata con il viso leggermente rivolto verso il centro e con in testa la corona, simbolo, secondo la tradizione, della sua origine principesca. Indossa una lunga veste scura damascata che copre l'abito arricchito sul petto da motivi vegetali fantastici e fermato in vita da una fascia d'oro decorata al centro con un rubino. Secondo la tradizione agiografica, Santa Caterina d'Alessandria avrebbe subito il martirio all'inizio del IV secolo per essersi rifiutata di adorare le divinità pagane. L'imperatore Massenzio la condannò al supplizio della ruota dentata, ma la Santa, riuscita a scampare a questa sorte, venne decapitata. Al momento dell'uccisione, al posto del sangue, sgorgò latte.
Al centro c'è la figura di San Pietro Apostolo che si presenta in assoluta, arcaica frontalità caratterizzata da un'aspra modellatura a piani scheggiati. Il Santo è rappresentato in età avanzata con un libro chiuso in mano, probabilmente la Sacra Scrittura, ed il mazzo di chiavi, simbolo della sua autorità sulla Chiesa.
Ultima figura del registro centrale è Santa Maria Maddalena: l'impostazione di profilo della Santa ne esalta la tensione lineare e l'anticlassica eleganza che ci riporta ad una tipica figura di donna sacra e profana al tempo stesso[12]. Maria Maddalena è rappresentata di profilo, ma con lo sguardo rivolto verso lo spettatore. Nella mano destra reca un vaso, reso attraverso la semplice incisione della superficie dorata, mentre con la sinistra sostiene il manto rosso che copre tutta la parte inferiore del corpo della Santa, lasciando scoperto solo il piede calzato dal sandalo. L'abito presenta una fitta decorazione, tra cui è evidente la fenice. I capelli sono annodati sulla nuca con un nastro giallo e sciolti sulle spalle per evidenziare la condizione nubile della donna. La fronte della Santa è adornata da un diadema con al centro un rubino rosso.
Osservando attentamente il Trittico si nota come in basso la terminazione sia incompleta essendo privo di predella, inoltre le strutture lignee sono irregolari e combaciano male: le colonnine tortili centrali proseguono sbilenche sino alla sommità, mentre quelle laterali sono interrotte da capitelli. Questo dimostra lo smembramento dell'originario polittico a cinque scomparti con predella e di un ricongiungimento giustapposto nel Trittico del Polo Museale di San Francesco.
Nella sua esecuzione originaria il polittico comprendeva, secondo la ricostruzione proposta dalla critica a partire dallo studioso Pietro Zampetti, le seguenti figure secondo un ordine di lettura da sinistra a destra:
Predella:
- San Giovanni Evangelista, conservato presso l'Institute of Arts di Detroit a partire dal 1936;
- San Luca, conservato al National Trust in Upton House (Banbury) dal 1948;
- Apostolo con rotulo, conservato al National Trust in Upton House (Banbury);
- San Pietro Apostolo, conservato presso l'Institute of Arts di Detroit dal 1936;
- Cristo Benedicente, conservato presso lo Sterling and Francine Clark Art Insitute a Williamstown;
- Sant'Andrea, conservato presso l'Academy of Arts di Honolulu;
- Santo Apostolo, conservato presso l'Academy of Arts di Honolulu;
- Apostolo con rotulo, conservato presso la raccolta di R. Lehman a New York.
Registro centrale:
- Madonna con Bambino, in posizione centrale ed ora conservata nei Musées Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles. Questa tavola risulta firmata sul gradino del trono: “CAROLVS CRIVELLVS VENETVS PINSIT”. Nel 1862 è stata venduta dal Vallati al museo di Bruxelles.
- San Francesco, anch'esso conservato presso i Musées des Beaux-Arts des Bruxelles. Fu allargato lateralmente nel XIX secolo, senza pregiudicarne la severità strutturale. Secondo Federico Zeri la figura del San Francesco è ispirata a “moduli figurativi che, a un deciso verticalismo alla gotica, intrecciano snodi anatomici di linearità secca e quasi anchilosata” (Zeri, 1961).
Cuspidi:
- Pietà (Cristo morto sorretto da Angeli), tavola conservata presso la National Gallery di Londra e che costituiva il pannello centrale della cimasa. Anch'essa presenta la firma a sinistra: “CAROLVS CRIVELLUS PINSIT”, ma secondo il Davies si tratta di un'aggiunta ottocentesca seguita allo smembramento del polittico[13].

Note
[1]Pietro Zampetti (a cura di), Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze, 1986, p. 20
[2]Ibidem, pp. 11-12
[3]Anna Bovero (a cura di), L'opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano 1974, pp. 6-7
[4]Pietro Zampetti (a cura di), cit., pp. 11-12
[5]Pietro Zampetti (a cura di), cit., p. 22
[6]Il Polo Museale di San Francesco di Montefiore dell'Aso nasce nell'ex sede conventuale della comunità francescana, ormai non più presente nel borgo marchigiano a seguito della soppressione degli ordini monastici. Il vecchio convento è stato convertito in istituzione culturale a seguito del sisma del 1997 per conservare il patrimonio storico-artistico del territorio ed ospita, oltre alla Sala Carlo Crivelli, il Centro di documentazione scenografica “Giancarlo Basili”, il Museo “Adolfo De Carolis” e la Collezione “Domenico Cantatore”.
[7]Anna Bovero (a cura di), cit., p. 87
[8]Pietro Zampetti, Carlo Crivelli nelle Marche, Istituto Statale d'Arte, Urbino, 1952, pp. 26-27
[9]Ibidem, p. 28
[10]Anna Bovero (a cura di), cit., p. 87
[11]Ibidem
[12]Guido Perocco (testi di), Carlo Crivelli, Collana I maestri del colore, Fratelli Fabbri Editore, Milano, 1964, p. 6
[13]Anna Bovero, Idem, pp. 87-88
Bibliografia
Silvano Bracci, L'anonimo frate del polittico crivellesco di Montefiore dell'Aso, in Studia Picena, vol. 62, Ancona, 1997
Anna Bovero (a cura di), L'opera completa del Crivelli, Rizzoli Editore, Milano, 1974
Francesco De Carolis, La rappresentazione della santità tra realismo e devozione nel polittico di Montefiore dell'Aso di Carlo Crivelli, in “Venezia Arti”, Nuova Serie 1, vol. 28, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, Dicembre 2019
Luigi Lanzi, Storia pittorica della Italia dell'abate Luigi Lanzi antiquario della R. Corte in Toscana, a spese Remondini di Venezia, Bassano, 1795-1796
Guido Perocco (testi di), Carlo Crivelli, Collana I maestri del colore, Fratelli Fabbri Editore, Milano, 1964
Pietro Zampetti (a cura di), Carlo Crivelli, Nardini Editore, Firenze, 1986
Pietro Zampetti, Carlo Crivelli nelle Marche, Istituto Statale d'Arte, Urbino, 1952
Sitografia
www.regione.marche.it
IL MIC: LA CERAMICA DI FAENZA
A cura di Francesca Strada
Introduzione al MIC
«Ancorché di siffatti vasi e pitture si lavori in tutta Italia, le migliori terre e più belle sono quelle di Castel Durante e di Faenza che per lo più le migliori sono bianchissime e con poche pitture e quelle nel mezzo o intorno, ma vaghe e gentili affatto.» Così il Vasari descrive nelle Vite la produzione di maiolica di Faenza, la città delle ceramiche per antonomasia, dove nel 1908 venne fondato da Gaetano Ballardini il Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), che ospita la raccolta più grande al mondo: essa infatti racconta la storia della città e del Bel Paese dall’antichità al ‘900, arricchita anche da pregevoli collezioni orientali, europee, islamiche e precolombiane. In seguito ai bombardamenti del maggio 1944, il museo subì ingenti danni; tuttavia l’intervento di Ballardini permise la ricostruzione e l’ampliamento della raccolta. Il MIC è stato anche riconosciuto come “Monumento testimone di una cultura di pace” dall’UNESCO.
Faenza e il Medioevo
I primi reperti dell’arte ceramica faentina risalgono al Basso Medioevo: a dominare è il cosiddetto stile arcaico, caratterizzato da toni bruni e verdi e da motivi vegetali o faunistici, ma anche da una rilettura della classicità in chiave cortese, come testimoniato dal boccale con rappresentazioni di Filide e Aristotele, in cui la donna assume il ruolo di “signore” tipico della lirica trobadorica.

Il Rinascimento a Faenza
L’istoriato
Il Rinascimento è un momento di assoluto splendore per la città romagnola; in questo periodo si nota la fioritura di nuovi stili decorativi derivanti dal mondo bizantino, arabo e orientale; tuttavia, a giocare un ruolo fondamentale è la fitta rete di legami con Firenze e la Toscana, che porta a Faenza alcuni dei più grandi nomi del mondo dell’arte e influenza notevolmente la produzione ceramica. I motivi tipici del Rinascimento si inseriscono in breve nelle botteghe, andando a sostituire lo stile arcaico e dando impulso a una nuova era dell’arte faentina, che la renderà famosa a livello internazionale. Nasce l’istoriato, uno stile decorativo caratterizzato da figure umane appartenenti al mondo della corte, ma anche allegoriche; qui si inseriscono le “belle donne”: volti femminili, spesso di profilo, di cui il più celebre è sicuramente la Iulia Bela.
MIC: i Bianchi di Faenza
Dopo la metà del ‘500 ai vivaci colori dell’istoriato si sostituisce il candore dei “Bianchi di Faenza”; lo stile muta e con esso le forme e le figure che popolano i manufatti; amorini e grottesche dai toni gialli, aranciati e blu decorano le brillanti superfici decantate dal Vasari. Il protagonista di questa nuova tendenza è Virgilio Calamelli, ceramista locale la cui fiorente bottega farà da scuola per gli altri.
Il ‘700 a Faenza
Il gusto esotico che caratterizza il ‘700 si riflette anche nella manifattura faentina. La famiglia Ferniani domina la scena, fondendo i temi del Neoclassicismo, come la foglia di vite, alle decorazioni orientali, seguendo le mode europee. Uno dei simboli del periodo è il garofano, di cui verrà fatto largo uso a Faenza come testimoniano svariate opere tra cui la Zuppiera con decorazione al garofano.
L’Italia al MIC
Il MIC non si limita a raccogliere opere di pregio locali, ma predilige regalare al visitatore una visione completa della produzione italiana, mostrando reperti dei maggiori centri artistici del Paese. Quivi si può trovare la sontuosa vasca Farnese della fornace della famiglia Pompei in Abruzzo, della quale il museo conserva anche parti del corredo degli Orsini Colonna, come una fiasca e due albarelli.
Numerosi sono i reperti marchigiani, costituiti da manufatti prevalentemente istoriati provenienti da Urbino, Casteldurante e Pesaro, come lo spasimo di Niccolò Pellipario o il piatto dipinto con il carro di Marte. Del XVII secolo è invece la famosa Anfora Barberini.
Anche l’Umbria offre un vasto repertorio, proveniente da Gubbio e Deruta, prevalentemente dedicato a corredi da farmacia e grandi piatti da pompa, come testimoniano piatto da pompa con raffigurazione del re Giuda Maccabeo a cavallo o piatto da pompa con figura di “Bella”.
Il museo presenta un’opera di assoluta rarità, si tratta di un piatto in porcellana medicea, dipinta di blu su fondo bianco; con questa tecnica sono stati prodotti solamente 50 esemplari, tra cui quello in possesso del MIC. Quivi sono conservate anche svariate opere toscane provenienti da Montelupo e Siena, come L’albarello decorato a occhio di penna di pavone, una fiasca decorata a raffaellesche e ceramiche robbiane.
Dal nord Italia provengono svariate opere veneziane, lombarde e piemontesi dal Rinascimento al XIX secolo; tuttavia, da rimarcare è principalmente il repertorio proposto dalla Liguria, caratterizzato dall’istoriato barocco e la fusione di scene mitologiche ai gusti orientali: a guidare questa tendenza saranno i centri di Albissola Marina e Savona, arricchendo il patrimonio museale.
Il ‘900
Il XX secolo regala al MIC un numero vastissimo di opere sia italiane che internazionali. Quivi sono esposti alcuni dei nomi più noti del panorama novecentesco, come Lucio Fontana, Tullio D'Albissola e Carlo Zauli; tuttavia, a colpire il visitatore sarà sicuramente la storia delle opere di Picasso, Chagall e Matisse. In seguito alla distruzione del museo nel 1944, infatti, Gaetano Ballardini, il fondatore del museo, non si diede per vinto e, terminato il conflitto, ricostruì l’edificio. Intrecciò un rapporto epistolare con il celeberrimo pittore e scultore Pablo Picasso, al quale chiese di donare almeno una sua opera per contribuire al rifacimento del museo. Picasso non solo acconsentì, ma invitò Chagall e Matisse a compiere il medesimo gesto per supportare la causa di Ballardini.
MIC: oltre l'Europa
Al MIC è possibile uscire dall’Europa per pochi istanti, immergendosi in mondi lontani tramite le opere provenienti dall’Iran, dalla Spagna islamica, dall’Anatolia, dalla Siria e dall’Egitto; quella di Faenza è la raccolta d’arte ceramica islamica più corposa dello Stato. Si può ammirare anche una raccolta proveniente dall’estremo Oriente e dal Sud America. Tutto questo è stato reso possibile dalla forte personalità di Ballardini, il quale desiderava un museo che potesse essere da esempio per il mondo e che rendesse Faenza non solo un centro artistico italiano ma anche un punto di ritrovo per l’arte mondiale.
Sitografia
www.micfaenza.org/it/
BATTISTA ZELOTTI A VILLA EMO - PARTE II
A cura di Alice Casanova
Nel precedente articolo si è introdotta la figura di Giovan Battsita Zelotti, pittore manierista dallo stile scenografico, che dal 1564 al 1566 affrescò gli ambienti di Villa Emo a Fanzolo. Si è già parlato della Loggia e della Stanza di Giove ed Io, in questo articolo si percorreranno le restanti stanze.
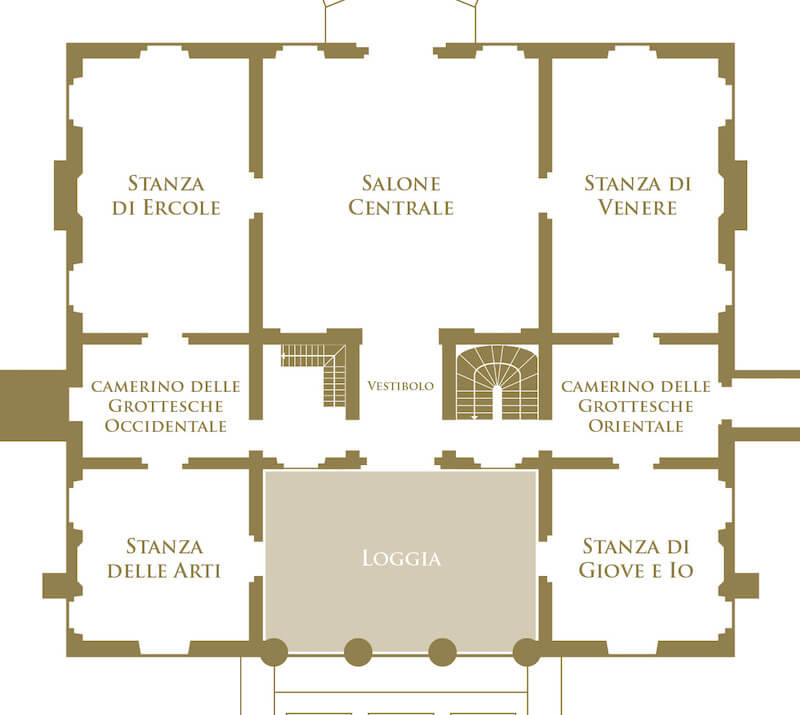
Precisazioni sulla scelta tematica degli affreschi di Zelotti
La Fig. 1 mostra come il corpo padronale della villa sia costituito da un asse centrale affiancato da due stanze per parte: a nord quelle di “Ercole” e di “Venere” a sud quelle delle “Arti” e quella di “Giove”. Già dalla disposizione si può intendere il fine del tema scelto dall’artista: nel salone centrale si vedrà come le raffigurazioni incitano alla virtù e alla generosità, mentre nelle altre sale si esaltano le arti liberali e si vogliono stigmatizzare le passioni umane. Come nella Stanza di Giove ed Io – vista nel precedente articolo – gli affreschi delle sale laterali riportano attraverso rappresentazioni quasi erotiche, episodi di trionfo del vizio accaduti a divinità pagane, affinché lo spettatore non ne segua l’esempio.
A tal proposito, scriveva il Palladio nella descrizione di un’altra villa veneta:
«…vi sono stanze, delle quali altre sono dedicate alla Continenza, altre alla Giustizia, et altre ad altre Virtù…il che è stato fatto affine che questo Gentil’huomo… possa alloggiare i suoi forestieri, et amici nella camera di quella Virtù, alla quale essi gli pareranno haver più inclinato l’animo» (1)
Nel Cinquecento, dunque, era scopo della villa, e più esattamene della villa rustica, cercare la virtù e conseguire la formazione della personalità morale seguendo una corretta condotta. Un’altra caratteristica che a partire dal ‘500 cambiò il ruolo della villa di campagna fu la presenza, sempre più diffusa nei trattati letterari del nord d’Italia, dell’idea che la vita di campagna e quella di città fossero diametralmente opposte: la città o la villa (2). Ma come mai ad un tratto la villa rustica assunse un tale grado di importanza? Questa che fino ad allora era stata una parte trascurabile della vita? La risposta risiede proprio nell’ingresso di Villa Emo. Appena entrati nella loggia a dare il benvenuto è Cerere, la dea dell’agricoltura, colei che insegnò all’uomo l’arte della coltivazione dei campi e che pose le prime leggi. La rivalutazione dell’agricoltura nei suoi aspetti etici e civili fece sì che venisse vista come un mezzo onorevole per ricavarsi il necessario per sopravvivere. Contrariamente agli altri sistemi di guadagno, infatti, la coltivazione non mette in pericolo la virtù e non danneggia gli interessi altrui, ma garantisce la pace fra gli uomini e nell’anima.

Ecco allora che la rinnovata visione per la villa di campagna comportò, anche nella decorazione, uno stile più maestoso e solenne, come dimostrano ad esempio le colonne ioniche o corinzie. Perché la villa era sì l’ambiente della coltivazione, ma anche e soprattutto luogo della cultura; Nella sua origine etimologica, la cultura era nel mondo latino un intervento materiale-lavorativo, ovvero la coltivazione dei campi, l’agri-coltura, una delle prime forme di cultura dell’umanità.
Battista Zelotti e la Stanza delle Arti

A differenza di tutte le altre sale, la stanza delle Arti è la sola a non presentare un tema tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, ma vi si incontrano sei allegorie delle Arti. A queste si uniscono le stagioni dell’Estate e dell’Inverno – posta, questa, “naturalmente” sopra il caminetto -, che chiudono il cerchio aperto nella stanza di Giove ed Io. Con la raffigurazione delle stagioni Zelotti non vuole tanto sottolineare lo scorrere del tempo, quanto più la ciclicità perenne con cui si svolge la vita sul nostro pianeta.
Le arti sono così ordinate: da sinistra, la Musica che suona il liuto, la Scultura intenta a scolpire, la Poesia con il capo coronato d'alloro, elemento che rimanda a Petrarca e Dante. A seguire la Pittura, intenta a dipingere la figura di un vecchio profeta, l'Astronomia, raffigurata mentre scruta il cielo con un compasso, e infine l'Architettura.
Quest’ultima allegoria tiene in mano un libro, forse I Quattro Libri dell'Architettura di Palladio, e la sua mano non solo indica la pianta di Villa Emo, ma punta precisamente la Stanza in cui l’osservatore si trova.
Altro elemento d’interesse è la rappresentazione simmetrica delle allegorie: ogni coppia è composta da una figura che osserva e studia la terra, l’altra il cielo.

Sopra la porta, dentro una finta struttura architettonica, lo Zelotti ha raffigurato un quadretto con la Sacra Famiglia, tema che corona ciò a cui questo ciclo intende alludere, ovvero l’educazione indispensabile ad ogni famiglia aristocratica. La nobiltà, infatti, si raggiungeva e si manteneva solo con l’educazione e l’elevazione dello spirito. Secondo lo storico Giuseppe Barbieri invece, il tema della Sacra Famiglia, o Natività, intende sottolineare «una dimensione fondativa, quasi un mito di origine del sistema delle arti, e quindi la remota, atemporale antichità delle pratiche della conoscenza», ma anche una certa impronta divina che caratterizza le Arti raffigurate. (3)

Il Salone Centrale: esempi di virtù
Il Salone della Villa è una stanza di pianta quadrata le cui pareti sono decorate con immagini tratte dalla raccolta di Exempla dello scrittore latino Valerio Massimo (I sec. a.C – I sec. d.C.) (4). Più precisamente, gli episodi rappresentati raccontano la Clemenza di Scipione nella parete orientale e il Sacrificio di Virginia in quella occidentale. Se la fonte a cui Zelotti attinge è sempre quella antica, ciò che ora cambia è invece il messaggio che viene trasmesso. Non si fa più riferimento alla forza e alla gloria, ma alla virtù e alla saggezza.
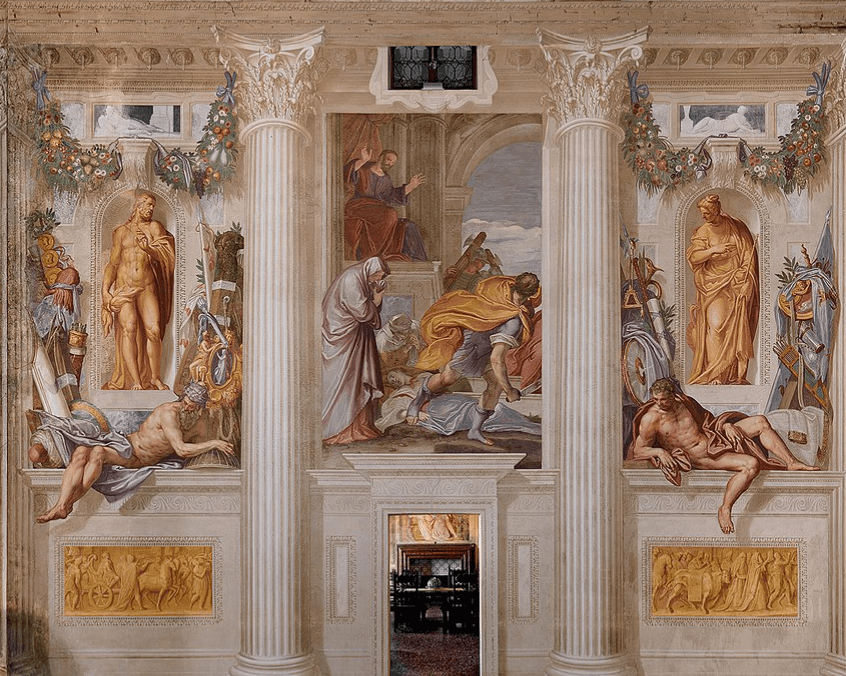
Nell’intercolumnio della parete orientale lo Zelotti raffigura l’attimo successivo all’uccisione di Virginia, giovane fanciulla che venne assassinata dal padre per conservarne la purezza e la libertà. Virginia è raffigurata sullo sfondo, sdraiata e pallida mentre viene accudita dal ricco patrizio che poco prima l’aveva chiesta in sposa. Si capisce che l’evento è appena accaduto in quanto in primo piano l’uccisore è immortalato in fuga e con ancora il coltello in mano.
I due intercolumni laterali presentano ognuno una finta nicchia con all’interno una divinità accompagnata dagli attributi che la contraddistinguono – a destra Giunone con il pavone, a sinistra Giove con la fiamma – in basso, vi sono figure di Prigioni circondate da armi deposte in segno di pace, o trofei di guerra. Queste due figure, che si trovano anche nella parete opposta, alludono alle vittorie della famiglia Emo contro i turchi, francesi e alemanni. I monocromi ocra che si trovano nello zoccolo illustrano invece Scene di trionfo. Secondo la storica Katia Brugnolo, tali cortei vedono protagonista Apollo, dio della Ragione e del Sole, protettore di ogni raccolto e traggono modello da bassorilievi antichi, come ad esempio la Processione sacrificale, scolpita su base d’altare al Museo Pio Clementino in Vaticano. (5)

Sulla parete opposta è raffigurato il tema della Clemenza di Scipione. La vicenda narra che dopo la conquista di Cartagine al condottiero Scipione venne offerta una fanciulla precedentemente catturata dai soldati romani. La ragazza era però già stata promessa in sposa al comandante delle truppe alleate a Cartagine, Aluccio, e fu per questo che Scipione la restituì al fidanzato e al padre di lei. Così come per il primo episodio, anche qui vi sono nei due intercolunni laterali due divinità: Nettuno accompagnato dal delfino e Cibele riconoscibile dalla leonessa. Questi ultimi due Dei completano il riferimento agli elementi naturali: Nettuno e Cibele alludono all’acqua e alla terra, mentre Giunone e Giove all’aria ed al fuoco.

Per quanto riguarda le altre due pareti della sala, si noti come entrambe presentano uno schema simile. Sulla parete meridionale spiccano sopra il timpano spezzato due figure femminili: l’allegoria della Prudenza, raffigurata mentre regge uno specchio in cui è riflessa la sua immagine, e l’allegoria della Pace che porta in una mano un ramo di ulivo e nell’altra una cornucopia. Ai lati delle due allegorie ci sono due monocromi violetti raffiguranti altrettanti episodi tratti dalle Metamorfosi: l’amore del dio Apollo per la ninfa Dafne (a sinistra) e la gara poetica tra Apollo e Pan (a destra). Sotto i monocromi, all’interno di nicchie a conchiglia sono rappresentati i busti ocra di Antonino Pio e Giulio Cesare. Allo stesso modo anche nella parete settentrionale vi sono altri due busti, quello di Ottaviano Augusto e quello di Pompeo Magno. Al centro stava probabilmente una finestra, occlusa per ospitare lo stemma della famiglia Emo.
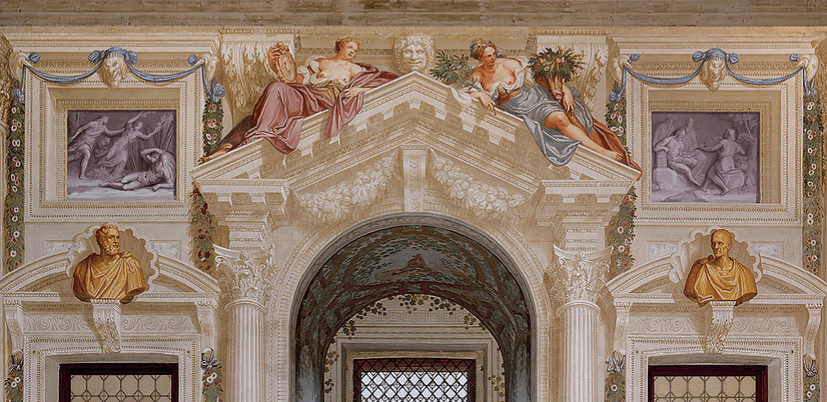
Per i molteplici e variopinti festoni con fiori e frutta che adornano la parte alta del Salone, così come anche le sale adiacenti, lo Zelotti sembra essersi ispirato alla Ghirlanda dipinta dal Maestro della Farnesina nella Casa della Farnesina (15 a.C – 40 d.C.)
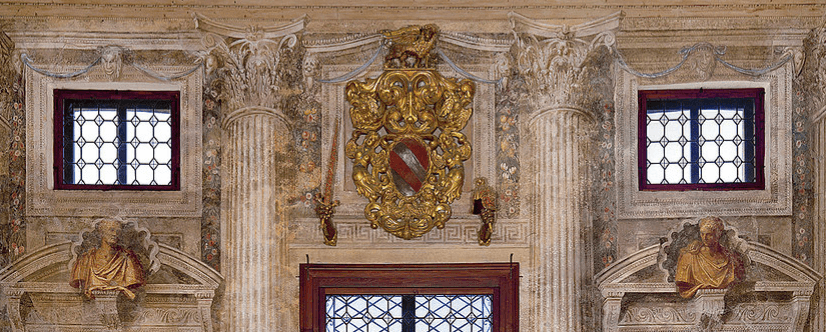
Gli elementi che caratterizzano la vita in villa sono dunque l’utilità, la pace, la libertà, la civiltà, e soprattutto l’etica. Questo nuovo fondamentale elemento è il fil rouge che lega tutti i racconti mitologici di villa Emo: il significato morale è la punizione della passione con le sue dolorose conseguenze.
Nella Stanza di Ercole, l’ultimo affresco – anche qui “naturalmente” posto sopra il caminetto - vede l’eroe tra le fiamme, in un rogo che lui stesso ha ordinato di accendere con l’intendo di porre fine ai propri dolori. Nella Stanza di Venere sta la morte di Adone, un giovane cacciatore del quale Venere si era innamorata. A nulla servirono le continue suppliche della dea della bellezza, perché Adone non andasse tra le belve feroci: fu infatti durante una battuta di caccia che l’amato venne ucciso da un cinghiale. Ed infine il sacrificio di Argo nel mito di Giove ed Io, accompagnato come nelle altre stanze da una sintesi tipologica e cristiana: nel mito di Giove ed Io vi è un parallelismo con l’Ecce homo, in quanto in entrambi i casi la salvezza si è ottenuta tramite un intervento divino. Nelle restanti sale si nota invece un’analogia tra il Noli me tangere, contrapposto alla “cupiditas” del centauro Nesso e un San Girolamo penitente associato al pianto di Venere. Una lezione quest’ultima, che deve esortare l’uomo al pentimento di fronte ad amori eccessivamente sensuali e un monito a non cedere all’impulso dei sensi.
Note
(1) Descrizione della Vila Repeta. Andrea Palladio, Libro II, Cap. XV, p.61.
(2) “Le vinti giornate dell’agricoltura et de piaceri della villa” (1567) del bresciano Agostino Gallo, la “Lettera in laude della villa” (1543) del ferrarese Alberto Lollio sono alcune delle molte opere che presentavano il meraviglioso mondo della vita in campagna, in contrapposizione a quello tetro e nebuloso della città. Anche Petrarca era giunto a una condanna della città, considerata da lui focolare delle passioni umane. Per questi autori la villa rustica era un paradiso, a confronto con l’inferno continuo della città, dove morale e salute erano costantemente in pericolo. RUPPRECHT B. L’iconologia nella villa veneta, Bollettino CISA, n. X, 234, 1968.
(3) BARBIERI G., Sui significati della decorazione di Battista Zelotti, in GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009, p. 58.
(4) La raccolta degli exempla di Valerio Massimo, intitolata Factorum et dictorum memorabilium libri, è un testo scritto intorno al 31 d.C. L’opera consiste in una serie di Esempi di modelli di vizi e di virtù, organizzati in libri ciascuno riguardante una specifica materia.
(5) BRUGNOLO K, Villa Emo: Il ciclo pittorico, l’apparato decorativo e il rapporto con l’antico, in GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009, 80
Bibliografia
GASPARINI D., PUPPI L., (a cura di) Villa Emo, Terra Ferma Antico Brolo, (Vedelago e Vicenza), 2009.
LOTTO A., Aspetti della committenza veneziana in riferimento all’opera di Battista Zelotti, Dottorato di Ricerca, Università Ca’ Foscari Venezia, Storia Antica e Archeologia. Storia dell’Arte, Anno Accademico 2006/2007 -2008/2009.
PALLUCCHINI R., Giambattista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo, Bollettino CISA, n. X, pp. 203 – 228, 1968.
PEDROCCO F., RUGOLO R., FAVILLA M., Gli Affreschi nei Palazzi e nelle Ville Venete, Sassi Editore, Schio (Vicenza), 2008.
RUPPRECHT B. L’iconologia nella villa veneta, Bollettino CISA, n. X, pp. 229 – 240, 1968.
Sitografia:
https://www.villaemo.org/la-pittura
https://www.marcadoc.com/villaemo/
CARLO SARTORI: “PITTORE DELLA NOSTRA TERRA”
A cura di Alessia Zeni
Introduzione
“Se mi si chiede: “Perché dipingi?” confesso che lì per lì mi sentirei imbarazzato. É più semplice se ci penso un po’… direi che quando posso dipingere sono felice, anche se soffro con me stesso. Potrei spiegarmi meglio ricordando il travaglio e la gioia della madre”[1]. Con queste semplici parole il pittore trentino Carlo Sartori descrisse il suo amore verso la pittura e l’arte in generale. Erroneamente etichettato come artista naïf, oggi la critica lo considera una personalità unica e originale nel panorama artistico del Novecento trentino.
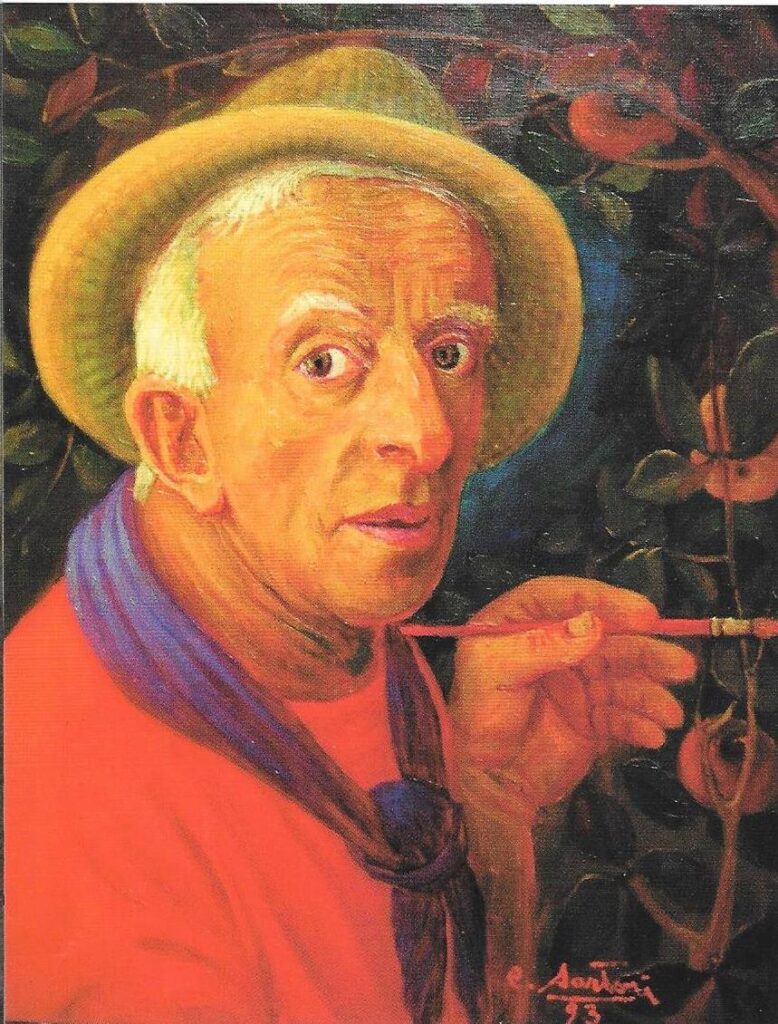
La vita di Carlo Sartori
Nato in una famiglia di umili origini a Ranzo di Vezzano, nella trentina Valle dei Laghi, il 27 maggio 1921, fin da piccolo mostrò una particolare predisposizione per il disegno che il poeta e scrittore trentino Renzo Francescotti così commentò: “Carlo è uno che si porta dietro da sempre la passione della pittura, come una malattia inguaribile”[2].
A causa dei problemi economici in cui versava la sua famiglia, in giovane età, si trasferì nelle Valli Giudicarie, nel Trentino occidentale, a S. Lorenzo in Banale e poi nella frazione di Godenzo-Poia, dove visse nelle tipiche case in legno e paglia dell’epoca. Nel 1934 la sua casa subì un furioso incendio e il piccolo Carlo, che allora aveva solo tredici anni, riuscì a salvare i suoi tre fratelli con i quali era rimasto solo. Il gesto fu talmente eroico e coraggioso che gli permise di ottenere la medaglia d’argento al valor civile, consegnata l’anno seguente a Roma dal Capo del Governo, Benito Mussolini, e la pubblicazione del suo nome sulla rivista “Il Balilla” nella sezione giovinezza eroica.

Questo singolare episodio incise sul carattere del giovane Sartori che si convinse di essere destinato ad un luminoso destino e ad inseguire il sogno di diventare un celebre pittore. Convinto di poter vivere della sua arte, riuscì in vita a vendere i suoi quadri a prezzi significativi, continuando inizialmente la sua attività di contadino, e poi di imbianchino. Le origini contadine, il carattere schivo, la passione per la natura e la libertà furono i temi che emersero nell’arte di Sartori, incentrata su soggetti bucolici e temi pastorali. Inoltre, nonostante la timidezza, egli ebbe anche una spiccata ironia che emerse nei suoi quadri, nei titoli ironici e nelle raffigurazioni di piccoli animali ammiccanti.
Nella formazione artistica di Carlo Sartori fu importante l’incontro con il pittore e decoratore girovago, nativo della Valle di Primiero, nel Trentino orientale, Grazioso Origher, dal quale apprese i materiali e le tecniche pittoriche, nonché i soggetti e lo stile. Un altro incontro cruciale fu con il pittore Matteo Tevini (Trento 1869-Torino 1946) che lo incoraggiò a studiare arte, rivelandogli i segreti “del saper vedere”, estraendo dal contesto masse, volumi e prospettive. In un secondo momento Sartori iniziò un percorso didattico per corrispondenza presso la scuola ABC di Torino e poi, sempre per corrispondenza, presso l’Istituto Volontà di Roma; da queste esperienze apprese il disegno e la decorazione pittorica. Sartori fu sicuramente un pittore autodidatta, ma la sua passione per l’arte lo portò a studiare parecchi manuali di pittura, testi di critica e di storia dell’arte, in particolare i grandi artisti del Trecento toscano. La sua poliedrica formazione è testimoniata dalle note, gli studi, gli schizzi e i cartoni preparatori che egli eseguì per ogni dipinto, conservati e catalogati oggi nella “Casa Museo” di Godenzo.
Infine sono da ricordare le mostre, personali e collettive, che contribuirono a diffondere la fama del pittore. La prima fu la collettiva del 1959 presso il Circolo della Stampa di Bolzano, seguita dalla personale allestita all’Hotel Miralago di Molveno nel 1960. Qui, raggiunto l’albergo con la corriera e le opere sotto braccio, appoggiando i dipinti su tavoli e sedie, riuscì a vendere tutte le sue opere, anche a prezzi elevati. Altre mostre personali e collettive seguirono negli anni, a Trento, Torbole sul Garda, Verona, Riva del Garda, Pavia, Bologna, Milano ed altre città. Fra queste esposizioni fu importante l’invito che ottenne nel 1977 alla “Rassegna di pittura e scultura” presso il Museo Nazionale della Arti Naives “Cesare Zavattini” di Luzzara a Reggio Emilia. Tale invito gli permise di ottenere, erroneamente, il titolo di pittore naïf e la partecipazione alle successive quattordici mostre collettive dedicate ai pittori riconducibili a tale stile. Le molte mostre a cui partecipò, sia a livello nazionale che internazionale, gli diedero una tale fama che spesso la domenica a Godenzo appassionati e curiosi venivano da tutta Italia per conoscere l’artista e comprare le sue opere.
In questo contesto è bene ricordare la prima personale allestita nel 2012 nelle sale del Palazzo Assessorile di Cles, in Valle di Non, dopo la morte di Carlo Sartori, avvenuta il 5 maggio 2010 alla soglia dei novant’anni. La mostra ”Carlo Sartori, il pittore della nostra terra” è stata la prima uscita pubblica della Fondazione “Casa Museo Pittore Carlo Sartori” di Godenzo, costituita nel 2011 al fine di custodire, diffondere e valorizzare il patrimonio artistico e le testimonianze lasciate dall’artista nella sua vita interamente dedicata alla pittura.
Il percorso formativo di un artista autodidatta “colto”
Carlo Sartori fu un artista poliedrico che sperimentò molte tecniche artistiche, dal disegno alla scultura, fino all’affresco e alla pittura su cavalletto. Quest’ultima fu protagonista nella produzione artistica di Sartori, incentrata sulla vita contadina e religiosa del mondo agreste trentino in cui visse, ma anche sugli autoritratti, i temi religiosi, come le crocifissioni, le nature morte e i ritratti familiari.
Prima di raggiungere la maturità artistica, il percorso formativo di Sartori potrebbe essere suddiviso in quattro periodi artistici. Il primo arco di tempo è quello che va dal 1952 al 1958 ed è caratterizzato da disegni e acquerelli che omaggiano i genitori, e da lavori ad olio su tela, masonite e faesite che rivelano un artista dilettante alla ricerca del suo mondo e del suo stile. Compaiono in questo periodo i primi autoritratti che saranno sempre presenti nel percorso artistico di Sartori, una sorta di lettura introspettiva che fa di se stesso.
Il secondo periodo che va dal 1959 al 1962, rappresenta la fase “cubista” del pittore. Un cubismo singolare e tardivo che dava poco interesse alla resa della solidità, alla scomposizione dei piani e alla tridimensionalità, capisaldi del cubismo internazionale. Questa risulta però una fase importante poiché incominciò ad affacciarsi alle sue tematiche, quella religiosa e quella contadina.

Il periodo seguente si rivela un periodo di studio che lo porterà a sperimentare il caratteristico “rosso sartoriano”, cifra stilistica della sua maturità artistica e che esploderà per la prima volta nel 1963 nella Crocifissione “Cristo che abbraccia l’umanità”. É un periodo di forte alternanza stilistica in cui Sartori si ispira al Van Gogh populista, della prima maniera, ad un tardo impressionismo, ai Macchiaioli (Fattori e Carrà) e ai Fauves.
L’ultima fase, che ha inizio nel 1970, è quella in cui raggiunge la piena maturità e il suo stile inconfondibile, da qui in poi comincerà a raccontare il suo mondo, la “grande saga contadina”. Nella piena maturità artistica Carlo Sartori realizzerà le sue opere più famose e caratteristiche, dove l’etichetta di artista naïf è ormai rifiutata dalla critica per parlare piuttosto di un artista che racconta il mondo contadino attraverso un “arcaico primitivismo”, studiato e pensato dall’artista nel suo percorso formativo da autodidatta “colto”[3].
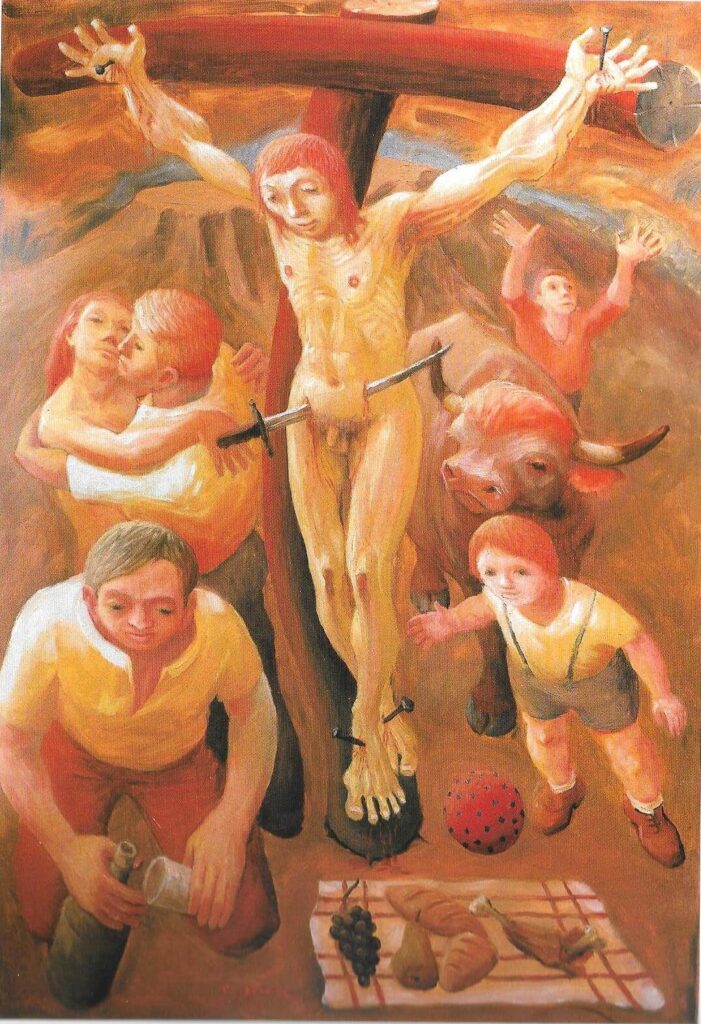
La maturità artistica di Carlo Sartori: la “grande saga contadina”
Osservando i quadri della piena maturità artistica di Sartori colpiscono i soggetti, le composizioni, la prospettiva schiacciata verso il centro, ma soprattutto l’incredibile timbro dei suoi quadri, il famoso “rosso sartoriano”, che pur rispettando i colori della tavolozza, avvolge il dipinto e suscita calore ed emozione. L’origine del “rosso sartoriano” è alquanto incerta. Il poeta e scrittore trentino Renzo Francescotti lo lega al drammatico episodio che visse da giovane, quando salvò i sui fratelli dal furioso incendio della casa di famiglia: “Vide negli occhi la morte di sé e dei fratellini in un rosso-giallo che tutto travolgeva”[4]. Potrebbe però essere spiegato anche con le parole dell’artista: “In quel periodo (fine del 1961) guardando ancora la pittura dei classici, ed in special modo il colore dei quattrocentisti, ho capito che il bianco non faceva quasi mai parte nell’impasto dei loro colori e così i quadri dei migliori autori avevano un tonalismo dorato color miele che legava tutto con meraviglia. Da allora ho dipinto escludendo quasi totalmente il bianco tranne nei punti dove dovevo far apparire oggetti che dovevano sembrare bianchi, componendo l’impasto della parte di luce colorata con colori caldi o freddi con pochissimo bianco e, per la necessità di schiarire certi colori, al posto del bianco usavo ocra chiara”[5].
Le sue opere raccontano di un mondo agreste abitato da contadini intenti nel loro quotidiano lavoro di pastori, boscaioli, carrettieri, vendemmiatori, seminatori, mietitori, falciatori, raccoglitori di patate, uccisori di maiali, muratori, maniscalchi, falegnami, calzolai, mugnai e molto altro ancora. Raccontano di lavoratori dediti alla siesta, alla vita religiosa, di contadini innamorati e anche di donne che partecipano alla vita contadina dei loro mariti, raccogliendo, guidando i buoi, spigolando o intente nel lavoro di lavandaie alla fontana. Nel raccontare la vita dei contadini, quest’ultimi vengono dipinti in corpi quasi deformi, bassi e tozzi, con teste scimmiesche e con mani e piedi grandi e callosi, quasi a voler sottolineare la fatica quotidiana che deforma il fisico. Immancabili nei quadri di Sartori sono gli animali – buoi, vacche, cavalli, capre, pecore, galline, cani e gatti – da lavoro e domestici, ma anche quelli selvatici quali uccelli, topi e lucertole. Uomini e animali vivono insieme e partecipano alla fatica del lavoro e all’intimità domestica, e spesso la loro presenza è ammiccante e ironica. Infine nei suoi quadri non mancano gli attrezzi del lavoro contadino, le case rustiche, i frutti prodotti dalla terra – patate, frumento e frutta – e le piante e i boschi. Il paesaggio che lui raffigura nei suoi quadri non rappresenta la terra natia, ma molto spesso raffigura alberi stilizzati ed irreali, nonché piante rade e scheletriche per le quali prese ispirazione dalla lezione di Giotto e dei pittori trecenteschi toscani.
Il tutto è raccontato in composizioni particolari con figure che sembrano schiacciate a terra e che si accalcano verso il centro; i soggetti sono rappresentati in una visione dall’alto con un effetto di schiacciamento verso il basso di tutti gli oggetti e di tutte le figure. Una visione quasi simbolica di un’umanità schiacciata a terra dalle fatiche del lavoro, ma che guarda verso l’alto, il cielo. Infatti non mancano nei suoi quadri frequenti gesti di preghiera, una costante nella vita contadina del tempo che chiedeva aiuto per sopravvivere. La componente religiosa è un elemento molto forte nei quadri di Carlo Sartori: una religiosità popolare che il pittore coglie mettendo i soggetti - piante e animali compresi - nella stessa posizione, in un mondo agreste paradisiaco.
Note
[1] Carlo Sartori, “Autopresentazione” in Catalogo della mostra collettiva “10+10. Pittori e incisori trentini del XX secolo”, Roma e Trento, 1971.
[2] Francescotti Renzo, “La saga contadina del pittore Carlo Sartori”, in Carlo Sartori. La saga contadina del pittore, p. 13.
[3] La pittura naïf è un genere di arte caratterizzata da semplici elementi, praticata da pittori non professionisti, autodidatti, attivi in America e in Europa, a partire dalla fine del sec. XIX. Inizialmente lo stesso Sartori accetterà questo tipo di definizione, ma in seguito questo tipo di etichetta non verrà più accolto dalla critica e dall’artista. Un artista naïf è estraneo allo studio della pittura, alla preparazione dei quadri con disegni e studi, ignora la prospettiva e ha un’abilità e un’ideologia che è del tutto estranea alla grande formazione artistica di Carlo Sartori.
[4] Francescotti, 2002, p. 18.
[5] Sartori Carlo, Protagonista della mia avventura, p.236.
Bibliografia
Rocca Gianluigi, Togni Alessandro, Carlo Sartori. La vita, la natura e il volto. Retrospettiva, Trento,
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, 2017.
Sartori Carlo, La mia vita, 2014.
Fedrizzi Camillo, Tamanini Nicoletta, Carlo Sartori. Il pittore della nostra terra. 1921-2010, Cles, Nitida Immagine, 2012.
Francescotti Renzo, Carlo Sartori. Le crocifissioni, Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas (S.A.S.S.) 23 Ottobre-1 Dicembre 2002, Trento, Nuove Arti Grafiche Artigianelli, 2002.
Sartori Carlo, La saga contadina del pittore Carlo Sartori, Trento , Artigianelli 1993.
Sitografia
www.carlosartori.info